Gian Maria Varanini
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
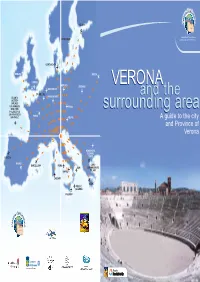
VERONA Surrounding Area VERONA Surrounding Area
Consorzio di Promozione e Commercializzazione Turistica VERONAVERONAand the surroundingsurroundingand the areaarea A guide to the city and Province of Verona TRAVEL DISTANCE BY Legend: MOTORWAY FROM VERONA TO: Trento km. 103 Fair Bolzano km. 157 Airport Vicenza km. 51 Venice km. 114 Lake Garda Brescia km. 68 Lessinia Milan km. 161 Bologna km. 142 Veronese Plain Florence km. 230 Soave Rome km. 460 Valpolicella Verona AFFI VERONA and the surrounding area A guide to the city and Province of Verona Verona Tuttintorno is proud to present the new edition of "Verona and the Surrounding Area - A Guide to the City and Province of Verona". The publication provides a general overview of the area's riches, and describes 30 fascinating itineraries to explore. The guide represents a collaborative effort between the Consortium and its members: travel agencies, hoteliers, restaurant owners, wineries, the Wine Road association, local government, transportation agencies, and tourist-sector service providers of every kind. The included itineraries offer a myriad of possibilities for enjoying the area's cultural riches, its nearby mountains, lake, and plain, getting and its world-famous enogastronomic traditions. Verona Tuttintorno, a consortium of businesses dedicated to promoting local tourism and the cultural, environmental, and enogastronomic to Verona patrimony of the City and Province of Verona, also offers up-to-date information and itinerary planning assistance for those wishing to make Verona and the surrounding area their next vacation destination. BY CAR BY TRAIN BY PLANE Enjoy Verona and the surrounding area!!! The A4 Motorway crosses the province Verona is served by the main train line The Valerio Catullo Airport, situated in of Verona from east to west. -

PAMÁTKOVÉHO SBORU Hll\V. MĚSTA PRAHY
- 80- 1353 a 1361 mezi konšely Starého Města a byl také držitelem r. 1361 domu za sv. Mikulášem v Zlaté ulici (č. 30). Jiný z příbuzenstva, Prokop (1364-1382), měl v držení od r. 1364 mimo jiné dvůr řečený Stenhof (Steinhof?), o němž dí Tomek (str. 457) »polohy nám neznámé«. PRAVY Máme tedy.u Benešovských jisté vztahy ku kostelu sv. Mikuláše a jeho. okolí. Erb s břevnem na děleném poli má Jan zvaný Železný, biskup litomyšlský, na PAMÁTKOVÉHO SBORU HLl\V. MĚSTA své biskupské pečeti z r. 1413 (Nejedlý; Dějiny města Litomyšle, Tab.), a erb ten nachází se při jeho osobě v Richentálově kronice koncilu kostnického. V tištěném vydání z r. 1483 jest kombinován se znakem biskupství litomyšlského (kříž zlatý PRAHY v černém poli). Znak označen jménem Dns Johannes episcopus liidinschionensis in Moravia (!). V kolorovaném exempláři universitní knihovny (XLE 24) jest břevno modré v bílém a černém poli j leč. tyto pigmenty nemusejí býti správny. Rovněž RAPPORTS DE LA COMM/SS/ON v Richentálovi vyobrazen znak Jana arcibiskupa Ostřihomského (Herr Johannes erzbischoff strigenensis nennt man von Oranen in Ungern) - křídlo s pazourem. POUR LA SAUVEGARDE DES MONUMENTS . Úloha, jakou hrál biskup Jan Železný. na koncilu kostnickém ave válkách husitských, jest s dostatek známá. Narodil se v Praze; dle mínění Sedláčkova po~ DE LA V/LLE DE PRAGUE. cházel, jak uvedeno, z rodu Beneschauerů j r. 1392 stal se biskupem litomyšlským, r. 1416 jmenován administratorem arcibiskupství Olomouckého a za válek husitských působí hlavně na Moravě. (tím. by vysvětlil se omyl u Richentála) a zdržuje se při POŘÁDAJÍ dvoře Sigmundově. Zemřel 9. -

Il Rinvenimento Del Ponte Postumio Nel 1891. Contributo Alla Ricerca Archivistica Delle Fonti Archeologiche (*)
ANDREA BRUGNOLI IL RINVENIMENTO DEL PONTE POSTUMIO NEL 1891. CONTRIBUTO ALLA RICERCA ARCHIVISTICA DELLE FONTI ARCHEOLOGICHE (*) ABSTRACT - Following a major flood in 1882 the course of the river Adige through Verona was altered by a flood prevention scheme which involved backfilling secondary channels and the construction of large stone embankments. During this project a number of archaeological discoveries were made, including evidence of a Roman bridge (the Postumio), which crossed the Adige at the northern end of the principle Roman road through the town (the decumano massimo). The planning department of Verona City Council produced accurate documentation of these findings including a number of drawings with appropriate levels, and a written report on the discovery of foundations and other elements of the Postumio. Most of this information has remained unpub- lished, and can now be reviewed and reconsidered as part of the present discussion of the Postumio’s structure and location. KEY WORDS - Roman Period, Verona, Postumio bridge. RIASSUNTO - In seguito all’alluvione del 1882 il tracciato dell’Adige all’interno di Verona venne ridefinito con l’interramento dei tratti secondari e la costruzione dei muraglioni. Questi interventi furono l’occasione di importanti scoperte archeologiche, tra cui il rinvenimento delle tracce del cosiddetto ponte Postumio, che attraversava l’Adige in prosecuzione del decumano massimo. L’ufficio tecnico del Comune di Vero- na produsse un’accurata documentazione che rimase sostanzialmente inedita. Alcuni disegni e una relazione relativa al ritrovamento delle fondazioni e di alcuni elementi del ponte Postumio, inviati alla Commissione Consultiva di Belle Arti e Antichità, sono tuttora conservati presso l’Archivio di Stato di Verona. -

Download E-Guide
Discover VERONA BY THE LOCALS Top 10 THINGS TO DO 1 ARENA & DETAILS Arena Amphitheatre, opening times: Tuesday-Sunday 8.30 am - 7.30 pm Monday 8.30 am - 7.30 pm (only June, July and September) PIAZZA BRA’ Ticket € 10,00 Opera Lyric Festival: starting at 9.00 pm only during summer (late June to late August) veryone knows about Colosseum in Rome, but he origin of the name of this square comes from E how many people know about Arena in Verona? Tthe Longobards’ word ‘braida’, which means ‘large’. This Roman theatre is still used, nowadays, for many Even if nowadays this is a very central place, in the performances and shows. With a circular shape this past it was mainly used for building works. On the Amphitheatre was originally composed by three rings; west side of the square there is the famous ‘Liston’, nowadays only one remained, and from the external which is represented by ‘700 Palaces with expensive circle just the ‘Ala’ (wing) is the original piece left; in restaurants or bars located under the arcades. This the following centuries the theatre has been renewed area became used as a square only from 1600 when many times due to maintenance. on the southern side Teatro Filarmonico was built, which is the closest indoor theatre of the area, located uring the Romans domination this monument just next to the big clock walls of Corso Porta Nuova. Dwas setting for games, ship battles and gladiators During winter this theatre hosts many classical music fights; in modern times, instead, the main purpose concerts, while Arena is setting for music shows, but became the Opera Lirica, which is set almost every not for the Opera. -

Historic Trail
VERONA, ITALY HISTORIC TRAIL VERONA, ITALY HISTORIC TRANSATLANTICTRAIL COUNCIL How to Use This Guide This Field Guide contains information on the Verona Historical Trail designed by Hiltrud Nupp of Troop 295 from Vicenza, Italy along with pictures from Bill Nupp in 2005. The guide is intended to be a starting point in your endeavor to learn about the history of the sites on the trail. Remember, this may be the only time your Scouts visit the Verona area in their life so make it a great time! While TAC tries to update these Field Guides when possible, it may be several years before the next revision. If you have comments or suggestions, please send them to [email protected] or post them on the TAC Nation Facebook Group Page at https://www.facebook.com/groups/27951084309/. This guide can be printed as a 5½ x 4¼ inch pamphlet or read on a tablet or smart phone. Front Cover Inset: Ponte della Pietra. Front Cover: Verona Skyline including the Lamberty Tower and the Adige River VERONA, ITALY 2 HISTORIC TRAIL Table of Contents Getting Prepared……………………… 4 What is the Historic Trail…………5 Historic Trail Route……………. 6-16 Trail Maps & Pictures.………. 17-19 Quick Quiz…………………………..…… 20 B.S.A. Requirements…………..…… 21 Notes……………………………..……22-23 VERONA, ITALY HISTORIC TRAIL 3 Getting Prepared Just like with any hike (or any activity in Scouting), the Historic Trail program starts with Being Prepared. 1. Review this Field Guide in detail. 2. Check local conditions and weather. 3. Study and Practice with the map and compass. -

I Ponti Romani
LIBRO_CETOP_1000.QXD 8/10/04 17:40 Página 9 2004 © Vittorio Galliazzo [email protected] http://www.traianvs.net/ I PONTI ROMANI Vittorio Galliazzo Arqueólogo Profesor de la Universidad de Venecia [email protected] Se l’architettura, in ultima analisi, è la continua loro storia trova sostanziale alimento proprio nelle vicen- 1 invenzione dell’abitare, cioè di porsi sulla terra e di vive- de del ponte stesso . re e pensare, i ponti, in particolare, mostrano di essere Ora fra tutte le città e i popoli civili, nessuno ha sentito una continua invenzione del collegare, anche se anch’es- come Roma, ‘città nata dal ponte’, la necessità di fare di si rientrano nella sfera del nostro abitare. diverse nazioni un’unica patria. Essa ha offerto ai popo- In realtà nessuna struttura architettonica ha avuto nella li vinti la civiltà, il diritto, collegando regioni e città del storia umana l’importanza del ponte nell’unire e mettere mondo antico con una fitta rete stradale, espressione in comunicazione fra loro popoli e civiltà: senza ponti le tangibile del processo di urbanizzazione e di romanizza- nazioni sarebbero separate, le città divise, i villaggi dis- zione del suo immenso impero: gangli vitali di questo persi; al contrario, con i ponti l’unione è garantita, i con- grandioso progetto furono i ponti urbani e stradali, ora tatti umani si sviluppano, i traffici commerciali sono di barche o navi, ora di legno, ora di muratura, ora ‘misti’ facilitati. Anzi è proprio il ponte che ha creato le condi- (cioè con ‘sottostruttura’ di muratura -

Your 2019 Vacation
ITALY YOUR 2019 VACATION Italy_Cover_2019_US.indd 1 03/09/2018 09:47 SIMPLY THE BEST WAY TO TRAVEL AS THE LEADERS IN TRAVEL SINCE 1947, YOU ARE GUARANTEED TO UNCOVER THE REAL SOUL OF ITALY WITHOUT HAVING TO WORRY ABOUT A THING. Real Connections No matter which trip you choose, you can be assured of a carefully handcra ed itinerary packed with unique Trafalgar highlights that will connect you to the real soul of Italy. You’ll see the iconic but also Connect With Locals who are proud to bring you into their homes, share their cultures and tell their tales. You’ll stay in places that are the fabric of the communities you visit and be 302 connected to unique Hidden Gems thanks to the depth HANDCRAFTED TRIPS and knowledge of your Trafalgar team. Read more p.6 711 80+ COUNTRIES AWARDS Real Ease THE You choose the destination and your itinerary, and we WORLD LEADERS take care of the rest. You will experience the real Italy IN TRAVEL without worrying about a thing. You’ll feel the freedom FOR 72 YEARS to just be, to be in the moment, to be truly connected. It’s Trafalgar’s 72 years of travel expertize, and the very 5 best on-road teams that guarantees you will enjoy 7 MILLION CONTINENTS HAPPY GUESTS simply the best vacation. & COUNTING Read more p.10 Real Joy It might be a minute, an hour, a day; it’s that feeling of pure joy that’s found in a ‘pinch me’ moment you didn’t expect. -

9781908984807 Extract.Pdf
Copyright © Michael Garner, 2018 The right of Michael Garner to be identified as the author of this book has been asserted in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. First published in 2018 by Infinite Ideas Limited www.infideas.com All rights reserved. Except for the quotation of small passages for the purposes of criticism or review, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise, except under the terms of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 or under the terms of a licence issued by the Copyright Licensing Agency Ltd, 90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP, UK, without the permission in writing of the publisher. Requests to the publisher should be emailed to the Permissions Department, [email protected]. A CIP catalogue record for this book is available from the British Library ISBN 978–1–908984–69–2 Brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. All web addresses were checked and correct at time of going to press. Front cover photo courtesy of LOOK Die Bildagentur der Fotografen GmbH / Alamy Stock Photo. Back cover photos (top left and bottom) Charley Fazio / Consorzio Tutela Vini Soave; (top middle) © Archivi Masi; (top right) Consorzio Tutela Vini Valpolicella. Maps and illustrations adapted and drawn by Nicki Averill. Source map of Soave courtesy of Consorzio Tutela Vini Soave. Source maps of Valpolicella courtesy of Consorzio Tutela Vini Valpolicella. Colour plate pages 1, 2, 3 (top) and 4 (top) courtesy of Charley Fazio/Consorzio Tutela Vini Soave; 3 (bottom) and 4 (bottom) courtesy of Marco Malvezzi/Consorzio Tutela Vino Lessini Durello DOC; 5 (top) courtesy of Mario Lonardi; 7 (bottom) courtesy of Giampaolo Speri; 5 (bottom) and 7 (top) © Archivi Masi; 6 and 8 courtesy of Consorzio Tutela Vini Valpolicella. -

CHIOGGIA Venice’S Seventh District and Gateway to Italian History Presenta�On by Hugo Trumpy & Trumpy Tours
CHIOGGIA Venice’s Seventh District and gateway to italian history Presentaon by Hugo Trumpy & Trumpy Tours 1 Contents • Chioggia – The port - Local and Connecons page 3 - Venice Chioggia: The Distance 4 - The Entrance 5 - Isola Saloni 6 - Isola Saloni 7 - Terminal Grand Opening 8 • Chioggia – The City - History 9 - Ars7c Tour 10 - Acvi7es, excursions and beaches 11 • What to see in the sorroundings of Chioggia 12 – Mantova 13 – Ferrara 15 – Ravenna 17 – Verona 19 – Padova 21 • Typical Products - Food and Wine 24 • Contacts and References 25 2 Chioggia – The Port Strategically Located in the Venean Lagoon • Chioggia is on a small island in the southern part of the Venean Lagoon. • It's in the Veneto region on Italy's east coast, about 25 km south of Venice (50 km by road). • The Laguna del Lusenzo seperates the town of Chioggia from the Soomarina beaches on the Adriac sea. • The nearest internaonal airports are Venice, only 60 Km from Chioggia, and Treviso (80 Km). • The port of Chioggia is connected to the transalpine naonal and internaonal highway’s net, this allows the goods to reach easily the areas of North Italy and Central Europe. • Venice is only 12 miles away by boat 3 Chioggia – The port Venice Chioggia : The Distance Venice and Chioggia are very close, the distance between the two ports is only 12 Miles 4 Chioggia – The Port Infrastructures and port services Entrance Port of Chioggia - Lat. : 45° 13' 31" N - Long. : 12° 17' 23" E - UN/LOCODE : ITCHI - Port Type : Harbor 5 Chioggia – The Port Cruise Terminal facilies “Isola Saloni” • Chioggia Cruise Terminal was recently built in order to easily accomodate thousands of embarking and disembarking passengers in total comfort, thanks to different areas for check in and security procedures, a spacious waing room and a very large hall, where baggage claim is efficiently arranged • The port of call Isola Saloni is located inside the city, has a draught of 8 metres and takes a surface of about 100.000 mq, with over 1500 mq of covered surface developed on three levels. -

River Navigation from the Adige to the Po in Shakespeare's Italy
Catching the Flood: River Navigation from the Adige to the Po in Shakespeare’s Italy by Catherine Hatinguais Lance, away, away! Aboard! Thy master is shipped, and thou art to post after with oars. What’s the matter? Why weep’st thou, man? Away, ass, you’ll lose the tide, if you tarry any longer. (…) Tut, man, I mean thou’lt lose the flood, and, in losing the flood, lose thy voyage, and, in losing thy voyage, lose thy master, and, in losing thy master, lose thy service, and, in losing thy service— The Two Gentlemen of Verona (II.3.31–34, 39–42) antino’s outburst in Act II scene 3 of The Two Gentlemen of Verona, where he scolds Lance for missing the boat taking Proteus from Verona to Milan, has often been cited by Stratfordian commentators, P 1 from Sidney Lee in 1907 to Andrew Dickson in 2016 as a “geographical howler” (Dickson’s words), evidence of Shakespeare’s ignorance of Italy. Both cities are landlocked and it is therefore ludicrous to have characters in the play sailing from one to the other—and there are no tides in Verona! When confronted with the conclusions of other researchers,2 who have shown that Shakespeare must have known the country first-hand and been aware of the prevalence of river navigation in Northern Italy, orthodox com- mentators change tack and dismiss those findings as irrelevant and superflu- THE OXFORDIAN Volume 21 2019 95 Catching the Flood: River Navigation from the Adige to the Po ous since Shakespeare’s Italy is purely imaginary anyway, a setting adopted for “mere creative convenience” (Dickson). -

I Ponti Romani
© Vittorio Galliazzo http://www.traianvs.net/ _______________________________________________________________________________________ I PONTI ROMANI Publicado en: Elementos de Ingeniería Romana. Congreso Europeo "Las Obras Públicas Romanas". Tarragona, 2004 Vittorio Galliazzo © 2004 TRAIANVS © 2004 Se l’architettura, in ultima analisi, è la continua invenzione dell’abitare, cioè di porsi sulla terra e di vivere e pensare, i ponti, in particolare, mostrano di essere una continua invenzione del collegare, anche se anch’essi rientrano nella sfera del nostro abitare. In realtà nessuna struttura architettonica ha avuto nella storia umana l’importanza del ponte nell’unire e mettere in comunicazione fra loro popoli e civiltà: senza ponti le nazioni sarebbero separate, le città divise, i villaggi dispersi; al contrario, con i ponti l’unione è garantita, i contatti umani si sviluppano, i traffici commerciali sono facilitati. Anzi è proprio il ponte che ha creato le condizioni per cui semplici villaggi di pastori o pescatori sono divenuti città o capitali di grandi nazioni: Roma, Parigi, Venezia, Verona, Firenze, Mérida, Magonza, Colonia, Londra e tante altre città d’Europa e del mondo abitato sono centri urbani ‘nati dal ponte’ (o comunque da una struttura di attraversamento di un corso d’acqua) e la loro storia trova sostanziale alimento proprio nelle vicende del ponte stesso1. Ora fra tutte le città e i popoli civili, nessuno ha sentito come Roma, ‘città nata dal ponte’, la necessità di fare di diverse nazioni un’unica patria. Essa ha offerto -

Introduction Controlling a Ford on the Adige River, an Obligatory Point Of
VERONA Introduction Controlling a ford on the Adige river, an obligatory point of passage between East and West, Verona, already occupied in pre-Roman times, was one of the main cities in the Veneto area. A colony under Latin law in 89 B.C., then a Roman municipium in 49 B.C., the city was occupied by Vespasian during the civil war against Vitellius, in 69, and later by Maxentius during that against Constantine, in 312. Later, due to its strategic position, Verona maintained for a long time its importance. The most famous ancient monument of Verona is its amphitheatre, where both gladiator games and hunting shows were held. Despite its name, the amphitheatre is not the simple collage of two theatres, nor the product of empirical research: a rigorous geometric study had demonstrated the superiority of the elliptical plan, both in terms of circulation and vision of the spectacle given in the “arena”, a name derived from the Latin name of the sand which absorbed the blood of men and beasts. History On the river Adige side, access to the city was facilitated by two Roman bridges, one of which, Ponte Pietra, dating back to the 1st century BC, still preserves two arches of its original structure. Of the ancient city walls, dating back to the Republican period, but restored by Emperor Gallienus in 265, Verona has preserved four gates, the most monumental of which, to the west, at the end of the decumanus maximus, is Porta Borsari: dated, in its current state, to the Julio-Claudian period, despite bearing an inscription relating to Gallienus, dated 265; its two arches are flanked by fluted Corinthian columns supporting the tympanum.