Il Paesaggio Destra Del T
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Valutazione Ambientale Del Piano Di Sviluppo 2011
Valutazione Ambientale del Piano di Sviluppo 2011 Rapporto Ambientale Volume Regione LIGURIA INDICE 1 Introduzione 4 3.3 Paesaggio e beni culturali, architettonici, monumentali e archeologici 13 1.1 Struttura del rapporto regionale 4 3.3.1 Siti UNESCO 13 1.2 Modalità di collaborazione attivate per la VAS 4 4 Contesto Economico 14 1.3 Fonti dati disponibili 4 5 Contesto Tecnico 15 2 Contesto Ambientale 5 5.1 Pianificazione energetica regionale 15 2.1 Caratterizzazione geografica 5 5.2 Stato della rete di trasmissione nazionale nell’area 2.2 Biodiversità ed aree protette 5 del Nord Ovest d’Italia 15 2.2.1 Aree naturali protette 5 6 Interventi 17 2.2.2 Rete Natura 2000 6 2.2.3 Aree Ramsar 9 6.1 Nuove esigenze 17 2.3 Assetto del territorio 9 6.2 Interventi presenti in Piani precedenti già approvati 31 2.4 Pianificazione territoriale 10 6.3 Sintesi degli indicatori regionali 33 3 Contesto Sociale 12 3.1 Demografia 12 3.2 Uso del suolo 12 Indice | 3 1 Introduzione dell’economia regionale, anche in relazione a 1.1 Struttura del rapporto regionale dati nazionali; − Il Rapporto Regionale relativo al Piano di Sviluppo Contesto Tecnico, che descrive lo stato della rete (PdS) 2011 riporta i principali interventi previsti, a livello regionale; suddivisi tra interventi in corso di concertazione, da − Interventi, che sono oggetto della VAS, proposti avviare alla concertazione, privi di potenziali effetti sul territorio regionale. significativi sull’ambiente, al di fuori dell’ambito VAS (in fase autorizzativa, autorizzati, in 1.2 Modalità di collaborazione attivate per la realizzazione, ecc.). -

Studio Incidenza PUC Genova Corretto PARTE I
COMUNE DI GENOVA PIANO URBANISTICO COMUNALE Progetto Preliminare STUDIO DI INCIDENZA GE N OVA DIREZIONE SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO Elaborazione: - Settore Urban Lab e Attuazione Progetti di Area Portuale - Settore Pianificazione Urbanistica - Ufficio Geologico - Settore Approvazione Progetti e Controllo Attivita' Edilizia - Ufficio Gis e Sviluppo Interno e Georeferenzialita'. Piano Urbanistico del Comune di Genova Studio di incidenza Parte I nell’ambito della procedura per la valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della L.R. 28/2009 giugno 2011 Alessandra Di Turi 3 INTRODUZIONE Il documento che segue costituisce lo studio di incidenza relativo al Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Genova, stilato sulla base delle funzioni ammesse dalle Norme di Piano aggiornate al 13/12/2010 all'interno delle aree SIC e ZPS che insistono sul territorio comunale. Nella fattispecie il PUC coinvolge interamente o parzialmente sei SIC terrestri due marini e una ZPS, in ordine di codice: SIC IT1331402 BEIGUA - M. DENTE - GARGASSA - PAVAGLIONE SIC IT1331501 PRAGLIA - PRACABAN - M. LECO - P. MARTIN SIC IT1331606 TORRE QUEZZI SIC IT1331615 M. GAZZO SIC IT1331718 M. FASCE SIC IT1331721 VAL NOCI -TORRENTE GEIRATO - ALPESISA ZPS IT1331578 BEIGUA - TURCHINO SIC IT 1332575 FONDALI NERVI SORI SIC IT 1332576 FONDALI BOCCADASSE - NERVI Lo studio è redatto sulla base della normativa nazionale vigente (DPR 357/1997, modificato dal DPR 120/2003), in conformità ai criteri approvati dalla Regione Liguria con la DGR 328/2006 "Approvazione di criteri e di indirizzi procedurali ad oggetto l'applicazione della Valutazione di Incidenza - sostituzione DGR 646/2001" e con riferimento alla Legge Regionale 28/2009 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”. -

Escursionismo 2018
CAI Asti - ESCURSIONISMO 2018 14 gennaio (Escursionismo) Varigotti - Le Manie - Varigotti Liguria Difficoltà: E Partenza/arrivo: Varigotti Dislivello salita/discesa: m 300 Tempo complessivo: h 3.30 Capigita: V. Amerio (AE), G. Bolgiani (ASE) Sentiero balcone ad anello, sospeso sul mare tra Noli e Finale. L’Altopiano delle Manie è un piccolo paradiso protetto, su cui si dipana una fitta rete di sentieri nella macchia, da percorrere a piedi. Sul mare, antiche torri saracene fanno da sentinelle a graziosi borghi. 11 febbraio (Escursionismo) Rapallo - Montallegro - Chiavari Liguria Difficoltà: E Partenza: Rapallo Arrivo: Chiavari Dislivello salita/discesa: m 612 Tempo salita: h 1.30/2; discesa: h 2.30/3 Capigita: M. Gai, B. Perosino Il percorso della gita segue lo spartiacque fra la linea di costa e la Val Fontanabuona, con vista mare presente per quasi tutto l’itinerario. Da Rapallo si percorre l’antica mulattiera lunga 3.850 metri, che dalla Chiesa di San Francesco, conduce alla sommità del Monte Leto (m 612). Da qui si scende lungo la dorsale fino all’abitato di Chiavari. 4 marzo (Escursionismo) Monte Bignone (m 1299) Liguria Difficoltà: T, E Partenza/arrivo: Verezzo di Sanremo Dislivello: m 850 Tempo complessivo: h 5.15 Capigita: C. Dirita (AE), U. Ughini (AE) Giro ad anello da Sanremo (frazione a m 290), sale per il Monte Colma e discende per la strada forestale, passando tra ville, giardini e coltivazioni floricole, santuari, ma anche siti archeologici del periodo preromanico (circa IV-V secolo a.C.) e, immancabili, eccezionali panorami sul mare e sull’entroterra sanremese. Saranno possibili anche mete intermedie. -

GITE SOCIALI GRUPPO SENIORES CAI Sezione Ligure
GITE SOCIALI GRUPPO SENIORES CAI Sezione Ligure Anno 2021 META REFERENTI RIFERIMENTO DOCUMENTAZIONE Marzo 1 Gio 4 Anello S.Cosimo di Struppa‐S.Martino‐Monte Piano‐Alpe Sisa‐ http://www.maurizioweb.it/montagna/liguria/alpesisa/index.php Seniores Gola di Sisa‐S.Cosimo Guiglia ‐ Auto Periferia Nord di Genova Andreani E ‐ Disl.: mt. 800 circa ‐ Tempo cammino: 6:00 h circa 2 Gio 4 Ciaspolata Seniores Appennino Ligure ‐ Val Trebbia Aquila ‐ Negrini * L'escursione può essere programmata, a discrezione del Consiglio Seniores, in alternativa o in aggiunta alla Auto Bavastrelli ‐ Monte Antola e ritorno Oliveri gita principale fissata per la stessa data; inoltre la meta puo' essere cambiata in base alle condizioni meteo e EAI ‐ circa mt. 700 della neve attingendo fra quelle elencate in ultima pagina 3 Gio 11 Crevari ‐ anello Monte Pennone ‐ Crevari Seniores Periferia Ponente di Genova Cardini ‐ Negrini Da Crevari col segnavia"X rossa"fino a poco sotto al M. Tardia di ponente, su cui si arriva su buona traccia non Auto e/o E ‐ Disl.: mt. 600 circa ‐ Tempo di cammino: 6h circa ‐ Lungh.: Km. 12 circa segnata. Ritorno a Crevari in buona parte sullo stesso sentiero, il monte Pennone viene però superato da sud. Mezzi Urbani Partenza da Crevari ‐ Treno Arenzano ‐ Voltri 4 Gio 11 Ciaspolata http://www.rifugiocasermettedelpenna.com/escursioni.html Seniores Santo Stefano d'Aveto Aquila ‐ Cardini * L'escursione può essere programmata, a discrezione del Consiglio Seniores, in alternativa o in aggiunta alla Auto Anello del Monte Penna con salita al Monte Trevine Oliveri gita principale fissata per la stessa data; inoltre la meta puo' essere cambiata in base alle condizioni meteo e EAI ‐ circa mt. -

SISTEMI TERRITORIALI - Documenti a Corredo - Settore Approvazione Progetti E Controllo Attivita' Edilizia - Ufficio Gis E Sviluppo Interno E Georeferenzialita'
COMUNE DI GENOVA PIANO URBANISTICO COMUNALE Progetto Preliminare Allegato GE N OVA DIREZIONE SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO Elaborazione: - Settore Urban Lab e Attuazione Progetti di Area Portuale - Settore Pianificazione Urbanistica - Ufficio Geologico SISTEMI TERRITORIALI - Documenti a corredo - Settore Approvazione Progetti e Controllo Attivita' Edilizia - Ufficio Gis e Sviluppo Interno e Georeferenzialita'. SISTEMI TERRITORIALI Dal Documento degli Obiettivi: “Tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle condizioni ambientali fra centro urbano e territorio esterno, della necessità di risarcire alcune porzioni di territorio segnato da condizioni di degrado ambientale o di dissesto idrogeologico nonché di valorizzarne gli aspetti legati all’identità locale, sono stati individuati alcuni sistemi territoriali. Per lo più si tratta di territori con una forte identità e che in passato hanno svolto un loro ruolo significativo nell’economia locale che si espletava lungo l’asse mare-monti. Da quando si è scelto di costruire la grande Genova l’asse della struttura economica è ruotato e le reti di relazioni si sono concentrate prevalentemente sull’asse costiero con conseguente disequilibrio degli antichi rapporti con il centro cittadino. La proposta al territorio è quella di valutare la possibilità di una disciplina finalizzata a consentire un meccanismo di perequazione urbanistica tra gli interventi previsti nel tessuto urbano e le possibili ricadute sull’entroterra. In questi sistemi territoriali potranno essere utilizzati fondi e finanziamenti previsti dai programmi europei, nazionali e regionali, interventi da prevedere nel programma dei lavori pubblici e oneri di urbanizzazione; saranno inoltre specificatamente attivate politiche di difesa idrogeologica del territorio e di sviluppo di produzione di energia da fonti alternative. Gli sviluppi pianificatori conseguenti si pongono in coerenza con la Descrizione Fondativa nonché con gli Obiettivi di piano. -

Commission Implementing Decision
15.2.2021 EN Offi cial Jour nal of the European Union L 51/187 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2021/159 of 21 January 2021 adopting the fourteenth update of the list of sites of Community importance for the Mediterranean biogeographical region (notified under document C(2021) 19) THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (1), and in particular the third subparagraph of Article 4(2) thereof, Whereas: (1) The Mediterranean biogeographical region referred to in Article 1(c)(iii) of Directive 92/43/EEC comprises the Union territories of Greece, Cyprus, in accordance with Article 1 of Protocol No 10 of the 2003 Act of Accession, and Malta, parts of the Union territories of Spain, France, Italy, Portugal and Croatia, and, in accordance with Article 355(3) of the Treaty, the territory of Gibraltar, for which the United Kingdom is responsible for external relations, as specified in the biogeographical map approved on 20 April 2005 by the committee set up by Article 20 of that Directive (the ‘Habitats Committee’). (2) The initial list of sites of Community importance for the Mediterranean biogeographical region, within the meaning of Directive 92/43/EEC, was adopted by Commission Decision 2006/613/EC (2). That list was last updated by Commission Implementing Decision (EU) 2020/96 (3). (3) The sites included in the lists of Community importance for the Mediterranean biogeographical region form part of the Natura 2000 network which is an essential element of the protection of biodiversity in the Union. -
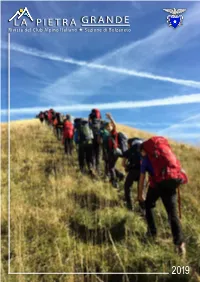
Pietragrande La
LA PIETRA GRANDE Rivista del Club Alpino Italiano « Sezione di Bolzaneto 2019 LA PIETRA GRANDE RIVISTA DEL CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di BOLZANETO Via C. Reta 16r - Tel. e Fax 010.740.61.04 - 16162 Genova Da Bologna a Santiago de Compostela....50 www.caibolzaneto.it - [email protected] di Giorgio Trotter Apertura Sede e tesseramento: giovedì ore 21 Api e Vale sull’Alta Via dei Monti Liguri.....52 di Franco Api e Valentina Vinci Un’esperienza di vita...............................54 LA PIETRA GRANDE Rivista del Club Alpino Italiano « Sezione di Bolzaneto di Stefano Camarda Cos’è Alvi Trail?.........................................56 Sommario di Marzia Gelai Capodanno in solitaria notturna..............57 di Marco Ferrando Trek in Portogallo dalla A alla Z...............60 CAI SEZIONE di BOLZANETO.......................2 di Sabrina Poggi e Michela Repetto Il socio agente del corretto rapporto con la Sulla Cima di Nasta..................................64 montagna.................................................3 di Bruna Carrossino di Nadia Benzi CULTURA.............................................68 Anno XII • Numero 12 2019 ALPINISMO.........................................5 Monte Carmo, storia di una croce di La Montagna si sconta... salendo..............5 vetta......................................................68 di Salvatore Gabbe Gargioni di Pietro Pitter Guglieri In copertina: “Verso il blu” 1...8 e 1…9 ma l’Alpinismo non dà i 25 aprile sull’Antola per ricordare Guido Foto di Valentina Vinci numeri!.......................................................7 -

1.5 Biodiversity Conservation Information Systems
2013, Cover drawing by Helena Marcer i Espunya A contribution to the use, modelling and organization of data in biodiversity conservation A PhD dissertation presented by Arnald Marcer i Batlle with the acceptance of the dissertation’ s supervisors: Dr. Joan Pino Dr. Xavier Pons CREAF, UAB UAB CREAF, Universitat Aut`onoma de Barcelona Cerdanyola del Vall`es March 2013 Ai festa, petapigona! Dedicated to Helena, Anna and my parents Contents Contents v List of Figures ix List of Tables xi List of Acronyms xiii Acknowledgements 3 1 Introduction 5 1.1 Setting the problem . 5 1.2 Biodiversity data . 8 1.3 Mapping for biodiversity conservation . 14 1.4 Species distribution modelling . 18 1.5 Biodiversity Conservation Information Systems . 32 1.6 Dissertation structure . 38 2 Modelling distributions for rare species conservation 41 2.1 Abstract . 42 2.2 Introduction . 43 2.3 Methods . 45 2.4 Results . 53 2.5 Discussion . 57 v vi CONTENTS 2.6 Conclusions . 61 2.7 Acknowledgements . 62 3 Modelling IAS distributions from biodiversity atlases 63 3.1 Abstract . 64 3.2 Introduction . 65 3.3 Methods . 67 3.4 Results . 76 3.5 Discussion . 80 3.6 Conclusions . 82 3.7 Acknowledgements . 83 4 Protected Areas' Information System 85 4.1 Abstract . 86 4.2 Introduction . 87 4.3 Legal context . 91 4.4 System design and implementation . 92 4.5 Discussion . 101 4.6 Conclusions . 105 4.7 Acknowledgements . 106 5 General discussion and conclusions 107 5.1 General discussion . 107 5.2 Conclusions . 119 5.3 Further research . 122 References 123 Appendix A Distribution model maps of SCI 159 Appendix B Protected range maps of SCI 167 Appendix C Protected range sizes of SCI 175 CONTENTS vii Appendix D Occurrence maps of IAS 305 List of Figures 1.1 Dimensions of biodiversity data . -

Zone Speciali Di Conservazione (Zsc) Della Regione Biogeografica Mediterranea
Misure di conservazione dei sic della regione geografica mediterranea approvate con DGR 4 luglio 2017 n. 537 ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) DELLA REGIONE BIOGEOGRAFICA MEDITERRANEA MISURE DI CONSERVAZIONE approvate con DGR 4 luglio 2017 n. 537 (testo collazionato dagli Uffici regionali con le DGR 3 febbraio 2015 n. 73, 20 maggio 2016 n. 16) INDICE: IT1324818 Castell'Ermo - Peso Grande IT1342813 Rio Borsa - Torrente Vara IT1324896 Lerrone - Valloni IT1342824 Rio di Colla IT1314723 Campassu - Grotta Sgarbu Du Ventu IT1324908 Isola Gallinara IT1342907 Monte Antessio - Chiusola IT1315313 Gouta - Testa d'Alpe - Valle Barbaira IT1324909 Torrente Arroscia e Centa IT1342908 Monte Gottero - Passo del Lupo IT1315407 Monte Ceppo IT1324910 Monte Acuto - Poggio Grande - Rio Torsero IT1343412 Deiva Marina - Bracco - Pietra di Vasca - Mola IT1315408 Lecceta di Langan IT1325624 Capo Mele IT1343415 Guaitarola IT1315503 Monte Carpasina IT1330893 Rio Ciaè IT1343419 Monte Serro IT1315504 Bosco di Rezzo IT1331402 Beigua - Monte Dente - Val Gargassa - IT1343425 Rio di Agnola IT1315602 Pizzo d'Evigno Pavaglione IT1343502 Parco della Magra - Vara IT1315714 Monte Abellio IT1331501 Praglia - Pracaban - Monte Leco - Punta IT1343511 Monte Cornoviglio - Monte Fiorito - Monte IT1315715 Castel d'Appio Martin Dragnone IT1315716 Roverino IT1331606 Torre Quezzi IT1343518 Gruzza di Veppo IT1315717 Monte Grammondo - Torrente Bevera IT1331615 Monte Gazzo IT1343520 Zona Carsica Cassana IT1315719 Torrente Nervia IT1331718 Monte Fasce IT1343526 Torrente Mangia IT1315720 -
SPC LA-E-83011 Metanodotto Sestri Levante
CLIENTE: PROGETTISTA UNITÀ COMMESSA 000 023089 LOCALITÀ Regione Liguria SPC LA-E-83011 WBS CLIENTE PROGETTO Rev. NR / 17144 Fg. 1 di 75 Metanodotto Sestri Levante - Recco 0 Metanodotto Sestri Levante - Recco DN 400 (16”), DP 75 bar ed opere connesse Studio di Impatto Ambientale Annesso I Sintesi non tecnica 0 Emissione Pettinari Brunetti Guiducci Mag. ‘19 Rev. Descrizione Elaborato Verificato Approvato Data Documento di proprietà Snam Rete Gas. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge. CLIENTE: PROGETTISTA UNITÀ COMMESSA 000 023089 LOCALITÀ Regione Liguria SPC LA-E-83011 WBS CLIENTE PROGETTO Rev. NR / 17144 Fg. 2 di 75 Metanodotto Sestri Levante - Recco 0 INDICE 1 LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 6 1.1 Localizzazione 6 1.2 Caratteristiche del progetto 7 1.3 Proponente 8 1.4 Autorità competente all’approvazione del progetto 8 1.5 Informazioni territoriali 8 2 MOTIVAZIONE DELL’OPERA 25 3 OPZIONE ZERO, ALTERNATIVE VALUTATE E SOLUZIONE PROGETTUALE PROPOSTA 26 3.1 Opzione zero 26 3.2 Alternative valutate e soluzione progettuale proposta 26 4 RAPPORTO DEL PROGETTO CON LA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 37 4.1 Strumenti di tutela e pianificazione nazionali 37 4.2 Strumenti di tutela e pianificazione regionali 39 4.3 Strumenti di pianificazione provinciale 41 4.4 Strumenti di pianificazione locale 42 5 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E FUNZIONALI DEL PROGETTO 43 6 STIMA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI, MISURE DI MITIGAZIONE E DI MONITORAGGIO 54 6.1 Stima degli impatti 54 6.2 Misure di mitigazione ambientale 67 6.3 Monitoraggio ambientale 69 6.4 Sintesi delle relazioni “impatti- mitigazioni/compensazioni-monitoraggi” 72 7 CONCLUSIONI 75 Documento di proprietà Snam Rete Gas. -

Zone Speciali Di Conservazione (Zsc) Della Regione Biogeografica Mediterranea
Misure di conservazione dei sic della regione geografica mediterranea approvate con DGR 4 luglio 2017 n. 537 ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) DELLA REGIONE BIOGEOGRAFICA MEDITERRANEA MISURE DI CONSERVAZIONE approvate con DGR 4 luglio 2017 n. 537 (testo collazionato dagli Uffici regionali con le DGR 3 febbraio 2015 n. 73, 20 maggio 2016 n. 16) INDICE: IT1324818 Castell'Ermo - Peso Grande IT1342813 Rio Borsa - Torrente Vara IT1324896 Lerrone - Valloni IT1342824 Rio di Colla IT1314723 Campassu - Grotta Sgarbu Du Ventu IT1324908 Isola Gallinara IT1342907 Monte Antessio - Chiusola IT1315313 Gouta - Testa d'Alpe - Valle Barbaira IT1324909 Torrente Arroscia e Centa IT1342908 Monte Gottero - Passo del Lupo IT1315407 Monte Ceppo IT1324910 Monte Acuto - Poggio Grande - Rio Torsero IT1343412 Deiva Marina - Bracco - Pietra di Vasca - Mola IT1315408 Lecceta di Langan IT1325624 Capo Mele IT1343415 Guaitarola IT1315503 Monte Carpasina IT1330893 Rio Ciaè IT1343419 Monte Serro IT1315504 Bosco di Rezzo IT1331402 Beigua - Monte Dente - Val Gargassa - IT1343425 Rio di Agnola IT1315602 Pizzo d'Evigno Pavaglione IT1343502 Parco della Magra - Vara IT1315714 Monte Abellio IT1331501 Praglia - Pracaban - Monte Leco - Punta IT1343511 Monte Cornoviglio - Monte Fiorito - Monte IT1315715 Castel d'Appio Martin Dragnone IT1315716 Roverino IT1331606 Torre Quezzi IT1343518 Gruzza di Veppo IT1315717 Monte Grammondo - Torrente Bevera IT1331615 Monte Gazzo IT1343520 Zona Carsica Cassana IT1315719 Torrente Nervia IT1331718 Monte Fasce IT1343526 Torrente Mangia IT1315720 -

Zone Speciali Di Conservazione (Zsc) Della Regione Biogeografica Mediterranea
Misure di conservazione dei sic della regione geografica mediterranea approvate con DGR 4 luglio 2017 n. 537 ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) DELLA REGIONE BIOGEOGRAFICA MEDITERRANEA MISURE DI CONSERVAZIONE approvate con DGR 4 luglio 2017 n. 537 (testo collazionato dagli Uffici regionali con le DGR 3 febbraio 2015 n. 73, 20 maggio 2016 n. 16) INDICE: IT1324818 Castell'Ermo - Peso Grande IT1342813 Rio Borsa - Torrente Vara IT1324896 Lerrone - Valloni IT1342824 Rio di Colla IT1314723 Campassu - Grotta Sgarbu Du Ventu IT1324908 Isola Gallinara IT1342907 Monte Antessio - Chiusola IT1315313 Gouta - Testa d'Alpe - Valle Barbaira IT1324909 Torrente Arroscia e Centa IT1342908 Monte Gottero - Passo del Lupo IT1315407 Monte Ceppo IT1324910 Monte Acuto - Poggio Grande - Rio Torsero IT1343412 Deiva Marina - Bracco - Pietra di Vasca - Mola IT1315408 Lecceta di Langan IT1325624 Capo Mele IT1343415 Guaitarola IT1315503 Monte Carpasina IT1330893 Rio Ciaè IT1343419 Monte Serro IT1315504 Bosco di Rezzo IT1331402 Beigua - Monte Dente - Val Gargassa - IT1343425 Rio di Agnola IT1315602 Pizzo d'Evigno Pavaglione IT1343502 Parco della Magra - Vara IT1315714 Monte Abellio IT1331501 Praglia - Pracaban - Monte Leco - Punta IT1343511 Monte Cornoviglio - Monte Fiorito - Monte IT1315715 Castel d'Appio Martin Dragnone IT1315716 Roverino IT1331606 Torre Quezzi IT1343518 Gruzza di Veppo IT1315717 Monte Grammondo - Torrente Bevera IT1331615 Monte Gazzo IT1343520 Zona Carsica Cassana IT1315719 Torrente Nervia IT1331718 Monte Fasce IT1343526 Torrente Mangia IT1315720