Car·Teggio Con Leopoldo Marc' Antonio Caldani 1758-1794
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Libro Bianco Sui Beni Culturali Pisani
Libro bianco sui beni culturali pisani a cura del Gruppo Cultura di Una città in comune PRIMO AGGIORNAMENTO Pisa, 30 luglio 2014 1 Indice Introduzione 3 Biblioteche 6 Archivio Generale di Ateneo 7 Biblioteca Universitaria di Pisa 8 Biblioteca Franco Serantini 9 Biblioteca Provinciale di Pisa 10 Biblioteca SMS 11 Monumenti 12 Piazza del Duomo 12 Cimitero Ebraico 13 Area del Santa Chiara 13 Scuola Medica 14 Chiesa di Santa Maria della Spina 15 Chiesa di San Paolo a Ripa d'Arno 16 Cappella di Sant'Agata 17 Chiesa di Sant'Antonio in Qualquonia 17 Chiesa di San Pietro in Vinculis o San Pierino 18 Chiesa e convento di San Francesco 19 Oratorio di San Bernardino 20 Chiesa di San Silvestro 21 Chiesa di Santa Croce in Fossabanda 21 Chiesa di San Zeno 22 Chiesa e convento di San Vito 23 Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri 23 Palazzo Prini-Aulla o palazzo Mazzarosa 24 Chiesa di San Domenico 24 Chiesa di San Giorgio dei Tedeschi 25 Luoghi inutilizzati o sottoutilizzati 26 Monastero di San Benedetto 26 Chiesa di San Benedetto 26 Palazzo Franceschi Galletti 27 Giardino di San Vito 27 Mura di Pisa 27 Bastione Sangallo 29 Bastione del Parlascio 29 Limonaia 30 Arsenali Medicei 31 Parco Don Andrea Gallo 32 In (s)vendita 33 Spedale dei Trovatelli 33 2 Santa Croce in Fossabanda 33 Mattonaia 34 Palazzo Mastiani 35 Sprechi 37 Uffizi Pisani 37 Campanile di San Piero a Grado 38 Sistema museale 39 Opera della Primaziale Pisana 39 Museo nazionale di San Matteo 39 Museo nazionale di Palazzo Reale 41 Museo di Palazzo Blu 41 Musei Comunali 42 Spazio Espositivo Sopra -

Gesamtkatalog BRD (Regionalcode 2) Spielfilme Nr. 94 (Mai 2010)
Gesamtkatalog BRD (Regionalcode 2) Spielfilme -Kurzübersicht- Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Website und in unse- rem 14tägigen Newsletter Nr. 94 (Mai 2010) LASER HOTLINE - Inh. Dipl.-Ing. (FH) Wolfram Hannemann, MBKS Talstr. 11 - 70825 Korntal Tel.: (0711) 83 21 88 - Fax: (0711) 8 38 05 18 INTERNET: www.laserhotline.de e-mail: [email protected] Katalog DVD BRD (Spielfilme) Nr. 94 Mai 2010 (500) Days of Summer 10 Dinge, die ich an dir 20009447 25,90 EUR 12 Monkeys (Remastered) 20033666 20,90 EUR hasse (Jubiläums-Edition) 20009576 25,90 EUR 20033272 20,90 EUR Der 100.000-Dollar-Fisch (K)Ein bisschen schwanger 20022334 15,90 EUR 12 Uhr mittags 20032742 18,90 EUR Die 10 Gebote 20000905 25,90 EUR 20029526 20,90 EUR 1000 - Blut wird fließen! (Traum)Job gesucht - Will- 20026828 13,90 EUR 12 Uhr mittags - High Noon kommen im Leben Das 10 Gebote Movie (Arthaus Premium, 2 DVDs) 20033907 20,90 EUR 20032688 15,90 EUR 1000 Dollar Kopfgeld 20024022 25,90 EUR 20034268 15,90 EUR .45 Das 10 Gebote Movie Die 120 Tage von Bottrop 20024092 22,90 EUR (Special Edition, 2 DVDs) Die 1001 Nacht Collection – 20016851 20,90 EUR 20032696 20,90 EUR Teil 1 (3 DVDs) .com for Murder 20023726 45,90 EUR 13 - Tzameti (k.J.) 20006094 15,90 EUR 10 Items or Less - Du bist 20030224 25,90 EUR wen du triffst 101 Dalmatiner (Special [Rec] (k.J.) 20024380 20,90 EUR Edition) 13 Dead Men 20027733 18,90 EUR 20003285 25,90 EUR 20028397 9,90 EUR 10 Kanus, 150 Speere und [Rec] (k.J.) drei Frauen 101 Reykjavik 13 Dead Men (k.J.) 20032991 13,90 EUR 20024742 20,90 EUR 20006974 25,90 EUR 20011131 20,90 EUR 0 Uhr 15 Zimmer 9 Die 10 Regeln der Liebe 102 Dalmatiner 13 Geister 20028243 tba 20005842 16,90 EUR 20003284 25,90 EUR 20005364 16,90 EUR 00 Schneider - Jagd auf 10 Tage die die Welt er- Das 10te Königreich (Box 13 Semester - Der frühe Nihil Baxter schütterten Set) Vogel kann mich mal 20014776 20,90 EUR 20008361 12,90 EUR 20004254 102,90 EUR 20034750 tba 08/15 Der 10. -

Enrico Fermi a Firenze. Le «Lezioni Di Meccanica Razionale» Al Biennio
I LIBRI DE «IL COLLE DI GALILEO» ISSN 2704-5609 (PRINT) | ISSN 2612-7989 (ONLINE) – 6 – I LIBRI DE «IL COLLE DI GALILEO» Direttore Daniele Dominici (Università di Firenze) Comitato scientifico Oscar Adriani (Università di Firenze; Sezione INFN Firenze, Direttore) Marco Benvenuti (Università di Firenze; Presidente del Sistema Museale d’Ateneo) Roberto Casalbuoni (Università di Firenze) Francesco Cataliotti (Università di Firenze) Stefania De Curtis (Sezione INFN Firenze) Paolo De Natale (Istituto Nazionale di Ottica, Direttore) Pier Andrea Mandò (Università di Firenze) Giuseppe Pelosi (Università di Firenze) Giacomo Poggi (Università di Firenze) Maria Sofia Randich Osservatorio( Astrofisico di Arcetri, Direttore) Enrico Fermi a Firenze Le «Lezioni di Meccanica Razionale» al biennio propedeutico agli studi di Ingegneria: 1924-1926 a cura di Roberto Casalbuoni Daniele Dominici, Giuseppe Pelosi FIRENZE UNIVERSITY PRESS 2019 Enrico Fermi a Firenze : le «Lezioni di Meccanica Razionale» al biennio propedeutico agli studi di Ingegneria: 1924-1926 / a cura di Roberto Casalbuoni, Daniele Dominici, Giuseppe Pelosi. – Firenze University Press, 2019. (I libri de «Il Colle di Galileo» ; 6) https://www.fupress.com/isbn/9788864539607 ISSN 2704-5609 (print) ISSN 2612-7989 (online) ISBN 978-88-6453-959-1 (print) ISBN 978-88-6453-960-7 (online PDF) Progetto grafico di Alberto Pizarro Fernández, Lettera Meccanica SRLs Immagine di copertina: elaborazione grafica della fotografia che ritrae da sinistra a destra Franco Rasetti, Rita Brunetti, Nello Carrara, Enrico Fermi all’Istituto di Fisica ad Arcetri [Archivio Amaldi, Dipartimento di Fisica, Università di Roma “La Sapienza”] Certificazione scientifica delle Opere Tutti i volumi pubblicati sono soggetti a un processo di referaggio esterno di cui sono responsabili il Consiglio editoriale della FUP e i Consigli scientifici delle singole collane. -

Pise — Wikipédia
Pise Pise (en italien Pisa) est une ville italienne d'environ 89 620 habitants, chef-lieu de la province de même nom en Pise Toscane. Elle est célèbre dans le monde principalement pour sa tour penchée. Elle est traversée par le fleuve Arno et située sur la via Aurelia. Sommaire Drapeau 1 Histoire 1.1 Nouveauté 1.2 Au Moyen Âge 1.3 XIe siècle 1.3.1 Expansion maritime 1.3.2 Autonomie politique 1.3.3 Empire commercial 1.4 XIIe siècle 1.4.1 Conquêtes, pillages, apogée 1.4.2 Dans l'orbite gibeline 1.4.3 Rivalité avec Venise 1.5 XIIIe siècle 1.5.1 Flux et reflux militaire Noms 1.5.2 Situation démographique et économique Nom italien Pisa 1.5.3 La prise du pouvoir par le Popolo Administration 1.6 Déclin 1.6.1 La Méloria, fin de la puissance pisane Pays Italie 1.6.2 Une ville du contado florentin Région Toscane 2 Chronologie Province Pise 3 Économie 1 4 Monuments et patrimoine Maire Marco Filippeschi 4.1 La Piazza dei Miracoli 2008 - 2013 4.2 Autres édifices religieux Code postal 56100 4.3 Édifices civils Code ISTAT 050026 4.4 Places et sites intéressants Code 4.5 Musées cadastral G702 5 Personnalités liées à la ville Préfixe tel. 050 5.1 Natifs de Pise 5.2 Résidents Démographie 6 Administration Gentilé pisan, pisane 6.1 Hameaux Population 89 620 hab. (30-09-2012) 6.2 Communes limitrophes 6.3 Jumelages Densité 484 hab./km2 7 Notes et références Géographie 8 Annexes Coordonnées 43° 43ʹ 00ʺ Nord, 10° 24ʹ 00ʺ Est 8.1 Articles connexes (http://tools.wmflabs.org/geohack/ 8.2 Liens externes geohack.php?language=fr&pagen ame=Pise¶ms=43.716667_N _10.4_E_type:city_region:IT-PI) Histoire Altitude Min. -

Anteprima a Giro Per Pisa.Pdf
A giro per Pisa Numero speciale A giro per Pisa La città e le sue terre A giro per Pisa, collana a cura di Alessandro Bargagna e Chiara Celli (City Grand Tour) Numero speciale A giro per Pisa. La città e le sue terre Proprietà letteraria riservata © 2018 Marchetti Editore Marchetti Editore Piazza S. Silvestro, 27 - 56127 Pisa Tel. 050 9661249 [email protected] www.marchettieditore.it Grafica e disegni: Gabriele Simili e Martino Rossi Ideazione e realizzazione copertina: Gabriele Simili ISBN: 978-88-99014-38-4 I diritti di riproduzione e traduzione sono riservati. Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto/dall’editore. Alessandro Bargagna, Chiara Celli A giro per Pisa La città e le sue terre .. mmarmchetti eeditor.. e Presentazione City Grand Tour è un’associazione di guide turistiche professionali formata da Alessandro Bargagna e Chiara Celli. Operiamo nella città di Pisa e nel territorio che la cir- conda dal 2008. Cerchiamo la poesia della quotidia- nità, dei particolari, del passato fra i vicoli e le piazze dove, nel racconto degli abitanti e nello sguardo curio- so dei viaggiatori, si concentra il vissuto di un paese. Proponiamo itinerari alla scoperta dei centri minori, dei loro prodotti tipici e mestieri tradizionali, unendo storia, leggende e momenti di intrattenimento a tema. -

Maurice Finocchiaro Discusses the Lessons and the Cultural Repercussions of Galileo’S Telescopic Discoveries.” Physics World, Vol
MAURICE A. FINOCCHIARO: CURRICULUM VITAE CONTENTS: §0. Summary and Highlights; §1. Miscellaneous Details; §2. Teaching Experience; §3. Major Awards and Honors; §4. Publications: Books; §5. Publications: Articles, Chapters, and Discussions; §6. Publications: Book Reviews; §7. Publications: Proceedings, Abstracts, Translations, Reprints, Popular Media, etc.; §8. Major Lectures at Scholarly Meetings: Keynote, Invited, Funded, Honorarium, etc.; §9. Other Lectures at Scholarly Meetings; §10. Public Lectures; §11. Research Activities: Out-of-Town Libraries, Archives, and Universities; §12. Professional Service: Journal Editorial Boards; §13. Professional Service: Refereeing; §14. Professional Service: Miscellaneous; §15. Community Service §0. SUMMARY AND HIGHLIGHTS Address: Department of Philosophy; University of Nevada, Las Vegas; Box 455028; Las Vegas, NV 89154-5028. Education: B.S., 1964, Massachusetts Institute of Technology; Ph.D., 1969, University of California, Berkeley. Position: Distinguished Professor of Philosophy, Emeritus; University of Nevada, Las Vegas. Previous Positions: UNLV: Assistant Professor, 1970-74; Associate Professor, 1974-77; Full Professor, 1977-91; Distinguished Professor, 1991-2003; Department Chair, 1989-2000. Major Awards and Honors: 1976-77 National Science Foundation; one-year grant; project “Galileo and the Art of Reasoning.” 1983-84 National Endowment for the Humanities, one-year Fellowship for College Teachers; project “Gramsci and the History of Dialectical Thought.” 1987 Delivered the Fourth Evert Willem Beth Lecture, sponsored by the Evert Willem Beth Foundation, a committee of the Royal Netherlands Academy of Sciences, at the Universities of Amsterdam and of Groningen. 1991-92 American Council of Learned Societies; one-year fellowship; project “Democratic Elitism in Mosca and Gramsci.” 1992-95 NEH; 3-year grant; project “Galileo on the World Systems.” 1993 State of Nevada, Board of Regents’ Researcher Award. -

BILANCIO CONSUNTIVO Esercizio 2012
BILANCIO CONSUNTIVO Esercizio 2012 __________________________________________________________________________ Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione il 18 marzo 2013 Testo approvato dall’Assemblea dei Soci il 18 aprile 2013 Testo approvato dalla Deputazione il 19 aprile 2013 II ORGANI STATUTARI in carica alla data di approvazione del Bilancio III Consiglio Presidente Claudio Pugelli di Amministrazione Vice Presidente Mauro Ciampa Consiglieri Lucia Calvosa Niccolò Quaratesi d’Achiardi Maurizio Sbrana Collegio dei Revisori Presidente Massimo Catarsi Revisori Effettivi Giovanna Frullini Maurizio Roventini Revisori Supplenti Chiara Calvani Paolo Torracca Deputazione Enrico Barachini Giuseppe Macchi Raffaello Bartelletti Gualtiero Masini Luigino Bonaccorsi Paolo Miccoli Giovanni Bonadio Ugo Michelotti Marco Braccianti Angelo Migliarini Enrico Braghieri Giovanni Nardi Mario Campa Mario Pasqualetti Francesco Ciardelli Marinella Pasquinucci Roberto Ciardi Fabio Redi Giuseppe Diomelli Arnaldo Stefanini Franco Falorni Antonio Strambi Nicola Favati IV ASSEMBLEA DEI SOCI Presidente Francesco GAMBINI Vice Presidente Andrea BARTALENA Vice Presidente Salvatore SALIDU Soci Massimo ABBAGNALE Fabrizio FILIPPI Alessio ANTONELLI Pierluigi FILIPPI Paolo ARRIGONI Franco FORTI Massimo Mario AUGELLO Francesco GAMBINI Enrico BARACHINI Gabriella GARZELLA Francesco BARACHINI Alfredo GHIZZANI Roberto BARSOTTI Gina GIANI Andrea BARTALENA Giovanni GIUGNI Barbara BARTOLINI Domenico LAFORENZA Raffaello BARTELLETTI Roberto LANDI Giuseppe BATINI Michele LUZZATI -

IL RINTOCCO DEL CAMPANO 1.12 (112) Anno XLII - Genn.-Apr
IL RINTOCCO DEL CAMPANO 1.12 (112) Anno XLII - Genn.-Apr. 2012 Rassegna periodica dell’Associazione Laureati Ateneo Pisano Suona lento e grave. Il suo don, don, don... si sparge nell’aria assonnata: mentre la città si scopre dalla sua coltre di nebbia bianca mattutina. È la sveglia dello studente. da Antonio Cella, Il Campano , 1947 Associazione Laureati Ateneo Pisano A.L.A.P. – Area Vecchi Macelli, via Nicola Pisano 25, 56126 Pisa e-mail: alap @interfree.it – sito web: www.alap-pisa.it Orario apertura sede: lunedì e mercoledì, 15.30-18.30 Telefono 050/544182; cellulare 334/2521741 c/c Postale 14152565 - C.F. 80011740505 BancoPosta IBAN: IT46X0760114000000014152565 BIC: BPPIITRRXXX Un’Associazione che tende a riunire tutti coloro che, nel comune e sempre vivo attaccamento all’Alma Ma - ter Stu diorum, conservano e conserveranno una tradizio - nale dolce memoria di Pisa. Un sodalizio di ex studenti che, ovunque e comunque, vogliono rimanere idealmen - te «cittadini pisani» in forza di uno speciale e quasi fau - stiano «jus juventutis». Un impegno istituzionale verso l’Ateneo con intenti non solo affettivi ma anche concretamente rivolti a so - stenerne il prestigio per sempre migliori fortune. IL RINTOCCO DEL CAMPANO Rassegna periodica dell’Associazione Laureati Ateneo Pisano Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 4 del 12.4.1972 DIRETTORE RESPONSABILE Brunello Passaponti COMITATO DI REDAZIONE Lorenzo Gremigni Segretario di Redazione Gino Alabiso Antonio Cambi Renzo Castelli Otello Lenzi Vincenzo Lupo Berghini Maurizio Vaglini ALAP ORGANI -
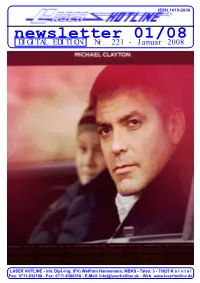
Newsletter 01/08 (Nr
ISSN 1610-2606 ISSN 1610-2606 newsletterDIGITAL EDITION Nr. 221 - 01/08Januar 2008 Michael J. Fox Christopher Lloyd LASER HOTLINE - Inh. Dipl.-Ing. (FH) Wolfram Hannemann, MBKS - Talstr. 3 - 70825 K o r n t a l Fon: 0711-832188 - Fax: 0711-8380518 - E-Mail: [email protected] - Web: www.laserhotline.de Newsletter 01/08 (Nr. 221) Januar 2008 editorial Hallo Laserdisc- und DVD-Fans, liebe Filmfreunde! Herzlich willkommen zu unserem ersten Newsletter im Jahre 2008. Nach einer kurzen Pause melden wir uns wieder zurück und prä- sentieren Ihnen das Neueste aus Deutschland und den USA. Die große Menge an Neu- veröffentlichungen in diesen beiden Regionen hat dazu geführt, dass wir in der vorliegenden Ausgabe auf die Japan-Releases verzichtet haben. Das holen wir aber selbstverständlich im nächsten Newsletter nach. Für uns Filmsammler fing das neue Jahr bereits mit einer grandiosen Neuigkeit an: die Welt wird blau! Der schon viel zu lange anhaltende Konkurrenzkampf zwischen den beiden High Definition Lagern ”Blu-ray Disc” und ”HD DVD” scheint beige- legt zu sein. Anstoß dazu gab Warner Home Video mit der Ankündigung, ab Mitte 2008 High Definition Versionen nur noch im ”Blu- ray”-Format anzubieten und auf ”HD DVD” zu verzichten. Das löste eine gewaltige Lawine in der DVD-Branche aus und führte zu strahlen- den Gesichtern bei den Fans. Denn damit dürfte die ”HD DVD” auf lange Sicht gesehen vom Markt verschwinden. Logisch dass Toshiba als ”HD DVD”-Verfechter nun alles erdenkliche tut, um sein System am Leben zu erhalten. Immerhin hat man zumindest mit Paramount derzeit noch einen der Großen mit im Boot. -

Und Kulturtransfer Zwischen Hannover Und Venedig in Der Frühen Neuzeit
Maße vor dem Druck überprüfen Rücken Falz 7 32 Falz 7 Hanovere, dessen Namensursprung bereits Gottfried Wilhelm Leibniz meine als Hohes Ufer deutete, und Venedig, die Stadt am Rialto, dem Hohen Ufer am strohmann weissmann Canal Grande, verbindet mehr als die bloße Namensverwandtschaft. Mit (Hg.) seinen prächtigen Staatsfesten und Prunkregatten, den öffentlichen Opernauf‑ Musik und führungen und nicht zuletzt dem Karneval war das Venedig der Frühen Vergnügen am Neuzeit ein beliebtes Reiseziel der Welfen und anderer europäischer Hofgesell‑ Hohen Ufer schaften und wurde modellbildend für das Musik‑ und Kulturleben nördlich der Alpen. Im Gegenzug leisteten die fürstlichen Besucher und auswärtigen Gesandten einen wesentlichen Beitrag zur Festkultur der Serenissima. Was zwischen den Hohen Ufern Venedigs und Hannovers erlebt und bewegt wurde, ist Gegenstand einer faszinierenden Geschichte eines umfassenden Musik‑, Fest‑ und Fest- und Kulturtransfer zwischen Hannover und Venedig Kulturtransfers. in der Frühen Neuzeit Der Sammelband zeichnet ein facettenreiches Bild von den sozialen, ökonomischen, politischen und nicht zuletzt künstlerischen Aspekten der Vergnügungsmetropole Herausgegeben von Sabine Meine, Nicole K. Strohmann Venedig und des gesamteuropäischen Zirkulationsprozesses zwischen Venedig, und Tobias C. Weißmann anderen italienischen Festzentren und den Höfen nördlich der Alpen. Der Schwer‑ punkt liegt auf den musikalischen Vergnügungen, die in besonderem Maße flüchtig und unwiederholbar – wie die Festkultur selbst – sind und von der Einbindung in ephemere Kunstformen leben. isbn 978‑3‑7954‑3142‑6 Sabine Meine, Nicole K. Strohmann und Tobias C. Weißmann (Hg.) Musik und Vergnügen am Hohen Ufer STUDI SCHRIFTENREIHE DES DEUTSCHEN STUDIENZENTRUMS IN VENEDIG CENTRO TEDESCO DI STUDI VENEZIANI NEUE FOLGE BAND XV herausgegeben von Michael Matheus STUDI Sabine Meine, Nicole K. -

Openness, Secrecy, Authorship Long 00 (I-Xvi/1-15) REV 5/14/01 7:43 PM Page Ii Long 00 (I-Xvi/1-15) REV 5/14/01 7:43 PM Page Iii
Long 00 (i-xvi/1-15) REV 5/14/01 7:43 PM Page i Openness, Secrecy, Authorship Long 00 (i-xvi/1-15) REV 5/14/01 7:43 PM Page ii Long 00 (i-xvi/1-15) REV 5/14/01 7:43 PM Page iii Openness, Secrecy, Authorship technical arts and the culture of knowledge from antiquity to the renaissance Pamela O. Long The Johns Hopkins University Press baltimore and london Long 00 (i-xvi/1-15) REV 5/14/01 7:43 PM Page iv © 2001 The Johns Hopkins University Press All rights reserved. Published 2001 Printed in the United States of America on acid-free paper 2 4 6 8 9 7 5 3 1 The Johns Hopkins University Press 2715 North Charles Street Baltimore, Maryland 21218-4363 www.press.jhu.edu Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Long, Pamela O. Openness, secrecy, authorship : technical arts and the culture of knowledge from antiquity to the Renaissance / Pamela O. Long. p. cm. Includes bibliographical references (p. ) and index. ISBN 0-8018-6606-5 (alk. paper) 1. Technology and civilization—History—To 1500. 2. Commu- nication of technical information—Europe—History—To 1500. 3. Technical writing—Europe—History—To 1500. 4. Intellectual property—Europe—History—To 1500. 5. Learning and scholar- ship—Europe—History—To 1500. 6. Renaissance. I. Title. CB478 .L65 2001 001.1'094—dc21 00-010152 A catalog record for this book is available from the British Library. Long 00 (i-xvi/1-15) REV 5/14/01 7:43 PM Page v For Bob Korn and Allison Rachel Korn Long 00 (i-xvi/1-15) REV 5/14/01 7:43 PM Page vi Long 00 (i-xvi/1-15) REV 5/14/01 7:43 PM Page vii Contents List of Illustrations -

Libri Internet 14-9-2020
14/09/2020 NOTE Il prefisso di codice CS indica un libro in sola consultazione La lettera R iniziale del codice, indica un libro per Ragazzi La lettera B iniziale del codice, indica un libro per Bambini Il numero che segue B oppure R indica l'età adeguata ELENCO DEI LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VILLANOVA D'ASTI L'ELENCO è un documento in formato PDF in cui ogni riga contiene i dati di un libro disponibile, (salvo giacenza 0 = prestito in corso). La codifica dei libri è di tipo Dewey semplificata. Il numero iniziale del codice Dewei indica l'argomento del libro I NUOVI ARRIVI (LIBRI NUOVI O ULTIME DONAZIONI) SI TROVANO AD INIZIARE DALLA PRIMA PAGINA come segue: Istruzioni per eseguire la ricerca di una parola chiave (cioè un autore, o un titolo, o parole intere parti di esso). Di preferenza evitare parole accentate o apostrofate (Perchè i titoli memorizzati in maiuscolo non le hanno, o possono non averle) 000 Enciclopedie e opere generali Ricerca con ACROBAT READER: fare clic sull'icona della LENTE, (oppure menù MODIFICA -> TROVA). Comparirà una casella in cui 100 Filosofia e discipline connesse scrivere l'occorrenza cercata. Premere AVANTI. Il ritrovamento è mostrato evidenziato in azzurro. Proseguire la ricerca con i Tasti “Avanti” 200 Religione o “Precedente”. 300 Scienze sociali - Economia, Politica, Diritto ecc. Ricerca con un browser internet (come Chrome; Mozilla Firefox; ecc): 400 Linguaggio 1) Fare clic sul tasto con tre lineette a destra della riga di indirizzo del vostro browser, e scegliere TROVA 500 Scienze naturali e matematica - Fisica, Astronomia, ecc.