Formazione Di Escalaplano
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Triassic and Jurassic Sedimentary Cycles in Central Sardinia
Geological Field Trips Società Geologica Italiana 2016 Vol. 8 (1.1) ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA Organo Cartografico dello Stato (legge N°68 del 2-2-1960) Dipartimento Difesa del Suolo ISSN: 2038-4947 The Triassic and Jurassic sedimentary cycles in Central Sardinia: stratigraphy, depositional environment and relationship between tectonics and sedimentation 85° Congresso Nazionale della Società Geologica Italiana - Sassari, 2008 DOI: 10.3301/GFT.2016.01 The Triassic and Jurassic sedimentary cycles in Central Sardinia: stratigraphy, depositional environment and relationship between tectonics and sedimentation L. G. Costamagna - S. Barca GFT - Geological Field Trips geological fieldtrips2016-8(1.1) Periodico semestrale del Servizio Geologico d'Italia - ISPRA e della Società Geologica Italiana Geol.F.Trips, Vol.8 No.1.1 (2016), 78 pp., 54 figs. (DOI 10.3301/GFT.2016.01) The Triassic and Jurassic sedimentary cycles in Central Sardinia: stratigraphy, depositional environment and relationship between tectonics and sedimentation 85° Congresso Nazionale della Società Geologica Italiana, Sassari 6-8 settembre 2010 Luca G. Costamagna*, Sebastiano Barca** * Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, Via Trentino, 51 - 09127, Cagliari (Italy) ** Via P. Sarpi, 18 - 09131, Cagliari (Italy) Corresponding Author e-mail address: [email protected] Responsible Director Claudio Campobasso (ISPRA-Roma) Editorial Board Editor in Chief Gloria Ciarapica (SGI-Perugia) M. Balini, G. Barrocu, C. Bartolini, 2 Editorial Responsible D. Bernoulli, F. Calamita, B. Capaccioni, Maria Letizia Pampaloni (ISPRA-Roma) W. Cavazza, F.L. Chiocci, R. Compagnoni, D. Cosentino, Technical Editor S. Critelli, G.V. Dal Piaz, C. D'Ambrogi, Mauro Roma (ISPRA-Roma) P. -

Cagliari ARMUNGIA X X BALLAO X X X ESCALAPLANO X X X
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Il COMMISSARIO DELEGATO ex OCDPC n. 122 DEL 20 PRESIDENTZIA NOVEMBRE 2013: PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PRESIDENZA PROTEZIONE CIVILE PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DI NOVEMBRE 2013 NELLA REGIONE Il Commissario delegato per l'emergenza AUTONOMA DELLA SARDEGNA Tabella A – Allegata all'Ordinanza n. 16 del 10/12/2013 come modificata dalle Ordinanze n. 17 e n. 18 del 12/12/2013 Interventi di Interventi di Interventi Danni al soccorso e Provincia COMUNI somma provvisionali patrimonio assistenza alla urgenza urgenti pubblico popolazione ARMUNGIA XX BALLAO XXX ESCALAPLANO XXX ESTERZILI XXX Cagliari SEULO X SILIQUA XXX VILLAPUTZU X VILLASALTO X VILLASOR XX BITTI XXX DESULO XX DORGALI XXX GALTELLI' XXXX IRGOLI XXX LOCULI XXX LODE' XXX LULA XXX MACOMER XX Nuoro NUORO XXX OLIENA XX ONANI' XXX ONIFAI XXX ORGOSOLO XX OROSEI XXX POSADA XX SINISCOLA XX TORPE' XXXX BAULADU X GONNOSTRAMATZA X MARRUBIU XXX MASULLAS XX MOGORO XXX MORGONGIORI XX Oristano ORISTANO XX PALMAS ARBOREA XXXX SAN NICOLO' D'ARCIDANO XX SIRIS X SOLARUSSA XXX TERRALBA XXXX URAS XX ALA' DEI SARDI XX ARZACHENA XXXX BERCHIDDA XX BUDDUSO' X BUDONI XX Olbia-Tempio LOIRI PORTO SAN PAOLO XXX MONTI XX OLBIA XXXX PADRU XXX SANT'ANTONIO DI GALLURA XX TELTI XX PABILLONIS XX SAN GAVINO MONREALE XXX Medio SANLURI XXX Campidano SARDARA X VILLACIDRO XX ARZANA XX GAIRO XXX JERZU XX SEUI XXX Ogliastra TALANA XX URZULEI XX USSASSAI X VILLAGRANDE STRISAILI XX COMUNI INTERESSATI E DATI PLUVIOMETRICI 84,4 PRESIDÈNTZIA 89,6 55,4 PRESIDENZA 60,6 ARZACHENA Il -

La Ragazzina Che Andava a Cagliari Con Il Carro a Buoi Di Matteo Cucca
L'O7 lug-ago 016def_Layout 1 11/07/16 17.13 Pagina 30 30 | città&paesi | escalaplano La ragazzina che andava a Cagliari con il carro a buoi di Matteo Cucca Storia di tzia Mariuccia Orlando Tolu e il nostro. fregula e malloreddus. Il grano veniva trasportato in dei Inoltre, ogni qualvolta moriva un Pitzalis, classe 1919 sacchi, la capienza massima era di 21 bambino, veniva interpellata anche starelli. Il carro era ben carico, per fare su comali o meglio su perché portavamo anche la paglia e comaleddu po is pipius, una sorta di ono figlia di Sisinnio l’acqua per i buoi. Ho in mente cuscino a forma del piccolo defunto Pitzalis e Antonia Loi, ancora il nome di uno dei gioghi di realizzato con sa fronica, un’erba che tutti e due di Escalaplano. famiglia, Portadì beni e Xebera. veniva ben pigiata e stretta forte Sono nata il 10 marzo Arrivati in città lo versavamo in un forte, a cui venivano appesi tanti S1919, ora ho 97 anni. grande vascone, dove scendeva giù campanellini d’argento e oggetti de Mio padre, era di secondo letto, sino a non vedersi più. prata, infine addobbata con tanti sposato due volte; Bonino era mio Mi divertivo tanto, ero una ragazzina, fiori. Questo veniva appoggiato sopra fratello, poi avevo 5 fratellastri (Rosa, avrò avuto 14 anni. Facevo il bambino e subito dopo il funerale Felicina, Luigi, Raimondo e compagnia a mio fratello Bonino, più disfatto; gli oggetti presi in prestito Giuseppe). Mi sposai a 25 anni con grande di me di 4 anni, che aveva il venivano subito restituiti ai Giuseppe Bianco, contadino. -
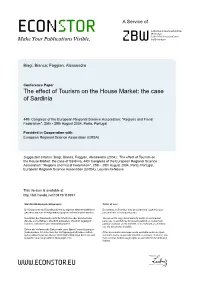
The Case of Sardinia
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Biagi, Bianca; Faggian, Alessandra Conference Paper The effect of Tourism on the House Market: the case of Sardinia 44th Congress of the European Regional Science Association: "Regions and Fiscal Federalism", 25th - 29th August 2004, Porto, Portugal Provided in Cooperation with: European Regional Science Association (ERSA) Suggested Citation: Biagi, Bianca; Faggian, Alessandra (2004) : The effect of Tourism on the House Market: the case of Sardinia, 44th Congress of the European Regional Science Association: "Regions and Fiscal Federalism", 25th - 29th August 2004, Porto, Portugal, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/116951 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. -

Tolu Albero Completo
Tav. 1 (La ricostruzione genealogica di questa tavola è a cura di Enrico Tola Grixoni e Luigi Orrù di San Raimondo) Sebastiano Tolo (Oliena, sec. XVI) Ricco possidente di Oliena, nel 1565 ottiene in enfiteusi il salto di Biriddò dall’Arcivescovo di Cagliari Parragues Monserrato I 1 (Oliena, secc. XVI e XVII) Possidente e collettore delle rendite della diocesi - reso Cavaliere ereditario il 31 agosto 1605 - sposa (forse) 2 Dorabella Caterina Manca Pirella, Donzella (di Galtellì) Sebastiano, Cavaliere Monserrato II, Cavaliere Giovanni Mauro, Cavaliere (Secc. XVI e XVII) (Secc. XVI e XVII) (Secc. XVI e XVII) (presente alle Cortes del 1614) (presente alle Cortes del 1614) (presente alle Cortes del 1614) (?) sposa ...................... (?) Don Gabriele (Cav.) Sebastiano, Cav. Monserrato III, Cav. (Secc. XVI e XVII, Oliena e Galtellì) (Sec. XVII, Oliena) (Sec. XVII, Galtellì) presente alle Cortes del 1614 col padre; presente alle Cortes del presente alle Cortes del 1624, 1631 presente alle Cortes del 1624 e 1626 1624 col fratello Sebastiano, Oliena; presente alle Cortes del 1626 sposa ........ sposa ............. col fratello Monserrato, Galtellì; presente Cortes 1642, Oliena sposa ................ 3 3 Don Sebastiano Don Pietro Michele Emanuele, Cav. Monserrato IV, Cav. Giovanni Stefano, Cav. (Oliena, sec. XVII) (Oliena, sec. XVII) (Oliena, sec. XVII) (Oliena, sec. XVII) (Oliena, sec. XVII) Presente alle Cortes del 1642 con il presente alle Cortes del 1642 presente alle Cortes del 1642 presente alle Cortes 1631, nel 1642 presente Cortes 1631, nel 1642 padre e a quelle del 1654; convocato ma con il padre e a quelle del 1654 anche quale procuratore di per procura a Emanuele e a per procura a Emanuele non abilitato a quelle del 1666 e 1677 Monserrato IV e Giovanni Stefano quelle del 1654; convocato ma non abilitato alle Cortes del 1666 sposa Tommasa Grazia Solinas (presunti fratelli) Salvatore, Cav. -

Comune Di Escalaplano Provincia Del Sud Sardegna SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO Via Sindaco Giovanni Carta N
Allegato 4 Comune di Escalaplano Provincia del sud Sardegna SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO Via Sindaco Giovanni Carta n. 18 - 09051 Tel. 0709541032 – fax 070 9541035 email: [email protected] - pec: [email protected] RELAZIONE TECNICA DI STIMA ESTRAZIONE SUGHERO PROPRIETA’ COMUNALE IN LOCALITA’ FOSSADA, RELIQUATO S.P.22 E PINETA. ANNUALITA’ 2019 1. PREMESSA Considerato che nell'anno 2009 si è proceduto all'estrazione del materiale sugheroso nelle proprietà comunali in località Fossada, Pineta e reliquato S.P. 22 in località Is Pranus e che pertanto, ad oggi, sono stati raggiunti i tempi minimi di maturazione per poter procedere ad una nuova estrazione, l'Amministrazione Comunale di Escalaplano (Prov. Sud Sardegna) ha conferito all'ufficio tecnico comunale l 'incarico di procedere alla stima del sughero estraibile dalle sughere presenti nelle suddette proprietà. 2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO Il Comune di Escalaplano (338 m. s.l.m.) è ubicato nella Sardegna sud orientale, interposto tra le regioni storiche del Gerrei, Sarcidano e dell'Ogliastra. Il suo territorio, a tratti delimitato sul versante Ovest dal Flumendosa, è confinante ad ovest con il territorio del comune di Orroli, a nord con Esterzili e Seui (isola amministrativa), ad est con il comune di Perdasdefogu, a sud con i comuni di Villaputzu, Ballao e Goni. Ha una conformazione basso collinare, anche se a tratti si presenta aspra e accidentata, con altitudini comprese fra i 90 metri s.l.m. (valle del Flumendosa) e i 674 metri s.l.m. nella parte alta dell’altopiano, in località "Taccu", al confine con l’isola amministrativa del comune di Seui. -

La Sardegna Cresce Con L'europa
La Sardegna cresce con l’Europa Cagliaritano Territory Basilica of Archaeological area Project jointly funded by the European Union San Saturnino of Sant’Eulalia Operational programme ERDF 2007 – 2013 Cagliari Cagliari EUROPEAN UNION ERDF - European Regional Development Fund - Axis I, Activity line 1.2.3.a. REPUBBLICA ITALIANA P.O.R. ERDF Sardinia 2007-2013, Line 1 “Information Society”, Specific Goal 1.2. “Promoting and developing the information society with a particular attention to those key aspects that will sustain the development of the territory and the quality of life, as health, education and the promotion of culture”, Operational Goal 1.2.3. “Increasing the production of the digital contents”, Action Line of 1.2.3.a. “Actions for the production, publication and sharing on the web and on new media (DTV, mobile T, etc.) of digital contents concerning Sardinia’s culture, literature, music, territory and images for a social fruition”. Cultural heritage Cagliaritano We thank the Superintendence for the Architectural, Landscape, Historical, Artistic and Ethno-An - thropological Heritage for the metropolitan city of Cagliari and for the provinces of Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias and Ogliastra, for the kind cooperation. Territory Basilica of San Saturnino | Cagliari Archaeological area of Sant’Eulalia | Cagliari Cultural heritage Unicity Srl: Sardegna Virtual Archaeology Coordination and Production 3D and 3D Render Reconstruction Cagliaritano and Production Virtual Guided Territory Visits and Virtual Views Production Communication and Multimedia Basilica of San Saturnino Testaluna Srl: Text: Mrs. Lucia Mura 3D Planning and Interactivity Mrs. Rossana Martorelli Polonord Adeste Srl: Archeological area USB Pendrive Production of Sant’Eulalia Text: Mrs. -

Nuragic Territory and Ancient Landscape. the Pranemuru Plateau (Sardinia) During the Bronze Age1
NURAGIC TERRITORY AND ANCIENT LANDSCAPE. THE PRANEMURU PLATEAU (SARDINIA) DURING THE BRONZE AGE1 ABSTRACT Preface. Marisa Ruiz-Gálvez. Universidad Complutense This book is the result of the project Nuragic Territory and Ancient Landscape in the Prane- muru Plateau; a research and heritage project in the Nuoro Province (Sardinia) sponsored by the Spanish Ministerio de Educación (project DGES PB98-0840), the Universidad Complutense (Proyecto Multidisciplinar Complutense PR269-98/196) and the Instituto del Patrimonio Histó- rico Español (Ayudas a Misiones Arqueológicas Españolas en el Extranjero 1999-2001). It also had the valuable support of Ph.D. Fulvia Lo Schiavo, Soprintendente Dirigente for Archaeology in the Sassari and Nuoro Provinces until 2000, the person responsible of the research project in the Arrubiu nuraghe in Orroli. This project emerges from the team’s diverse interests as regards the study of the commercial relations in the Bronze Age Mediterranean region, the analysis of landscape in past farming so- cieties’ identity formation, and the causes, contexts and times of the Greek – Phoenician coloni- sation in the Mediterranean. The multidisciplinary project paid by the Universidad Complutense allowed the incorporation of geographers, who performed the GIS modelling used in the landscape study, as well as some rural development specialists who discussed the ways of making public and exhibiting the ar- chaeological heritage in the study territory. The project team members are sincerely grateful to the Spanish institutions and Italian authori- ties that sponsored this work, especially Ph.D. Lo Schiavo. Survey design. Marisa Ruiz-Gálvez. Universidad Complutense The study took place in the eastern half of the Sardinian Island, in the counties of Orroli, Nurri and Escalaplano in the Nuoro Province. -

Listino Dei Valori Immobiliari Dei Terreni Agricoli
ISSN: 2280-191X LISTINO DEI VALORI IMMOBILIARI DEI TERRENI AGRICOLI PROVINCIA DI CAGLIARI -CI-VS LISTINO 2017 RILEVAZIONE ANNO 2016 quotazioni dei valori di mercato dei terreni agricoli entro un minimo e un massimo per le prin cipali colture in ciascun comune privati professionisti edizioni pubblica amministrazione O SSERVATORIO DEI VALORI AGRICOLI – PROVINCIA DI CAGLIARI – RILEVAZIONE 201 6 Hanno collaborato alla formazione del listino MASSIMO CURATOLO, ingegnere, membro di numerose commissioni di congruità presso enti pubblici. È stato capo area presso la struttura centrale della Agenzia del Territorio che si occupava di Osservatorio del mercato immobiliare. Ha diretto l’ufficio tecnico erariale di Isernia e di Viterbo. È stato capo del Servizio Tecnico 1° della Direzione Centrale dei SS.TT.EE. Autore/coautore di numerose pubblicazioni sia in campo estimale che catastale. Ha svolto numerosi incarichi di docenza. ANTONIO IOVINE, ingegnere consulente in materia di catasto ed estimo, attualmente direttore scientifico rivista informatica www.catastonline.it. È stato dirigente dell’Agenzia del territorio, responsabile dell’Area per i servizi catastali della Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare, membro della Commissione Censuaria Centrale. Autore/coautore di vari testi in materia di catasto, topografia ed estimo, ha svolto numerosi incarichi di docenza per conto della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze e di altre strutture pubbliche o private tra cui, Scuola delle Autonomie locali, Consiel, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Verona, Synergia formazione. La redazione gradisce indicazioni costruttive o suggerimenti migliorativi ([email protected]). Disclaimer L’elaborazione del testo, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per errori o inesattezze. -

Data Luogo Città Indirizzo 1 Murru Graziella 11/05/1959 Assolo Isili Via Dei Ginepri 21 3491237791 Si Tutti I Giorni Con Presen
Registro degli Assistenti familiari PLUS 7 SARCIDANO - BARBAGIA DI SEULO N° Iscriz Cognome e Nome Nascita Residenza Recapito Titoli professionali Esperienza Disponibilità logistica e Orari di lavoro disponibili Tipologia e Auto Patente registro Telefonico lavorativa territoriale del servizio di caratteristiche del munito Data Luogo Città Indirizzo assistenza fornito servizio di assistenza offerto 1 Murru Graziella 11/05/1959 Assolo Isili Via Dei ginepri 21 3491237791 si Escolca,Gergei,Isili,Nuragus,Nurall tutti i giorni con presenza nessuna preferenza SI SI ao,Nurri,Orroli,Serri,Villanova Tulo part Time 2 Demuro Annalaura 07/12/1990 Cagliari Villanova Via campo dei 0782813151 si Escolca,Gergei,Nuragus,Nurallao, Tutti i giorni a tempo pieno nessuna preferenza si si Tulo fiori 14 Nurri,Orroli,Sadali,Serri,Seulo,Villa senza pernotto nova Tulo 3 Melis Arianna 22/10/1988 Cagliari Isili Via Paganini 21 3402922143 Corso di formazione no Escolca,Gergei,Isili,Nuragus,Nurall tutti i giorni con presenza a nessuna preferenza si si professionale ao,Serri,Villanova Tulo tempo pieno senza teorico/pratico di 200 pernotto ore 4 Lai Dalila 22/02/1987 Cagliari Gergei Vico II Municipio 3201629493 Corso di formazione si Escolca,Gergei,Isili,Nuragus,Nurall tutti i giorni con presenza a nessuna preferenza si si 4 professionale ao,Nurri,Orroli,Serri,Villanova Tulo tempo pieno senza teorico/pratico di 200 pernotto ore 5 Dessì Francesca 30/04/1973 Cagliari Esterzili Via Garibaldi 7 3395024357 Titolo di O.S.S. si Escalaplano,Esterzili,Isili,Sadali,Se tutti i giorni -

O 09010 GIBA 3 Agus Mariella VIA I
SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1 ELENCO AMMESSI NOMINATIVO INDIRIZZO DOMICILIO 1 Abis Anna via RINASCITA09034 Villasor 20 C/ 2 Agosta Francesco 09010 GIBA O VIA 3 Agus Mariella 09040 SERDIANA ITA Via 4 Albanella Roberta 09030 Elmas Gili Via 5 Aledda Massimo 09048 Sinnai IV 6 Altea Roberto VIA UMBERTO09030 SARDARA I 37 via 7 Ambu Maria Grazia 09042 Monserrato Cle Via 8 Ambu Stefano 09028 Sestu Sar c/o 9 Anardu Leandra 09100 Cagliari AG 10 Angioni Michele VICO09042 III GIULIO MONSERRATO CESARE 14 Via 11 Angioni Nevina 09045 QUARTU S.E. PE VIA 12 Annis Valeria 09124 CAGLIARI CO VIC 13 Anolfo Gabriella 09040 SELEGAS O 14 Arca Antonella VIA GARIBALDI09096 SANTA 113 GIUSTA OR VIA 15 Ardau Angelo 09044 QUARTUCCIU PU Via 16 Ardau Laura 09126 Cagliari Dei VIA 17 Ardau Marco 09134 Cagliari DEI PIA 18 Aresu Luisella 09095 POMPU ZZ Via 19 Aresu Maria Francesca 09040 Donori Vitt VIA 20 Argiolas Carla 09042 Monserrato VIR VIA 21 Argiolas Daniela 09027 SERRENTI TO c/o 22 Argiolas Ignazio Ferdinando 09047 Selargius Fa Via 23 Ariu Giovanna 09042 Monserrato Car VIA 24 Arrù Marco 08015 Macomer (NU) PIE 25 Aru Stefania VIA LEOPARDI08015 Macomer 1 (NU) 26 Asili Carlo VIA XXV09041 APRILE Dolianova 1945 N. 37 27 Asunis Emanuela VIA COSTITUZIONE09040 SERDIANA SNC 28 Atzei Ingrid Corso09032 Africa Assemini 11 29 Atzei Linetta Via Nazionale09035 Gonnosfanadiga 81 CA 30 Atzei Veronica VICO09040 I GRUTTIXEDDAS SAN BASILIO 4CA 31 Atzeni Alessia Via G.09042 Cesare Monserrato 70 32 Atzeni Anna Maria VICO09031 I P. -

Piano Regionale Di Previsione, Prevenzione E
PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI 2020-2022 Anno 2020 PRESIDI TERRITORIALI ANTINCENDIO Approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 28/16 del 04/06/2020 Con il contributo di: Direzione Generale della Protezione Civile Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Direzione Generale dell’Agenzia FoReSTAS INDICE: SERVIZI TERRITORIALI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DEL CFVA ……………………………………….. pag. 1 STAZIONI FORESTALI DEL CFVA …………………………………………………………………………………………. “ 3 BASI OPERATIVE DEL CFVA ……………………………………………………………………………………………….. “ 8 SQUADRE DI LOTTA AGENZIA FORESTAS…………………………….……………………………………………… “ 10 STRUTTURA SEDI DEI VIGILI DEL FUOCO ..…………………………………………………………………………. “ 18 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ……………………………………………………………………………….. “ 23 COMPAGNIE BARRACELLARI ……………………………………………………………………………………………… “ 38 SERVIZI TERRITORIALI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DEL CFVA 1 Servizi Territoriali Ripartimentali del CFVA - STIR DIREZIONE GENERALE DEL CFVA TEMPIO CAGLIARI IGLESIAS LANUSEI NUORO ORISTANO SASSARI PAUSANIA VIA CANEPA, 17 (EX VIALE DANTE VIA KENNEDY, 1 - VIA BIASI, 9 - 09131 VIA ILBONO - 08045 VIA TRIESTE 58 - VIA DONIZETTI, 15/A ENAOLI) - 09016 ALIGHIERI, 37 - 07029 TEMPIO CAGLIARI LANUSEI 08100 NUORO - 09170 ORISTANO IGLESIAS 07100 SASSARI PAUSANIA 2 STAZIONI FORESTALI DEL CFVA 3 Stazioni Forestali del CFVA (UOC) STAZIONE STIR COMUNE INDIRIZZO AMBITO VILLANOVAFRANCA, TURRI, GENURI, LAS PLASSAS, SIDDI, USSARAMANNA, BARUMINI CA BARUMINI VIA SAN NICOLA BARUMINI, GESTURI,