Gruppo Alpinisti Sciatori
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Via Ferratas of the Italian Dolomites Volume 1
VIA FERRATAS OF THE ITALIAN DOLOMITES VOLUME 1 About the Author VIA FERRATAS OF James Rushforth is an experienced professional climber, mountaineer, skier and high-liner. His book The Dolomites: Rock Climbs and Via Ferrata was THE ITALIAN DOLOMITES nominated for the Banff Film Festival Book Award and was cited as ‘the best Dolomite guidebook ever produced’ (SA Mountain Magazine). James VOLUME 1 also works as a professional photographer and has won 12 international photography competitions and published work in numerous magazines by James Rushforth and papers including National Geographic, The Times and The Daily Telegraph. He has written tutorial and blog posts for a number of popular media platforms such as Viewbug and 500px, and appeared as a judge in several global competitions. Although based in the UK, James spends much of his time explor- ing the Italian Dolomites and is one of the leading authorities on the region – particularly with regards to photography and extreme sports. He is part of the Norrøna Pro Team and is kindly supported by Breakthrough Photography, Landcruising and Hilleberg. James can be contacted at www.jamesrushforth.com. Other Cicerone guides by the author Ski Touring and Snowshoeing in the Dolomites JUNIPER HOUSE, MURLEY MOSS, OXENHOLME ROAD, KENDAL, CUMBRIA LA9 7RL www.cicerone.co.uk © James Rushforth 2018 CONTENTS First edition 2018 ISBN: 978 1 85284 846 0 Map key ...................................................... 9 Overview map ................................................ 10 This guide further develops and replaces the previous guide by Graham Fletcher Route summary table ........................................... 12 and John Smith with the same title published under ISBNs 9781852843625 and Foreword .................................................... 17 9781852845926 in 2002 and 2009 respectively. -

The British, Kugy, and Western Slovenia
182 The British, Kugy, and Western Slovenia Ksenija Rozman Plates 69-72 The Julian Alps, the Sava valley, the surroundings of the lakes at Bled and Bohin;, Lake Cerknica, the city of Ljubljana and the Postojna caves are areas which the British have been visiting for centuries-fust as scientists, later also as travellers and mountaineers, and today mainly as tourists. All these areas are readily accessible by organized motor co'ach tours which start from Bled, Bohinj and Kran;ska gora. This territory, once part of the multi-national Austrian empire, now is the western part of the republic of Slovenia, one of the six constituent republics of Yugoslavia. The highest mountain in Yugoslavia, Triglav (2863m), lies in Slovenia. Dr Julius Kugy once asked France Avein, the Slovenian moun taineer, climber and professor of electrical engineering, what part of the Julian Alps he liked the best. Avein decided on the western Julian Alps, but Kugy demurred; 'That's all right, my dear Avein, it's beautiful! But the eastern part has the Triglav. The Triglav is not a mountain, the Triglav is a realm.'l Forests, mountains, mountain flora, meadows, rivers and lakes are all naturally constituent parts of the globe-but so many prominent Britons have wri~ten so much in praise of Slovenia and its people that even the best educated European could hardly fail to take heed and to be flattered. Sir Humphry Davy, and after him Josiah Gilbert and GC Churchill thought that the valley of the Sava river was the most beautiful valley in Europe. -

Cadore: Costruzioni Identitarie E Tutela Giuridica
Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Economia e Gestione delle Arti e delle attività culturali (EGArt) Tesi di Laurea Cadore: Costruzioni identitarie e tutela giuridica Relatore Ch. Prof. Maria Luisa Ciminelli Correlatore Prof. Lauso Zagato Laureando Camilla Larese De Santo Matricola 840484 Anno Accademico 2014 / 2015 1 Sommario Sommario ............................................................................................................................................. 2 Introduzione ........................................................................................................................................ 4 Sintesi della tesi ............................................................................................................................................. 5 Ricerca antropologica di una cadorina in Cadore: riflessioni metodologiche ............................................... 7 Capitolo 1. Identità e cultura ............................................................................................................ 10 1.1 Identità .................................................................................................................................................. 10 1.2 Cultura ................................................................................................................................................... 19 1.3 Identità, cultura e UNESCO ................................................................................................................... -

2013 Italy: Dolomites & Venice, Croatia
Priorities: Itinerary with overnight refuges (green). 1. July 12 Fri: Fly Seattle late afternoon overnight to Amsterdam. 2013 Italy: Dolomites & Venice, Croatia, 2. July 13 Sat: Arrive in Venice late afternoon. Venice night 1 of 4. Slovenia by [email protected] 3. July 14 Sun: Venice night 2 of 4, Antica Raffineria in Cannaregio *** Shorter Walks in the Dolomites by Gillian Price 2012, 2nd 4. July 15 Mon: Venice night 3 of 4, Antica Raffineria Ed: is referenced throughout as “SWD” with Hike#. 5. July 16 Tues: Venice night 4 of 4, Antica Raffineria *** Rick Steves’ Venice 2013. Croatia & Slovenia 2012. 6. July 17 Wed: Venice car rental > 3.5hrs > ***Brenta Dolomites Lonely Planet: Hiking Italy 2010 describes longer routes Rifugio Tucket or Rifugio Brentei overnight. “GPS” in this document marks Tom’s Waypoints for this device: Garmin 2595LMT GPS (at Costco) speaks turn-by-turn routes! 7. July 18 Thu: Hike out. > Drive 1.7 hrs > Bolzano: **Iceman; Add Europe module; lists lodging & phone #’s. Garmin Basecamp **Castelo Roncolo/Runkelstein Castel. Flexible/rain day. for PC pre-plans hundreds of Waypoints and records Routes (each 8. July 19 Fri: 45min > ***Karersee/L.Carezza, **hike 5mi/450m. Route must break into <600 miles and <30 waypoints). [Google Maps are much better, but they require a smart phone/tablet.] Rosengarten/Catinaccio Group: **Rif. Paolina lift +night+hike. US$1.33 per € euro = 0.75 € per US$ on 6/12/13 9. July 20 Sat: Hike ***Inner Catinacchio, Passo Principe, Vaiolet Italy jet lag is Seattle + 9 hours (GMT+1 hour) Towers: ***Rifugio Vaiolet 3 hrs RT + Lake Antermoia 6.5 hrs. -

Bulletin Europei 2017
Comune di Auronzo www.auronzomisurina.it azione It er al d ia e n F a C k a a y noa Ka AURONZO DI CADORE, ITALY 28.06.2018 - 01.07.2018 BULLETIN www.auronzo2018.eu - [email protected] …. Welcome from Major of Auronzo …. 2018 ECA JUNIOR & U23 CANOE SPRINT EUROPEAN CHAMPIONSHIPS WELCOME FROM THE PRESIDENT OF THE ITALIAN CANOE FEDERATION An important international event returns to Italy and it does so in the magnificent setting of Auronzo di Cadore with the ECA European Canoe Sprint Junior & Under 23 Championships. After having organised some international events, the Italian Canoe Kayak Federation is going through a new experience, to be once again the protagonist of a great competition. A sincere thank you to the Organising Committee in the person of Andrea Bedin, who has successfully organised several international events – including the annual International Flatwater Sprint regatta in Auronzo di Cadore which is dedicated to the youth categories. For these European Championships we will be at the side of this further important event, supporting it in the institutional relations, in the organisation and communications. The best athletes of the youth categories will be present, representing the future of the Olympic canoe. It will be an extraordinary event, capable of combining competition and the desire for results, the beauty of the landscape and the warmth of an Italian welcome. The quality of the competition field, the readiness and the competence of all those who for years work on the events organised in Auronzo di Cadore, the hospitality of the town, are characteristics that will make these European championships unforgettable. -

ALPI GIULIE 107/1 - Anno 2013 CONCORSO FOTOGRAFICO 2012
ALPI GIULIE 107/1 - Anno 2013 CONCORSO FOTOGRAFICO 2012 Anche nel 2012 la Commissione Escursioni ha proposto ai soci un concorso fotografico dal titolo “Le escursioni del 2012”. Sono state presentate una ottantina di opere tra le quali la giuria, composta dai soci Elena Sai, Antonino Schepis e Paola Pesante, ha selezionato e premiato le prime tre immagini classificate in quattro categorie di soggetti: flora, fauna, paesaggio e gitanti. Ad aggiudicarsi il primo premio per la categoria flora è stato Giovanni Tiberio con la foto “purezza”, per la categoria fauna ha vinto Daniela Perhinek con “equilibrismi”, mentre per la categoria paesaggio ha avuto la meglio Livio Marassi con la foto “mondo di ghiaccio” che si è inoltre aggiudicato il primo premio per la categoria gitanti con la foto “bufera”. Ai quattro autori primi classificati sono state assegnate quattro opere grafiche generosa- mente donate da Beatrice Movia. Pubblichiamo in 2a e 3a paginapg di copertina le foto prime cclassificate.lassificate. Giovanni Tiberio Purezza Daniela Perhinek Equilibrismi SOMMARIO Apre il Rifugio “F.lli Nordio e Riccardo Deffar” ............................................ 2 Friuli Mandi, Nepal Namastè – Giorgio Gregorio ......................................... 4 Soci benemeriti ........................................................................ 6 Consiglio Direttivo e Cariche Sociali 2011/2013 .......................................... 7 Relazione morale del Presidente – Mario Privileggi ....................................... 8 Relazione sull’attività dei gruppi nell’anno 2012 – Daniela Candelari ....................... 10 La prima parte dell’Alta Via 1 dal Lago di Braies a San Vito di Cadore – Giuliano Brancolini 39 L’anfi teatro più bello delle “Giulie” – Francesco Blasi ...................................... 45 Le spinte in salita, un ricordo di Antonio Marsi – Flavio Ghio, Lucio Piemontese ............ 50 Tra i monti dello Spitzberg e ritorno attraverso la Lapponia – Enrico Merlak ............... -

Anali Za Istrske in Mediteranske Študije Annali Di Studi Istriani E
Anali za istrske in mediteranske študije Annali di Studi istriani e mediterranei Annals for Istrian and Mediterranean Studies Series Historia et Sociologia, 30, 2020, 1 UDK 009 Annales, Ser. hist. sociol., 30, 2020, 1, pp. 1-176, Koper 2020 ISSN 1408-5348 UDK 009 ISSN 1408-5348 (Print) ISSN 2591-1775 (Online) Anali za istrske in mediteranske študije Annali di Studi istriani e mediterranei Annals for Istrian and Mediterranean Studies Series Historia et Sociologia, 30, 2020, 1 KOPER 2020 ANNALES · Ser. hist. sociol. · 30 · 2020 · 1 ISSN 1408-5348 (Tiskana izd.) UDK 009 Letnik 30, leto 2020, številka 1 ISSN 2591-1775 (Spletna izd.) UREDNIŠKI ODBOR/ Roderick Bailey (UK), Simona Bergoč, Furio Bianco (IT), COMITATO DI REDAZIONE/ Alexander Cherkasov (RUS), Lucija Čok, Lovorka Čoralić (HR), BOARD OF EDITORS: Darko Darovec, Goran Filipi (HR), Devan Jagodic (IT), Vesna Mikolič, Luciano Monzali (IT), Aleksej Kalc, Avgust Lešnik, John Martin (USA), Robert Matijašić (HR), Darja Mihelič, Edward Muir (USA), Vojislav Pavlović (SRB), Peter Pirker (AUT), Claudio Povolo (IT), Marijan Premović (ME), Andrej Rahten, Vida Rožac Darovec, Mateja Sedmak, Lenart Škof, Marta Verginella, Špela Verovšek, Tomislav Vignjević, Paolo Wulzer (IT), Salvator Žitko Glavni urednik/Redattore capo/ Editor in chief: Darko Darovec Odgovorni urednik/Redattore responsabile/Responsible Editor: Salvator Žitko Urednika/Redattori/Editors: Urška Lampe, Gorazd Bajc Prevajalci/Traduttori/Translators: Petra Berlot (it.) Oblikovalec/Progetto grafico/ Graphic design: Dušan Podgornik , Darko -

Radici Profonde
TRIMESTRALE DELLA SEZIONE DI GORIZIA DEL CLUB ALPINO ITALIANO, FONDATA NEL 1883 125 ANNO XLII - N. 1 - GENNAIO-MARZO 2008 “Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - 70% - DCB/Gorizia” In caso di mancato recapito restituire a CAI Gorizia, Via Rossini 13, 34170 Gorizia Anniversari RADICI PROFONDE di MANLIO BRUMATI enticinque anni ci separano da quella domenica del maggio 1983 nella quale abbiamo ce - lebrato i cento anni della no - Vstra sezione. “Festa del socio” aveva - mo voluto chiamarla e, in effetti, di una vera festa si era trattato, con una parte ufficiale dedicata all’intera città di Gorizia concentrata al mattino nella splendida cornice del Castello ed una seconda, al pomeriggio, meno formale e più mirata verso i soci, organizzata all’auditorium Fogar e negli spazi con - termini. In quella sede avevamo pre - miato soci che nel corso degli anni si erano avvicendati nella conduzione della sezione ed altri che si erano di - stinti per particolare impegno a favore del sodalizio. Avevamo pure allestito una mostra, presentando moltissimi documenti e reperti fotografici prove - nienti dal ricco archivio sezionale. Oggi la ricorrenza dei centoventi - cinque anni di vita del C.A.I. Gorizia, mi consente di indulgere su alcuni ri - cordi personali, senza la pretesa di tracciare la storia dei tanti anni vissuti nella sezione, con la consapevolezza di dover tralasciare molti argomenti e con il rimpianto di non poter ricordare tanti amici e consoci. Innanzitutto sento la necessità di esprimere l’orgo - glio di appartenere ad un’associazione che pur partendo da tanto lontano continua ad attrarre sempre nuove fre - quentazioni ed evidenzia un trend di crescita sempre positivo. -

IMP PERMAFROST in Veneto.Indd
IL PERMAFROST IN VENETO: DISTRIBUZIONE, ANALISI E POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI PROGETTO PERMANET - PROGRAMMA ALPINE SPACE PERMAFROST IN THE VENETO REGION: DISTRIBUTION, ANALYSIS AND POTENTIAL ENVIRONMENTAL EFFECTS PERMANET PROJECT - ALPINE SPACE PROGRAMME Regione del Veneto Veneto Region Presidente della Giunta Regionale President of Regional Council Luca Zaia Luca Zaia Assessore all’Ambiente Regional Councillor for the Environment Maurizio Conte Maurizio Conte Assessore all’Economia e Sviluppo, Ricerca e Regional Councillor for the Economy, Innovazione Development, Research and Innovation Marialuisa Coppola Marialuisa Coppola Segreterio Regionale per l’Ambiente Regional Secretariat for the Environment Mariano Carraro Mariano Carraro Dirigente Regionale Direzione Geologia e Geology and Geological Resources Department Georisorse Marco Puiatti Marco Puiatti Geological Service Department Dirigente Servizio Geologico Alberto Baglioni Alberto Baglioni Head of Unit of the Trans-border Cooperation Dirigente Unità di Progetto Cooperazione Project Transfrontaliera Anna Flavia Zuccon Anna Flavia Zuccon Contact Person for the Interregional Alpine Responsabile Programma Interreg Alpine Space Space Programme Alvise Rossi Alvise Rossi Project Manager Progetto PermaNET Project Manager of PermaNET Project Anna Galuppo Anna Galuppo Autori Authors Andrea Crepaz2, Valentina Defendi1, Simone Frigerio3, Andrea Crepaz2, Valentina Defendi1, Simone Frigerio3, Jacopo Gabrieli4, Anna Galuppo1, Laura Magnabosco1, Jacopo Gabrieli4, Anna Galuppo1, Laura Magnabosco1, -

Via Ferratas of the Italian Dolomites: North, Central and East Dolomites V
FREE VIA FERRATAS OF THE ITALIAN DOLOMITES: NORTH, CENTRAL AND EAST DOLOMITES V. 1 PDF Graham Fletcher,John Smith | 320 pages | 30 Sep 2010 | Cicerone Press | 9781852845926 | English | Cumbria, United Kingdom Dolomites via ferratas guidebook - 77 graded routes | Cicerone Press Whilst I will spend many Via Ferratas of the Italian Dolomites: North on the internet planning this holiday I would like to commence with suggestions from locals or people who have 'been there and done that'. Before I ask questions I will provide some background to give some context t to the questions. I am 65 and my husband is We are both quite fit and whilst not risk takers we do like to challenge ourselves and have always loved challenging hikes. Our last two trips have been to Austria and we have fallen in love with Via Ferratas. Definitely cannot do anything with a D overhang. We have done three guided tours and three without a guide. I have my own equipment and my husband will most likely buy his own kit Via Ferratas of the Italian Dolomites: North. Each year we rent a motorhome out of Regensburg for approx. Even though parking can be a challenge in towns, Germany and Austria cater well for motorhomes and by making sure we get to places early we have not really had any problems. Italy may be different though. If we had to do it any other way we would prefer to stay home so no recommendations to hire a car and stay at hotels please. Locations of easy Via Ferratas that we could do without a guide. -
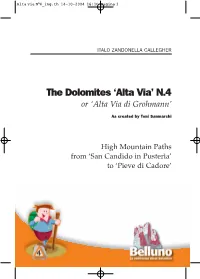
Alta Via 4 Guidebook
Alta via N°4_ing.th 14-10-2004 16:10 Pagina 1 ITALO ZANDONELLA CALLEGHER The Dolomites ‘Alta Via’ N.4 or ‘Alta Via di Grohmann’ As created by Toni Sanmarchi High Mountain Paths from ‘San Candido in Pusterìa’ to ‘Pieve di Cadore’ Alta via N°4_ing.th 14-10-2004 16:10 Pagina 2 Front Cover: From the small Sorapiss lake, dusk over the Tre Sorelle Inside cover 2 The overhanging bow of the Spigolo Giallo di Lavaredo Inside cover 4 The Torre Siorpaès with the Cimon di Croda Liscia (to the right) in the Cadini di Misurina ©2003 Provincial Administration of Belluno TOURISM, RURAL TOURISM AND PRODUCTIVE ACTIVITIES SECTOR Communication and Promotion Service Via Psaro, 21 - 32100 Belluno Tel. 0437.940084 www.infodolomti.it Edition entirely revised and updated By Italo Zandonella Callegher Photos Manrico Dell’Agnola Graphics Luca Celi Printed by Linea Grafica Alta via N°4_ing.th 14-10-2004 16:10 Pagina 3 General notes “The Alta Via n. 4” is dedicated to the great Viennese moun- taineer Paul Grohmann, who was the first man to conquer,just after the middle of the last century, the giant Dolomite peaks on this Alta Via: The Tre Scarpèri, the Croda dei Barànci, the Cima Grande di Lavaredo, the Cristallo, the Sorapiss and the Antelao”. Toni Sanmarchi wrote the above in the preface of his guide “Alta Via di Grohmann n° 4”, published by Tamari of Bologna in 1972 and again in 1976, although it has to be said that Paul Grohmann’s expe- ditions in this area of the Dolomites started well before that, in 1942 to be precise (see Dalle Marmarole al Sorapiss in “The Italian Alpine Club’s monthly magazine” n°1-2, 1946, from page 3 to page 9),when he studied and found that it was actually possible to cross through the “Banco di Sorapiss”, in other words along what is certainly the most challenging stretch of what would become the Alta Via n° 4. -

Stories from the Land Along the Soča Guided Tours Along the Walk of Peace in the Upper Soča Region and to Slavia Veneta
Stories from the land along the Soča guided tours along the Walk of Peace in the Upper Soča Region and to Slavia Veneta Experiencing the transborder nature of the Kolovrat range panorama ¶ The Kolovrat outdoor history classroom; the story of Erwin Rommel; the story of Ernest Hemingway; the panoramic view; flora and fauna; lunch at the typical Slavia Veneta inn ....................................................... The First World War Outdoor Museum Kolovrat Within the framework of its third line of de- fence the Italian army built a whole system of defence- and gun positions and observation posts on the Kolovrat range. Part of the posi- tions on the slope of the hill Na gradu (1115 m) were restored and arranged as an outdoor museum. Opening from the ridge of the Kolovrat range is an exceptional view over the onetime battlefield of the Isonzo Front from Mt. Kanin, over the Krn range to Mt. Sveta Gora; in the opposite direction, the view reaches over the Friuli-Venezia Giulia all to the Adriatic sea. All the time a visitor has a ....................................................... feeling that he/she stands on a privileged van- The story of Ernest Hemingway tage point, at the contact of two completely The worldwide famous American author different worlds, which, however, are strong- chose the Isonzo Front for the place of events ly interdependent and bound to interact. The in his historical novel “A Farewell to Arms”. state border, which for centuries ran along The novel comprises many autobiographical these ridges and shaped the destiny of local elements. Which of them are genuine and population, did not only separate the people which are not? Did the author ever visit the from either side but also connected them due former scene of the Isonzo Front in person or to their common culture, mere survival and didn’t he? How did this literary work con- the proverbial disobedience to remote cen- tribute to better recognisability of the Soča tres of political and economic power.