TER-2017.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Explanatory Notes of the “Giuseppe Sciacca” Foundation
EXPLANATORY NOTES OF THE “GIUSEPPE SCIACCA” FOUNDATION In accordance with its statutory purposes focusing on social solidarity initiatives, the “Giuseppe Sciacca” Foundation has implemented a variety of micro and/or macro projects in various countries. Some of the numerous activities carried out by our Foundation are listed below: support to the Medical Center of excellence Maria Grazia Balducci Rossi Foundation in the Ivory Coast, a relationship of effective collaboration that has been established for years and which dedicates particular attention to minors who receive assistance from the healthcare facility; provision of financial allowances and basic necessities, payment of health expenditure, households etc. to families and individuals who live in a state of poverty; scholarships for young school-aged students or university students who excel in academics without sufficient financial resources; scholarships and financial aids for minors and young adults of the Department of Juvenile Justice and the Penitentiary Administration Department in the context of their respective Memoranda of Understanding; financial support to charitable organizations of various kinds, especially in the case of activities managed by religious entities both in Italy and in various countries of the world. During the course of each year a number of cultural events take place in Rome aiming at social solidarity purposes. It must be mentioned that the events implemented by the Giuseppe Sciacca Foundation are often of international and interdisciplinary scope. The homonymous International Giuseppe Sciacca Award is undoubtedly the best proof and the most important of all. The attention of our organization is particularly directed towards the enhancement of youth and the aid of the most deprived. -
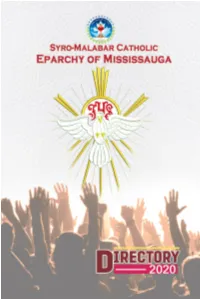
2020 Directory
1 ..................................................................................... PRAYER FOR THE EPARCHY OF MISSISSAUGA God our loving Father, we praise and thank you for the establishment of the Eparchy of Mississauga. Pour out your Spirit, endue with the choicest heavenly blessings and all the necessary graces and gifts of the Holy Spirit on all of us to build up the Syro-Malabar Church in Canada, for the Glory of God. In the name of Jesus we ask you to send your Spirit on our Bishop, Priests, Religious and all Men and Women, Young and Old to respond to your call for renewing the families and building up the community. Holy Mary, Mother of God, Pray for us. St. Joseph, patron of Canada, Pray for us St Thomas, Patron of our Eparchy, Pray for us. 2 3 ST. THOMAS PATRON OF THE EPARCHY 4 His Holiness Pope Francis.......................................................................... 5 The Catholic Church ................................................................................... 8 State of Vatican City ................................................................................... 10 The Roman Curia ........................................................................................ 11 His Excellency the Most Reverend Luigi Bonazzi ................................. 15 Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB)............................. 16 Episcopal Commissions and Standing Committees ............................. 18 Ecclesiastical Jurisdictions .......................................................................... -

“God Country Family Inc.”
“GOD COUNTRY FAMILY INC.” By Giorgio Mottola Consultant Andrea Palladino With the contribution of Norma Ferrara – Simona Peluso Video by Davide Fonda – Tommaso Javidi Editing and graphics by Giorgio Vallati POPE FRANCIS - URBI ET ORBI BLESSING 27 MARCH 2020 Omnipotent and merciful God, behold our painful condition, comfort your children and open up our hearts to hope. GIORGIO MOTTOLA VOICEOVER Under a gloomy sky covered by heavy rain clouds, for the first time in history a Pope spoke in front of a totally empty Saint Peter’s square. POPE FRANCIS - URBI ET ORBI BLESSING 27 MARCH 2020 We didn’t listen to the cries of the poor and of our gravely ill planet. We continued undeterred, believing we would always remain healthy in a sick world. GIORGIO MOTTOLA VOICEOVER In the midst of the pandemic, the Pope granted plenary indulgence to the world's faithful. But in some Catholic circles, the Pope himself is seen as the very cause of Coronavirus. JOHN-HENRY WESTEN - DIRECTOR, LIFESITENEWS Is it possible to imagine that, at least in part, this epidemic is a consequence of the Pope’s betrayal of our Lord? GIORGIO MOTTOLA VOICEOVER Basically, God would have used Coronavirus to punish mankind for the Pope’s betrayal. So says the director of Lifesitenews, one of the world’s most popular ultra-Catholic websites. JOHN-HENRY WESTEN - DIRECTOR, LIFESITENEWS The pontiff has authorised sacrilegious communions, granting the holy Eucharist to people who have divorced or remarried. Such a profanation of the holy communion has a direct link with divine punishment. GIORGIO MOTTOLA VOICEOVER This theory was promoted for weeks by dozens of ultra-Catholic websites and by several American internet preachers. -

The Holy See
The Holy See ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI TO THE GENDARMERIE AND THE FIRE BRIGADE OF THE VATICAN CITY STATE Clementine Hall Friday, 11 January 2013 Mr Commandant, Dear Officials, Commissioners and Inspectors, Dear Gendarmes and Firemen, I am very pleased to welcome you today to the Apostolic Palace and to spend this moment with all of you who serve the Successor of Peter, offering your valuable service in Vatican City State, day and night. I greet you with deep cordiality, starting with Dr Domenico Giani, your Commandant whom I thank for his words expressing your sentiments, outlining the intentions that motivate your commitment. I address my grateful thoughts to Cardinal Giuseppe Bertello and to Bishop Giuseppe Sciacca, respectively President and Secretary General of the Governorate, who never let the Gendarme Corps or the Fire Brigade go without the necessary support. I warmly greet Cardinal Tarcisio Bertone, my Secretary of State, and thank him for coming to this meeting. I address a word of appreciation also to Fr Gioele Schiavella and Fr Sergio Pellini, for their ministry on behalf of the spiritual development of the whole of the Gendarme Corps. I offer a very affectionate greeting to each one of you, dear Gendarmes! This occasion gives me the opportunity to express to you my deep esteem, my warm encouragement and especially my profound gratitude for the generous service you carry out with discretion, competence, and efficiency and not without sacrifice. Almost every day I have the opportunity to meet some of you on duty at various posts and to note personally your professional cooperation to guarantee the surveillance of the Pope, as well as the necessary order and safety of those who live in the State 2 or who are taking part in the celebrations and meetings held at the Vatican. -

IUS ECCLESIAE Direttore Joaquín Llobell Segretario Di Redazione Jesús Miñambres Direttore Responsabile Davide Cito *
IUS ECCLESIAE Direttore Joaquín Llobell Segretario di redazione Jesús Miñambres Direttore responsabile Davide Cito * La redazione di « Ius Ecclesiae » è curata dai docenti della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce Via dei Farnesi 82, I 00186 Roma, tel. +39 06 68164500, fax +39 06 68164600, [email protected] * Nihil obstat : J. T. Martín de Agar Imprimatur : Vicariato di Roma Roma, 21 settembre 2011 Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 29 del 3 luglio 2007. issn 1120-6462 issn elettronico 1972-5671 Rivista associata all’Unione Stampa Periodica Italiana. * Le opinioni espresse negli articoli pubblicati in questa rivista rispecchiano unicamente il pensiero degli autori. Si invitano gli autori ad attenersi, nel predisporre i materiali da consegnare alla redazione e alla casa editrice, alle norme specificate nel volume Fabrizio Serra, Regole editoriali, redazionali & tipografiche, Pisa · Roma, Serra, 20092. IUS ECCLESIAE RIVISTA INTERNAZIONALE DI DIRITTO CANONICO VOL. XXIII · N. 2 · 2011 PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE FABRIZIO SERRA EDITORE PISA · ROMA Rivista quadrimestrale * Amministrazione e abbonamenti Fabrizio Serra editore S.r.l. Casella postale n. 1, Succursale n. 8, I 56123 Pisa, [email protected] Uffici di Pisa : Via Santa Bibbiana 28, I 56127 Pisa, tel. +39 050 542332, fax +39 050 574888, [email protected] Uffici di Roma : Via Carlo Emanuele I 48, I 00185 Roma, tel. +39 06 70493456, fax +39 06 70476605, [email protected] * I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o Online sono consultabili presso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net Print and/or Online official subscription rates are available at Publisher’s web-site www.libraweb.net. -

Vol. VI, N. 1, Febbraio 2020
JUS- ONLINE 1/2020 ISSN 1827-7942 RIVISTA DI SCIENZE GIURIDICHE a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano INDICE N. 1/2020 RENATO BALDUZZI 1 La posizione costituzionale del Csm tra argomenti di ieri ed effettività dell’organo GIUSEPPE SCIACCA 21 Il Tribunale Ecclesiastico a servizio del matrimonio e della famiglia GERALDINA BONI 31 Sigillo sacramentale, segreto ministeriale e obblighi di denuncia- segnalazione: la ragioni della tutela della riservatezza tra diritto canonico e diritto secolare, in particolare italiano TOMMASO GAZZOLO 223 Minority Report e il crimine senza crimine GIANPIERO MANCINETTI 251 La tutela in rem e il iudicium in factum contro il venditore VINCENZO FERRANTE 289 Potere di controllo e tutela dei lavoratori: riflessioni sparse sulle disposizioni dello “Statuto”, alla luce delle più recenti modifiche VP VITA E PENSIERO JUS- ONLINE 1/2020 ISSN 1827-7942 RIVISTA DI SCIENZE GIURIDICHE a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano RENATO BALDUZZI Professore ordinario di diritto costituzionale, Università Cattolica del Sacro cuore La posizione costituzionale del Csm tra argomenti di ieri ed effettività dell’organo* English title: The constitutional position of Italian High Council of the Judiciary, between traditional doctrinal opinions and effectiveness DOI: 10.26350/18277942_000001 Sommario: Premessa. 1. Sessant’anni di ricostruzioni del modello italiano di Consiglio superiore (e di magistratura). 2. L’effettività del Consiglio superiore come inveramento del modello costituzionale (e alcuni suggerimenti per migliorarla). Conclusioni. Premessa Da molti mesi, a seguito dello “scandalo romano”1 che ha visto interessati ex-componenti di estrazione togata del Consiglio superiore della magistratura e che ha indotto alle dimissioni alcuni suoi componenti in carica nella consiliatura attuale (anch’essi magistrati), il Csm è oggetto di attenzione costante da parte dei mezzi di informazione. -
L'o S S E Rvator E Romano
Price € 1,00. Back issues € 2,00 L’O S S E RVATOR E ROMANO WEEKLY EDITION IN ENGLISH Unicuique suum Non praevalebunt Fifty-third year, number 42 (2.668) Vatican City Friday, 16 October 2020 Go d’s door is always open to our cry of suffering The Holy Father continues his series of catecheses on prayer reflecting on the Psalms E D I T O R I A L ‘Fratelli Tutti’, even those considered ‘too many’ ANDREA MONDA The text of the Encyclical Letter Fratelli Tutti, Pope Francis’ t h i rd , published on 4 October, has fore- seeably evoked a series of assor- ted, very diverse reactions. There is also word arriving from over- seas that cannot be defined as a “re a c t i o n ” but rather as a symp- tom of how greatly we need the very meaning of fraternity to be rediscovered today, even in its strictest, most literal sense. It is a publicity campaign that can be seen in this period along streets and on the walls of buildings in Canada and the USA, and which calls attention to a mentality, a world view shaped by the closure generated by a fear of “otherness” and by a lack of confidence that the Pope’s text invites us to over- come, with a “heart open to the whole world”, as stated in the title of the fourth chapter of Fratelli Tutti. The theme ad- dressed by the OnePlanetOneCh- ild association is precisely that of fraternity, seen in very simple terms (after all, this is the aim of CONTINUED ON PA G E 4 To Women’s Consultation Group Protagonists of a Church PAGE 5 To Global Compact on Education To educate is an act of hope FOR THE HO LY FAT H E R ’S C AT E C H E S I S SEE PA G E 3 PAGE 6/7 page 2 L’OSSERVATORE ROMANO Friday, 16 October 2020, number 42 the titular see of Nomentum. -
Rockford Observer
ISSN: 0029-7739 $ 1.00 per copy THE OBSERVER Official Newspaper of the Catholic Diocese of Rockford Volume 78 | No. 36 http://observer.rockforddiocese.org FRIDAY SEPTEMBER 6, 2013 Diocese Announces Changes in Administration THE OBSERVER made to combine our offi ces of Family Life, Pro-Life and DIOCESE—Changes are N.F.P. into one collaborative coming to the Diocese of Rock- mission,” Msgr. Nelson wrote. Offi cial Appointments ford, both in personnel and in “This effort to combine of- some of the diocesan structures. The Rev. Kenneth J. Ander- fi ces and to unify our consistent son — Pastor of St. Thomas In an Aug. 27 announce- ethic of Life was made to fortify Aquinas Parish, Freeport, Illi- ment to diocesan staff, Msgr. this message by not only coordi- nois, to be also Vicar Forane for Glenn Nelson, Vicar General nating the vision and efforts, but the Freeport Deanery, effective and Moderator of the Curia, ex- also to emphasize the intercon- August 28, 2013. plained some of those changes. The Rev. John E. Gow — to nectedness between Life, Mar- be Parochial Vicar for St. John One of the major changes is riage, Natural Family Planning, Neumann Parish, St. Charles, the restructuring of the Family Evangelization and all the ef- Illinois, effective September 1, Life and Pro-Life offi ces into forts that were, in the past, done 2013. one offi ce to be known as the separately,” he explained. Collins Mendoza Given at the Chancery, Life and Family Evangelization This restructuring will mean Aug. 30, 2013 (LiFE) Offi ce. -

Title: Dobro Małżonków : Identyfikacja Elementu Ad Validitatem W Orzecznictwie Roty Rzymskiej
Title: Dobro małżonków : identyfikacja elementu ad validitatem w orzecznictwie Roty Rzymskiej Author: Andrzej Pastwa Citation style: Pastwa Andrzej. (2016). Dobro małżonków : identyfikacja elementu ad validitatem w orzecznictwie Roty Rzymskiej. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Dobro małżonków Identyfikacja elementu ad validitatem w orzecznictwie Roty Rzymskiej NR 3484 Andrzej Pastwa Dobro małżonków Identyfikacja elementu ad validitatem w orzecznictwie Roty Rzymskiej Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2016 Redaktor serii: Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Józef Budniak Recenzent Wojciech Góralski Spis treści Wstęp . 7 1 . Kryteria waloryzacji formuły bonum coniugum . 13 1 .1 . Przesłanki genetyczno-historyczne . 13 1 .1 .1 . „Personalistyczna” geneza kodeksowego pojęcia bonum coniugum . 16 1 .1 .2 . Kontekst reformy KPK: od ius ad vitae communionem do essentiale aliquod elementum . 28 1 .1 .3 . Ku wyodrębnieniu istotnego elementu małżeństwa: dwie optyki . 39 1 .1 .3 .1 . Oś problemowa: ordo procreationis — ordo caritatis (Ombretta Fumagalli Carulli) . 40 1 .1 .3 .2 . Oś problemowa: sfera „przedmiotowa” — sfera „osobowa i międzyosobowa” (José María Serrano Ruiz) . 54 1 .2 . Przesłanki epistemologiczno-metodologiczne . 68 1 .2 .1 . Problem bonum coniugum a paradygmat „jedności hermeneutycznej” 71 1 .2 .1 .1 . Znaczenie specjalnego magisterium papieskiego: Przemówienia do Roty Rzymskiej . 72 1 .2 .1 .2 . Wzorcowy charakter orzecznictwa Roty Rzymskiej . 81 1 .2 .1 .3 . Normy i deklaracje wydane przez inne dykasterie Kurii Rzymskiej . 90 1 .2 .2 . Problem bonum coniugum a paradygmat „realizmu” (odnowionej) doktryny małżeńskiej . 95 1 .2 .2 .1 . Niekompatybilność ujęć subiektywistyczno-pozytywistycznych . 97 1 .2 .2 .2 . „Uznana doktryna” reprezentantów personalistycznego nurtu odnowy ius matrimoniale . 103 1 .2 .2 .3 . Adekwatna oś problemowa: realizm personalistyczny — realizm jurydyczny (Carlos José Errázuriz Mackenna) . -
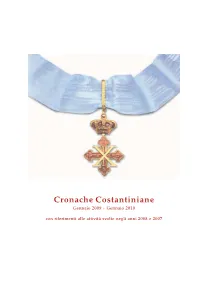
Cronache Costantiniane
Cronache Costantiniane Gennaio 2009 - Gennaio 2010 con riferimenti alle attività svolte negli anni 2008 e 2007 La presente Pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo dei Cavalieri Costantiniani: S.E. Ambasciatore Nobile Giuseppe Balboni Acqua Cavaliere di Gran Croce di Grazia Segretario Generale e Delegato per le Marche e l’Umbria Avvocato Prof. Franco Ciufo Cavaliere di Gran Croce di Merito Vice Delegato per il Lazio Avvocato Prof. Antonio Maria Leozappa Commendatore di Merito This pubblication has been realized thanks to the contribution of the following Constantinian Knights: HE Ambassador Sir Giuseppe Balboni Acqua Knight of Grand Cross of Grace Secretary General and Delegate for Marche and Umbria Regions Prof. Franco Ciufo, Lawyer Knight of Grand Cross of Merit Vice Delegate for Latium Region Prof. Antonio Maria Leozappa, Lawyer Commander of Merit Editoriale A tre anni di distanza dall’ultimo bollettino ufficiale, le Cronache Costantiniane riprendono la loro testimonianza delle iniziative dei Cavalieri e delle Dame del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. E’ un’illustrazione di opere, attività, realizzazioni ed anche di propositi, con immagini fotografiche che talvolta esprimono, con maggiore efficacia dello scritto, il significato profondo dell’azione svolta. Il nuovo Gran Maestro del Sacro Ordine, il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro e la Principessa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Castro che è l’ispiratrice dell’azione umanitaria dell’Ordine, hanno indicato con forme rinnovate, adeguate ai tempi odierni, le tradizionali linee direttrici per il perseguimento delle finalità dell’Ordine. Le Cronache Costantiniane assicurano un’informazione ampia delle principali attività del Gran Magistero dell’Ordine fornendo anche un compendio delle comunicazioni provenienti dalle Delegazioni, non solo italiane, sulle iniziative promosse in sede locale. -

Diocesan Directory 2017
THE EPARCHY OF PALGHAT (Regd 108 of 1976) (Estd 1974) Directory2017-18 BISHOP’S OFFICE P.B. No.4, Noorani P.O., Vennakkara- 678 004 Palakkad, Kerala, India. Phone : 0491-2515277, 2526583 (Sec.), 2504583 (V.G.), 2525129 (Bp) E-mail : [email protected] Website : www.palghatdiocese.org 2017 Eparchy of Palghat Directory 2017-18 Published by Eparchial Curia Bishop's House P.B. No. 4, Noorani P.O. Vennakkara, Palakkad- 678 004. Edited by Fr. Aji Aikkara Page Layout Jobin Baby Data Updated as on 08th September 2017 Printed at Jim Offset, Palakkad INDEX GENERAL INFORMATIONS The State of Vatican City........................................................................11 The Church in Asia - FABC....................................................................17 The Church in India................................................................................18 Three Episcopal Bodies.........................................................................20 Common Ventures .................................................................................21 Office of the CBCI..................................................................................24 The Catholic Church in Kerala...............................................................26 The Syro-Malabar Church......................................................................31 The Major Archbishop............................................................................32 The Syro-Malabar Major Archiepiscopal Church at a Glance................33 A Brief History .......................................................................................34 -

The Meeting of the Major Superiors of the Order – 22 June 2018 A
Cover: The meeting of the major Superiors of the Order – 22 June 2018 A SHINING EYE AND A DARK EYE By Msgr. Slađan Ćosić Chargé d’affaires of the Apostolic Nunciature in China Meeting of the Major Superiors of the Camillians, Lotung, 22 June 2018 Homily at the Holy Mass (cf. Readings: 2 Kings 11:1-4,9,18,20; Psalm 131; Matthew 6:19-23) Dear Fr. Leocir Pessini, Superior General of the Camillians, Dear Provincial Superiors, Dear Fr. Giuseppe, I would like to thank you cordially for your invitation to preside over this celebration of the Eucharist and for the opportunity to meet the Provincial Superiors of the great family of St. Camillus which is guided by your Superior General. I greet you fraternally with the hope that this celebration will be an opportunity to strengthen your communion, to renew your missionary commitment and to pray for each other. Today’s gospel is divided into two short parts in which Jesus offers us two simple lessons which are very important for our Christian lives and for our religious and priestly ministry. Let us try to see, briefly, these lessons of life, taking the text in our hands. To begin with, the Lord gives us some advice: ‘Do not lay up for yourselves treasure on earth’ (Mt 6:19). This is very simple advice, involving prudence: do not waste time accumulating what is of no use! There are in particular three treasures of the earth that Jesus warns us about on a number of occasions (cf. Pope Francis, homily of 20 June 2014).