Le Ferite Del Piave. Tra Danni E Ricostruzione
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lasciamo Il Segno"
Aderenti alla Rete "Lasciamo il Segno" Azienda ULSS2 MARCA TREVIGIANA Provincia di Treviso Città di Treviso Città di Motta di Livenza Coordinamento delle Associazioni di Ufficio Scolastico Territoriale Treviso Volontariato della Provincia di Treviso Postural Project - Centro di Medicina Fisica Coni Comitato Provinciale Treviso e Riabilitativa Comune di Arcade Comune di Breda di Piave Comune di Carbonera Comune di Casale sul Sile Comune di Casier Comune di Cessalto Comune di Chiarano Comune di Cimadolmo Comune di Fontanelle Comune di Gorgo al Monticano Comune di Istrana Comune di Mansuè Comune di Maserada sul Piave Comune di Meduna di Livenza Città di Mogliano Veneto Comune di Monastier Comune di Morgano Comune di Oderzo Comune di Ormelle Comune di Paese Comune di Ponte di Piave Comune di Ponzano Veneto Comune di Portobuffolè Comune di Povegliano Città di Preganziol Comune di Quinto di Treviso Città di Roncade Comune di Salgareda Comune di San Biagio di Callalta Comune di San Polo di Piave Comune di Silea Comune di Spresiano Città di Villorba Comune di Zenson di Piave ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Comune di Zero Branco Protezione Ambientale del Veneto Ente Parco Regionale del Fiume Sile Ospedale Riabilitativo di Motta di Livenza UTAP - Unità Territoriale di Assistenza Primaria - Associazione Sportiva Dilettantistica Ponzano Veneto STRADA FACENDO CRAL - Circolo Ricreativo Aziendale Atlantic Sport - Società Sportiva Dilettantistica Dipendenti Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino CONTARINA spa Treviso 3 Ordine Provinciale -

COMUNICATO STAMPA Treviso, 31 Marzo 2021
COMUNICATO STAMPA Treviso, 31 marzo 2021 VACCINAZIONE CON ACCESSO LIBERO DELLA CLASSE 1935 A CASTELFRANCO SARA’ SPERIMENTATO IL DRIVE-IN Sospesa la vaccinazione degli accompagnatori (n. 62/2021) Sarà sperimentata anche la vaccinazione in modalità drive-in nel corso del Vax Day di sabato 3 aprile, riservato alla classe del 1935. Il drive-in sarà attivo nel parcheggio della discoteca Melodi, a Castelfranco, e sarà riservato, esclusivamente, agli 86enni residenti nei comuni di Castelfranco Veneto, Altivole, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X e Vedelago, per un totale di 419 persone che saranno avvisate dai rispettivi Comuni. I restanti cittadini residenti nel Distretto di Asolo faranno riferimento per la vaccinazione, invece, al Centro Polifunzionale di Vidor. Riepilogando le sedi vaccinali in cui gli 86enni potranno recarsi sabato 03 aprile sono le seguenti: - CVP di Oderzo “Foro Boario”: per i residenti nei Comuni dell’area Opitergino-Mottense - CVP di Villorba “Bocciodromo”: per i residenti nei Comuni dell’area di Treviso - CVP di Godega di Sant’Urbano “Campo Fiera”: per i residenti nei Comuni dell’ex Ulss 7 - CVP drive-in nel park discoteca Melodi: per i residenti nei Comuni di Castelfranco Veneto, Altivole, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X e Vedelago - CVP di Vidor Centro Polifunzionale: per i residenti nei Comuni dell’ex Ulss 8 non rientranti tra quelli ammessi al drive-in. Di seguito l’elenco dei Comuni di riferimento dei cinque Centri vaccinali suindicati: Comuni dell’area Opitergino Mottense: Cessalto – -

COMUNE DI REFRONTOLO Provincia Di Treviso
COMUNE DI REFRONTOLO Provincia di Treviso C O P I A Deliberazione n. 56 Data 30-12-2016 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2017 - 2019. L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 20:30 a seguito di inviti scritti diramati in tempo utile e regolarmente notificati al domicilio di ciascun Consigliere, come da dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello, risultano presenti: Collodel Loredana P Teo Barbara P Bernardi Luca P Foltran Cristina P Lorenzon Pasquale P Collodel Roberto P Cadamuro Elisabetta P Canal Mauro P Tittonel Fabio P De Stefani Roberto A Antoniazzi Nicola P (P)resenti n. 10. ( A)ssenti n. 1 Assiste il Segretario Comunale Comunale Nadalin Daniela Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Collodel Loredana , nella sua qualità di Sindaco e, dichiarata aperta la seduta, ed espone l’oggetto all’ordine del giorno: su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: Il Sindaco Presidente invita il Revisore dei Conti, dott. Permunian Stefano, ad accomodarsi al tavolo del Consiglio. Propone quindi di trattare congiuntamente i punti 6 e 7 dell’Ordine del Giorno, in quanto strettamente correlati, salvo poi procedere con votazioni separate. IL CONSIGLIO COMUNALE UDITA la relazione tecnica del Revisore dei Conti, dott. Permunian Stefano, integralmente riportata a verbale; RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati), che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; VISTO l’art. -

The Walled Cities
(C) THE WALLED CITIES Even now, on visiting the historical centre of This gives it the peasant and very sweet Treviso , one can well understand how, since impression of a city whose history flows with the most ancient times, its inhabitants were the River that crosses it. In Roman times, closely bound to the surrounding landscape the layout of Tarvisium, which was made a and fully exploited the potential offered by the municipium and assigned to the Claudia tribe, nature of the place. The earliest settlement was followed the two main roads that crossed to established in the 14th to 13th century BC, on a form a quadruvium, as testified to by a wall fluvial island in the River Sile, before expanding mounted stone plaque on the south side of the over the centuries to the surrounding areas in Baptistery, to the left of the Cathedral. On the part made inhabitable by reclamation work. north façade, this construction, which was built Until recently, the River was an important in the 11th and 12th century also maintains trading and communication route that a Roman funeral stele, in line with that 20 connected directly with the Adriatic Sea. somewhat frequent taste of using historical St Tomaso gate (Treviso) Fadalto Nove Botteon Savassa BassaSonego Osigo Passo San Boldo Luca PROVINCE OF Longhere Breda Mezzavilla Pra De Radego Revine LagoSerravalle Fregona Montaner BELLUNO S. Maria Olarigo Fratte Lago Borgo VillaCosta Anzano Rugolo Nogarolo Caiada Sarmede Sotto Croda Colmaggiore VITTORIO VENETO Palu' Tovena Ceneda Alta Cappella Maggiore Soller -

Relazione Previsionale E Programmatica -.:: Comune Di San
Comune San Fior Provincia di Treviso RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2016 - 2017 Pag. 1 INDICE GENERALE Sommario SEZIONE 1 – CARATTERISTICHE GENERALI ............................................................................................................................................................................... 3 1.1 Popolazione .................................................................................................................................................................................................................................... 4 1.2 Territorio ......................................................................................................................................................................................................................................... 6 1.3.1 - Personale ................................................................................................................................................................................................................................... 7 1.3.2 - Strutture ..................................................................................................................................................................................................................................... 9 1.3.3 - Organismi Gestionali ............................................................................................................................................................................................................ -

Formato Europeo Per Il Curriculum Vitae
CURRICULUM VITAE dal 30/09/2019 INFORMAZIONI PERSONALI Nome FORLIN LUIGIA MARIA Data e luogo di nascita 13 marzo 1963 – Mansuè (TV) Qualifica SEGRETARIO GENERALE di fascia professionale A (cod. 2587) Amministrazione MINISTERO DELL’INTERNO- ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Incarico attuale SEGRETARIO REGGENTE DEL COMUNE DI SALGAREDA (TV) A T. P. Numero Telefonico Cellulare personale 339 1262939; E-mail [email protected] TITOLI DI STUDIO PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE Titolo di studio LAUREA in Scienze Politiche conseguita presso l’Università degli Studi di Padova in data 18.11.1986 con punti 110/110 e lode; Altri titoli di studio e professionali IDONEITA’ a Segretario generale conseguita con punti 27/30 a seguito di corso di specializzazione “SEFA 2 bis”, di cui all’art. 14, co.2, del D.P.R. n. 465/1997, ed iscrizione alla fascia professionale A (ai sensi dell’art. 31, co. 1, del CCNL Segretari sottoscritto il 16.05.2001), con decorrenza dal 5.10.2004; IDONEITA’ a Segretario generale per ricoprire sedi di segreteria di Comuni con popolazione superiore a 10000 e sino a 65000 abitanti, conseguita con punti 29/30 a seguito di corso di specializzazione tenutosi nell'anno 2000; ABILITAZIONE all’ insegnamento per la classe XXVI di concorso – Discipline giuridiche ed economiche, conseguita con punti 69/80 a seguito di concorso ordinario indetto con D.M. 23.3.1990; DIPLOMA del corso di studio per aspiranti segretari comunali conseguito nell’ a.a. 1987/1988 conseguito con punti 50/60; Esperienze professionali Incarichi ricoperti con la qualifica di Segretario comunale/generale titolare dei Comuni di: CURTAROLO - SANTA GIUSTINA IN COLLE - CAMPO SAN MARTINO (PD), convenzione di cl. -

14.12.2011 Categoria Ragazze
GSS 2011-2012 PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE Valdobbiadene - Villa dei Cedri –14.12.2011 CATEGORIA RAGAZZE PUNTI ATLETA S CUOLA 1 MARRAFFA JESSICA VEDELAGO 2 MORO FEDERICA BREDA DI PIAVE 3 TIEPPO LINDA EFREM REATTO 4 BIANCO VERDIANA BRUSTOLON 5 PASA FRANCESCA GIOVANNI XXIII 6 MARCHESI ALESSANDRA ASTORI 7 LUCHESCHI COSTANZA COLLE UMBERTO 8 TUAN CAMILLA BRUSTOLON 9 GATTAGRISA CHIARA TOTI DAL MONTE 10 TUBIANA ELEONORA SERENA 11 MATURI VALENTINA V. U.COSMO 12 FALDON LISA VAZZOLA E MARENO 13 CESCHIN FRANCESCA L.DA PONTE 14 BAZZACCO ROBERTA GIOVANNI XXIII 15 RUZZIER ELENA QUINTO 16 MORETTON MICHELA SUSEGANA 17 DARIO ANGELA CODOGNE' 18 MARCOLIN ANNA GIOVANNI XXIII 19 SANGION ANNA ASTORI 20 FRANCESCHIN ELISA EFREM REATTO 21 CASAGRANDE ALICE U.COSMO 22 MILICEVIC GLORIA CASTELFRANCO 2 23 ZANCO ARIANNA RONCADE 24 SEGATTO MATILDE STEFANINI 25 CARRARA MARTINA EFREM REATTO 26 BONROY KALE' ASTORI 27 PERALCOLLE GIORGIA RESANA 28 SCHIAVINATO ALESSIA SALGAREDA 29 DE MARTIN MADDALENA GAIARINE 30 BRESSAN BEATRICE GAIARINE 31 TODOVERTO ALICE EFREM REATTO 32 KOUAME ROXANE CARBONERA CATEGORIA RAGAZZI PUNTI ATLETA S CUOLA 1 MASETTO SIMONE L.DA PONTE 2 DIOUF ALLIOU SAN ZENONE D.EZZELINI 3 CAPOVILLA FRANCESCO EFREM REATTO 4 SLIMANE ABDERAHMEN ASOLO/CASTELCUCCO 5 GALLINA GIULIO CAERANO S.M. 6 BARZOTTO ANDREA U.COSMO 7 BRUNELLO MATTIA QUINTO 8 DE TOTTO ANDREA MARTINI 9 FELETTO TIZIANAO CODOGNE' 10 BALDISSIN CRISTIAN MARTINI 11 DANCI BODGAN ASOLO/CASTELCUCCO 12 SERAFIN ALEX CORDIGNANO 13 BONDI' JACOPO TOTI DAL MONTE 14 GUERRA SIMONE PONTE DI PIAVE 15 FAVERO THOMAS U.COSMO -

Parere Comune Di Salgareda
COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PARERE n. 41 de l7 Maggio 2012 (o.d.g. 5 del l7 Maggio 2012) OGGETTO: Comune di Salgareda (TV). Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio. PREMESSO CHE – ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE, i Comuni, le Province e la Regione, nell’ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, devono provvedere alla valutazione ambientale strategica (VAS) dei loro effetti sull’ambiente al fine di “promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente”; – La Commissione Regionale VAS, individuata ex art.14 della LR n.4/2008, si è riunita in data 17 maggio 2012 come da nota n. 221433 del 14.05.2012 del Dirigente della Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV), segretario della commissione; – Il Comune di Salgareda (TV) con note n. 5577 del 10.06.11, n. 12232 del 02.01.12, n. 1938 del 27.02.12, n. 4134 del 04.05.12 e con e-mail del 14.05.12 ha fatto pervenire la documentazione necessaria per ottenere il parere della Commissione VAS; − ITER PROCEDURALE PER LA VAS DEL PAT Il Comune di Salgareda ha approvato con DGC n. 12 del 28.02.07 il “Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione”, ai sensi dell’art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale. Lo schema di accordo di pianificazione è stato, in seguito, riapprovato con DGC n. -

Logistics of Vine-Shoots Harvesting in Treviso Province
UNIVERSITY OF PADUA COLLEGE OF AGRICULTURE Department of Land, Environment, Agriculture and Forestry Logistics of vine-shoots harvesting in Treviso province Supervisor: Professor Raffaele Cavalli Co-supervisor: Dr. Stefano Grigolato MSc student: Matteo Albergucci 607067-AB ACADEMIC YEAR 2010-2011 2 3 Acknowledgments I would like to warmly thank all the people that made this work possible, and who have accompanied me along this path. My precious family, and all my special friends and pals here at the university and outside in everyday life, near and far. Professor Raffaele Cavalli for being my supervisor along these years, and doc. Stefano Grigolato, for his needful support; thanks also to the team of forest operations management, of whom I do not remember the name. I am very grateful to Nicola Breda, which has been an invaluable companion for this work: thanks mate, enjoy your Erasmus! I wish to thanks also all the kind people in the farms that allowed us to made our research, and sometimes offered us a drink. I would like to thanks everyone who were involved, but I know I won’t remember all the names: may they know they are in my mind. To everyone I forgot to mention: sorry, you are in my heart. I think it’s all, just a thing more... “Avete ragione di parlare di "inferno", giacché da quando vi ho lasciato, vivo in una specie di inferno intellettuale, ossia in un paese ove l'intelligenza e la scienza sono reputate cose infernali da chi ha la bontà di governarci”. Camillo Benso, conte di Cavour; da una lettera a De La Rive Happy Birthday, Italy Conegliano, March 18th, 2011 4 5 INDICE 1 Background ..................................................................................8 1.1 The rule of the wood biomass for energy production ..............................8 1.2 The energy utilization of vine-shoot ..................................................9 1.3 Objectives ............................................................................. -
Comuni Di CHIARANO • ISTRANA • PORTOBUFFOLÈ QUINTO DI
Comuni di CHIARANO • ISTRANA • PORTOBUFFOLÈ QUINTO DI TREVISO • SALGAREDA VEDELAGO • VOLPAGO DEL MONTELLO X VOLPAGO DEL MONTELLO Venerdì 15 giugno Area retrostante Municipio (Maltempo: Teatro Parrocchiale Venegazzù) SIOR TODERO BRONTOLON di Goldoni Associazione Culturale IL SATIRO TEATRO Compagnia RINASCITA INFORMAZIONI: 347/1524429 [email protected] – www.omonero.it INIZIO SPETTACOLI: ore 21.15 PREZZI INGRESSO: (ove non diversamente specificato nell’evento) INTERO 8 – RIDOTTO 6 eurekip nave pier eurekip Per alcuni spettacoli sono indicate modalità di prevendita. Apertura Cassa nel luogo di spettacolo: ore 20.00 L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al programma le variazioni che si rendessero necessarie per esigenze tecniche e cause di forza maggiore. “...son paron dei fioi, e son paron dela nezza, e dela dota e dela casa, e de tuto quelo che vogio mi…” In questa straordinaria battuta di Todero, sono racchiuse tutte le indicazioni per la regia, per gli attori e per il pubblico. Goldoni ben sapeva che tratteggiando un tal carattere avrebbe condotto gli spettatori oltre l’intreccio della commedia, oltre la trama, al di là delle preoccupazioni di Marcolina che vuole sposare sua figlia Zanetta con un buon giovane, a dispetto del nonno che la vuole maritare con il figlio del fattore per garantirsi la servitù gratuitamente, al di là anche delle speranze della servetta Cecilia che rischia di perdere l’occasione buona per maritarsi. La storia diventa pretesto per questo grande vecchio che tiranneggia tutta la casa, anche quando non è presente in scena. Della trama Todero non ne ha bisogno, perché lui è …Todero, e tanto basta! Ingresso: Intero € 8 – Ridotto € 6 3 VEDELAGO Sabato 16 giugno Località FANZOLO - VILLA EMO (Maltempo: Teatro Sanson Vedelago) IL MALATO IMMAGINARIO di Marco Zoppello da Molière STIVALACCIO TEATRO & TEATRO STABILE DEL VENETO 17 febbraio 1673. -

SUAP Informazioni
SUAP informazioni Rassegna delle principali novità normative di interesse per lo Sportello Unico delle Attività Produttive n.2 Gennaio 2018 NOVITA' Il Comune di Treviso ha approvato le modifiche al Protocollo d’intesa dell’Organismo di Gestione della Destinazione (OGD) delle Città d’arte e Ville venete del territorio trevigiano e relativo Regolamento con deliberazione di Consiglio n. 71 del 20 dicembre 2017, consultabile sul sito del Comune al seguente indirizzo: http://www.comune.treviso.it/delibere/dettaglio? openagent&nodo=1.1.1&uid=394E5DF2DA16FA78C125820F0038C7E0 Di seguito potete consultare il nuovo Protocollo d'intesa e il relativo Regolamento. Prot. n. PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE DELL'OGD CITTA' D'ARTE E VILLE VENETE DEL TERRITORIO TREVIGIANO PREMESSO che: • in data 3 luglio 2013 è entrata in vigore la Legge Regionale 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” che rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo nel Veneto; • punto saliente della nuova normativa è il concetto di “destinazione”, ossia delle località o degli ambiti territoriali nei quali ha sede un complesso di risorse, infrastrutture e servizi connessi con un prodotto turistico o con una gamma di prodotti; • l'art. 9 della citata legge prevede che la Giunta Regionale riconosca, per ciascuna destinazione turistica, un'unica organizzazione della gestione e definisca criteri e parametri per la costituzione di quest'ultima; • l'OGD – Organizzazione della gestione della destinazione, delineata dal legislatore regionale, analogamente -
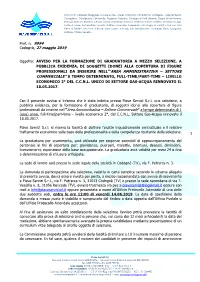
Codognè, 27 Maggio 2019 AREA
Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codogne’, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant’Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d’Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto. Prot. n. 9994 Codognè, 27 maggio 2019 Oggetto: AVVISO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA A MEZZO SELEZIONE, A PUBBLICA EVIDENZA, DI SOGGETTI IDONEI ALLA COPERTURA DI FIGURE PROFESSIONALI DA INSERIRE NELL’“AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE COMMERCIALE” A TEMPO DETERMINATO, FULL-TIME/PART-TIME – LIVELLO ECONOMICO 2° DEL C.C.N.L. UNICO DI SETTORE GAS-ACQUA RINNOVATO IL 18.05.2017. Con il presente avviso si informa che è stata indetta presso Piave Servizi S.r.l. una selezione, a pubblica evidenza, per la formazione di graduatoria, di soggetti idonei alla copertura di figure professionali da inserire nell’”Area Amministrativa – Settore Commerciale” a tempo determinato di 1 (uno) anno, full-time/part-time – livello economico 2°, del C.C.N.L. Settore Gas-Acqua rinnovato il 18.05.2017. Piave Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di definire l’esatto inquadramento contrattuale e il relativo trattamento economico sulla base della professionalità e della competenza risultante dalla selezione. 1 La graduatoria per scorrimento, sarà utilizzata per esigenze aziendali di approvvigionamento del personale ai fini di copertura per: gravidanze, puerperi, malattie, infortuni, decessi, dimissioni, licenziamenti, espansione della base occupazionale.