A Cura Di Ernestina Pellegrini
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Storia Di Firenze Annali I 2006.Indd
!NNALIDISTORIADIFIRENZE ) Avvertenza Le pagine a seguire forniscono, per gli anni 2001 e 2002, un elenco ordi- nato alfabeticamente per autore dei volumi, dei saggi in opere collettanee e degli articoli su riviste attinenti la storia fi orentina. Tale materiale, ugualmente suddiviso in tre sezioni, è disponibile anche nel portale «Storia di Firenze» nella sezione «Bibliografi a» dove è possibile trovare anche il link alla scheda del vo- lume disponibile nel catalogo delle case editrice (htpp://www.dssg.unifi .it/sdf/ bibliografi a.html). Nel prossimo numero degli «Annali» comparirà la bibliogra- fi a relativa al biennio 2003-2004. L’eccezionale vastità della produzione scientifi ca su Firenze e l’assenza di uno strumento unico di aggiornamento bibliografi co al riguardo, oltre ad essere il motivo essenziale di questo lavoro ne rappresenta anche il principale elemento di diffi coltà. Per gli intenti del portale, il profi lo scientifi co e gli interessi dei membri della redazione, la cultura fi losofi ca e letteraria e la storia delle arti fi - gurative risultano relativamente in secondo piano rispetto ai temi storiografi ci. La ricerca di cui queste pagine sono il frutto ha infatti integrato risorse diverse (bibliografi e on-line, siti di case editrici, segnalazioni su riviste e spogli di data- base bibliografi ci), nell’intento, non sempre di facile realizzazione, di isolare materiali propriamente riferiti alla storia di Firenze e omettendo una consimile ricerca in fonti a carattere storico-artistico o storico-letterario. Ci auguriamo che questa consapevole limitazione, anziché indebolire l’effi cacia del nostro lavoro, ne precisi la consistenza e quindi la fruibilità per i lettori. -

Cultural Heritage Of
® LIFE BIENNIAL BEYOND TOURISM® PUBBLICATION EVENTS 2014 - 2016 MEETING THE WORLD IN FLORENCE Centro Congressi al Duomo Life Beyond Tourism® Events Director | Direttore Carlotta Del Bianco Coordinator | Responsabile Michaela Žáčková Rossi Organizing Secretariat | Segreteria Organizzativa Stefania Macrì Eleonora Catalano Zdenka Skorunkova Dati Chika Arai Publication edited by | Pubblicazione a cura di Centro Congressi al Duomo: Life Beyond Tourism® Events With the collaboration of | Con la collaborazione di Centro Congressi al Duomo: Hotel Laurus al Duomo Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio Design and layout | Progetto grafico e impaginazione Corinna Del Bianco Maria Paz Soffia Contents | Contenuti Life Beyond Tourism® Events Abstracts texts have been sent to Life Beyond Tourism® Events by the Project Leaders of each conference and workshop – promoted by the Fondazione Romualdo Del Bianco® of Florence. I testi degli abstract di convegni e workshop – promossi dalla Fondazione Romualdo Del Bianco® – sono stati forniti a Life Beyond Tourism® Events dai Project Leader degli stessi eventi. Translation | Traduzione Eleonora Catalano Masso delle Fate Edizioni Via Cavalcanti 9/D - 50058 Signa (FI) ©Fondazione Romualdo Del Bianco® - Life Beyond Tourism® Masso delle Fate Edizioni ISBN LIFE BIENNIAL BEYOND TOURISM® PUBBLICATION EVENTS 2014 - 2016 Our ability to reach unity in diversity will be the perfect present for the test oF our civilization MAHATMA GANDHI Welcome to Florence! In order to offer the travellers support to their Florence, a personal and professional Florentine journey, the Centro Congressi al Duomo has established an event planning section called Life Beyond Tourism® city frozen in Events, which for years has been organizing in Florence international and intercultural events. -

The Case of Alberto Carocci (1926-1939)
Habitus and embeddedness in the Florentine literary field: the case of Alberto Carocci (1926-1939) Article Accepted Version La Penna, D. (2018) Habitus and embeddedness in the Florentine literary field: the case of Alberto Carocci (1926- 1939). Italian Studies, 73 (2). pp. 126-141. ISSN 1748-6181 doi: https://doi.org/10.1080/00751634.2018.1444536 Available at http://centaur.reading.ac.uk/75567/ It is advisable to refer to the publisher’s version if you intend to cite from the work. See Guidance on citing . To link to this article DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00751634.2018.1444536 Publisher: Taylor and Francis All outputs in CentAUR are protected by Intellectual Property Rights law, including copyright law. Copyright and IPR is retained by the creators or other copyright holders. Terms and conditions for use of this material are defined in the End User Agreement . www.reading.ac.uk/centaur CentAUR Central Archive at the University of Reading Reading’s research outputs online Habitus and Embeddedness in the Florentine Literary Field: The Case of Alberto Carocci (1926-1939) Daniela La Penna Department of Modern Languages and European Studies, University of Reading, Reading, UK [email protected] 1 Habitus and Embeddedness in the Florentine Literary Field: The Case of Alberto Carocci (1926-1939) This article intends to show how the notion of embeddedness, a concept derived from network theory, can improve our understanding of how a journal’s reliance on regional and national intellectual networks impacts the journal’s performance. The study takes as test case Alberto Carocci’s editorship of Solaria. -

Pieghevole Firenze.Indd
Econofi sica, Rosario MANTEGNA, Università di Palermo Interviene: ore 14; 15.30; 17 Conferenze, Visite Guidate e Laboratori 2. Galileo: dalla caduta dei gravi alla difesa del sistema copernicano 1. La caduta dei gravi: il piano inclinato e la piuma che cade nel vuoto Sotto l’Alto Patronato del Biofotonica, Francesco PAVONE, Università di Firenze Giulio GIORELLO, Università di Milano Laboratorio: micro-visioni, la forza della forza Nel laboratorio un animatore, nei panni di Galileo Galilei, dialoga con i 2. La bilancetta di Galileo: come determinare la densità di un liquido Discussione Rivolto ai bambini dai 5-12 anni, durata 80’ visitatori sulle proprie vicende. Parla delle prime osservazioni astronomiche 3. Corpi in acqua: il galleggiamento non dipende dalla forma degli oggetti, Nell’ambito del Caff è Filosofi co del Festival della Creatività, a cura dell’Assessorato Il telescopio di Galileo Presidente della Repubblica Presiede: Massimo Inguscio, Università di Firenze Organizzato da Federazione Italiana dei CEMEA Mostra - laboratorio con il telescopio che gli permisero di demolire l’antica concezione geocentrica né dalla profondità dell’acqua alla Cultura della Regione Toscana: e illustra gli studi sul moto di caduta dei gravi. N° laboratori previsti: 15 Venerdì 14 novembre ore 16.30 Sabato 25 ottobre Museo di Storia della Scienza, Piazza dei Giudici 1, Domenica 26 ottobre ore 20.30 3. L’accademia del Cimento: scienza sperimentale nella Toscana del Seicento Martedì 21 Ottobre ore 10 Sala Consiliare, Palazzo Comunale, Piazzale della Sala Volta, Fortezza da Basso, Viale Filippo Strozzi, Firenze ore 10.15; 11.45; 14 Firenze Aula Magna del Dipartimento di Fisica, Via Sansone 1 (Polo Laboratorio: la forza della forza, vai col vento Il laboratorio delinea il ruolo svolto dall’Accademia del Cimento nel Resistenza 1, Scandicci La filosofia del Dr. -

June 2019 P&F Newsletter LONG
WELCOME June brings the celebrations of Florence’s patron saint, San Giovanni. It is an abundant celebration, with parades, arts and music festival, the historical soccer game, and fireworks. Stay in town for the festivities, but make sure to visit Chianti for some wine and music. After a rainy May, it’s time to enjoy the sunshine of June. With best wishes from SUZANNE, CORSO, BEI, LESLIE, VANNI, ANNA PIA, RAFFAELLA, AND MARISA. JUMP TO YOUR FAVOURITE SECTION PITCHER AND FLACCOMIO PICKS BEST OF THE REST EXHIBITIONS DANCE AND THEATRE FILMS, LECTURES, AND PRESENTATIONS MUSIC OPEN MIC NIGHTS EXHIBITIONS OUTSIDE OF FLORENCE FUN, FESTIVALS, AND FOOD OUTSIDE OF FLORENCE CLASSIFIEDS !1 Pitcher & Flaccomio Newsletter Copyright 2017 Direttore responsabile Raffaella Galamini - Pubblicazione con iscrizione n. 5697 del 23\01\09 presso il Tribunale di Firenze. Pitcher & Flaccomio - Lungarno della Zecca Vecchia 30 - 50122 - Florence - Italy • Phone +39 055 2343354 • Fax +39 055 5609916 Office Hours: 9am - 5pm (+1.00 GMT) PITCHER & FLACCOMIO PICKS FOR JUNE BEST EVENT: LA FESTA DI SAN GIOVANNI, PATRON SAINT OF FLORENCE , June 24 SPECIAL PARADE WITH MASS The patron saint of Florence, John the Baptist, is celebrated on June 24. The morning begins with a small civic parade, which carries the offering of candles from Palazzo Vecchio to the Baptistery, located beside the Cathedral of Santa Maria de Fiore. Then the Archbishop of Florence celebrates holy mass in the cathedral at around 10.30am. SAN NICCOLO TOWER OPENS On this day, the San Niccolò Tower is also opened for the season until the end of September. -
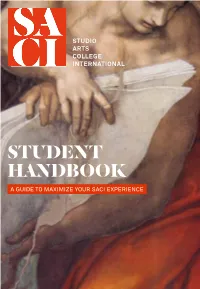
STUDENT HANDBOOK a GUIDE to MAXIMIZE YOUR SACI EXPERIENCE Front and Back Cover Images: Details of Michelangelo’S Sistine Chapel
STUDIO ARTS COLLEGE INTERNATIONAL STUDENT HANDBOOK A GUIDE TO MAXIMIZE YOUR SACI EXPERIENCE Front and back cover images: details of Michelangelo’s Sistine Chapel. SACI STUDENT HANDBOOK A Guide to Maximize Your SACI Experience Studio Arts College International Palazzo dei Cartelloni Via Sant’Antonino 11 50123 Florence - ITALY T (+39) 011 055 289948 F (+39) 011 055 2776408 [email protected] www.saci-florence.edu 4 CONTENTS Welcome..................................................7 SACI Mission Statement............................8 SACI Facilities.............................................9 School Regulations and Policies.............10 Housing................................................14 Other SACI Services..................................17 Visitors...............................................18 SACI Academic Information.....................20 Course Information....................20 Financial Information...............22 SACI Field Trips.........................................24 Florence’s Schedule.................................26 Health and Safety ...................................27 Fitness Facilities.......................27 Medical Information.................28 Safety Information....................31 Communication.....................................35 Telephone...............................35 Faxes, Photocopies, and IDs......37 Email and Internet....................37 Mail.....................................38 Money Transactions.................................39 Getting Around in Florence.....................41 -

A Palace and the City
A PALACE AND THE CITY 150 years since Florence was named An exhibition created and curated by the Capital of Italy Stefania Ricci and Riccardo Spinelli Palazzo Spini Feroni opens its doors Design to the city in a fascinating exhibition Maurizio Balò on its centuries of history in collaboration with Davide Amadei Museo Salvatore Ferragamo Exhibition organised by Florence, Palazzo Spini Feroni Museo Salvatore Ferragamo 8 May 2015- 3 April 2016 in collaboration with inauguration 7 May Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Firenze Fondazione Ferragamo With the sponsorship of Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Regione Toscana Comune di Firenze 1 A PALACE AND THE CITY “Long before I ever moved into the Palazzo Spini Feroni it was one of the buildings of Florence that I most admired and loved.” Salvatore Ferragamo From 8 May 2015 to 3 April 2016, at Palazzo Spini Feroni, via Tornabuoni, Florence, Museo Salvatore Ferragamo will hold an exhibition on the building’s centuries of history, commemorating the 150 years since Florence was named capital of the Kingdom of Italy (1865-1870), and Palazzo Spini Feroni became the city hall in 1865. Curated by Stefania Ricci and Riccardo Spinelli, the exhibition will include prestigious works of art and documents from museums and private collections and will tell the intricate stories behind the palace and its residents, in captivating displays created by stage designer Maurizio Balò, thus sharing one of the most important buildings in the city’s urban landscape with Florence, Florentines and travellers. -

Amici Di Palazzo Pitti Bollettino 2017
BOLLETTINO 2017 AMICI DI PALAZZO PITTI Amici di Palazzo Pitti Bollettino 2017 a cura degli Amici di Palazzo Pitti Presentazione 3 Carlo Sisi Contributi Botticelli in America 6 Miles Chappell I dipinti di Fra Bartolomeo in Galleria Palatina, nel quinto centenario della morte 23 Serena Padovani Luigi Ademollo, pittore in palazzo Pitti alla corte degli Asburgo-Lorena. Parte II 34 Egle Radogna Canova e Firenze, nella corrispondenza epistolare del 1814 48 Carlo Sisi, Silvio Balloni Il ritratto degli arciduchi e Mengs a Firenze 53 Elena Marconi Don Tommaso Corsini e alcuni artisti del suo tempo 58 Silvestra Bietoletti Riflessioni a margine della mostra Tracce. Dialoghi ad arte nel museo della moda e del costume 66 Caterina Chiarelli, Simonella Condemi Momenti della musica del Novecento a Firenze 80 Eleonora Negri Donaria granducali per la Chiesa e il Monastero di Santa Felicita I parte - I Medici 88 M. Cristina François Attività dei Musei di Palazzo Pitti Tesoro dei Granduchi (già Museo degli Argenti) 94 Galleria Palatina e Appartamenti Reali 100 Galleria d’arte moderna 104 Galleria della moda e del costume 106 Giardino di Boboli 107 Attività dell’Associazione Visite 112 Gite e viaggi 114 Conferenze 123 Eventi particolari 125 Piccola Antologia Ricordo di Marco Chiarini, studioso e amico 128 Miles Chappell Auguri a Detlef Heikamp 131 L’Associazione Amici di Palazzo Pitti 133 Redazione: Laura Baldini e Serena Padovani con la collaborazione di Detlef Heikamp Presentazione Per la nostra Associazione degli Amici di Palazzo Pitti la pubblica- zione -

May 2019 P&F Newsletter LONG
WELCOME May is one of the best times to be in Florence. The rain finally leaves, but the weather is not too hot and the gardens are spectacular. Music fills the air throughout the city. There are more events happening than we could possibly fit into one newsletter, but we have done our best to cover the highlights! Take in the spring blooms, honour the women who take care of you for Mother’s Day, and enjoy the sunshine together while there is still a cool breeze. With best wishes from SUZANNE, CORSO, BEI, LESLIE, VANNI, ANNA PIA, RAFFAELLA, AND MARISA. JUMP TO YOUR FAVOURITE SECTION PITCHER AND FLACCOMIO PICKS BEST OF THE REST EXHIBITIONS DANCE AND THEATRE FILMS, LECTURES, AND PRESENTATIONS MUSIC NETWORKS AND SOCIAL GATHERINGS OPEN MIC NIGHTS EXHIBITIONS OUTSIDE OF FLORENCE FUN, FESTIVALS, AND FOOD OUTSIDE OF FLORENCE !1 Pitcher & Flaccomio Newsletter Copyright 2017 Direttore responsabile Raffaella Galamini - Pubblicazione con iscrizione n. 5697 del 23\01\09 presso il Tribunale di Firenze. Pitcher & Flaccomio - Lungarno della Zecca Vecchia 30 - 50122 - Florence - Italy • Phone +39 055 2343354 • Fax +39 055 5609916 Office Hours: 9am - 5pm (+1.00 GMT) PITCHER & FLACCOMIO PICKS FOR MAY BEST SPRING GARDENS FOR MAY: INTERNATIONAL IRIS GARDEN AND THE ROSE GARDEN, Until May 20 The Iris is the symbol of Florence, the deep red of the Giglio di Firenze! Until May 20, you should spend part of every day in the Iris Garden above Florence, breathing in fresh air, avoiding the crowds and restoring your spirits. Expect beautiful flowers, meticulously refined over generations by the careful hands of their keepers. -

Pietro Gagliano'
PIETRO GAGLIANO’ SACI instructor since 2014 Installation and Performance Art MFA Graduate Seminar in Studio Art: Professional Practicum I and II (Second Year) RECENT EXHIBITIONS AND PROJECTS ● “Shelters and Libraries,” concept and curatorship of the group show with Adalberto Abbate, Gaetano Cunsolo and Davide D’Elia, with a performance by Justin Thompson, ABC Arte gallery, Genoa, June 2017. ● “Paesaggio Dentro,” curatorship of the group show, Susanna Orlando Arte Contemporanea, Pietrasanta (Lucca), July 2017. ● “Scripta Festiva,l” concept and curatorship of the book festival focused on contemporary theory, Brac Bookshop and other venues, Florence, May 2017. ● “Pietro Fortuna – SILOS,” curatorship of the solo show, MACRO (Museum of Contemporary Art in Rome), Rome, April 2017. ● “Matteo Negri - 17 sculture a colori,” curatorship of the solo show, Lorenzelli Arte, Milan, March 2017. ● “Isabella Pers – The Next Flow,” curatorship of the solo show, aA29 Project Space, Milan, March 2017. ● “The Safety of the Objects,” concept and curatorship of the group show involving 9 artists (Bruno Baltzer and Leonora Bisagno, Emanuele Becheri, Luca Capuano, Daniele D’Acquisto, Davide D’Elia, Serena Fineschi, Laura Pugno, Alessandro Valeri), Former Atelier Corradi, Bologna, January 2017. ● “Giuseppe Stampone – Artists for Sale,” curatorship of the solo show, Bologna, January 2017. ● “The Missing Part,” Action and Talk, Gnam (National Gallery), Rome, January 2017. ● “La Torre di Babele,” concept and curatorship of the group show involving 20 galleries of Contemporary Art, official event for the opening of Centro Pecci in Prato, Former Factory Lucchesi, Prato, October 2016. ● “WAITING FOR RAVE. Anticipations of a Posthuman Time,” curatorship of the exhibition, Villa Manin, Codroipo Udine, July 2016. -

Progetti Per L'arte E La Cultura
PROGETTI PER L’ARTE E LA CULTURA La sezione Progetti per l’arte e la cultura comprende 3 buste in cui è raccolta documentazione pro- dotta tra il 1947 ed il 1971 inerente ad una serie di collaborazioni e progetti promossi da CLR nell’am- bito della valorizzazione del ruolo di Firenze come centro di cultura artistica sia nazionale che inter- nazionale; la prima contiene documentazione pertinente al ruolo svolto da Carlo Ludovico Ragghianti nel rinnovamento e nella creazione, tra la fine degli anni ’40 ed i primi anni ’70, di una serie di enti finalizzati alla realizzazione di mostre ed esposizioni ed alla promozione culturale della città Firenze e del suo territorio. Si tratta di collaborazioni con importanti realtà cittadine, quali l’ambiente degli antiquari rappresentati da Luigi Bellini, con cui progetta la I Mostra Antiquaria Internazionale a Pa- lazzo Strozzi, l’Azienda Autonoma di Turismo e l’Amministrazione Comunale di Firenze, per cui lavora alla creazione di un ente culturale collegato al nascente Premio Firenze, al rinnovamento dello Statuto dell’Ente Mostre d’Arte Antica (inserito in una più generale proposta di legge di disciplina del settore espositivo) ed alla creazione del comitato permanente per le manifestazioni fiorentine “Annuali d’Arte Antica e Moderna”, e con la Provincia di Firenze per l’istituzione di un Ente Toscano per le Arti Figurative. Progetti ed iniziative che in alcuni casi verranno realizzati in collaborazione con lo Studio di Storia dell’Arte di Firenze o attraverso la creazione dell’Associazione “La Strozzina”, a cui la città di Firenze affiderà per oltre vent’anni la realizzazione a Palazzo Strozzi di importanti mostre d’arte antica e moderna e rassegne d’arte contemporanea, in altri saranno ripresi in tempi più recenti o del tutto abbandonati. -

Memory of the World Register
MEMORY OF THE WORLD REGISTER Cimitero di Porta a’ Pinti cosidetto Cimitero “degli Inglesi” (Florence's ‘English’ Cemetery, its archives, and its Mediatheca) (Italy) Ref N° 2010-44 PART A – ESSENTIAL INFORMATION 1 SUMMARY Florence’s cosmopolitan Swiss-owned so-called ‘English’ Cemetery, its archives and library of books by and about the international and ecumenical persons buried between 1827-1877, nobles, artists, poets, servants, serfs and slaves, British, Swiss, American, Russian, Scandinavian and others, with inscriptions in Hebrew, Greek, Roman, Cyrillic and fraktura letters, and in most European languages, including Rumantsch, distils into a small space and fifty years of time a dense history of Florence, of Europe, of the world. Many of these persons participated in the Peninsula and Waterloo battles against Napoleon, many were friends of Florence Nightingale and Henri Dinant, many worked ardently for the Abolition of Slavery (Elizabeth Barrett Browning, Frances Trollope, Richard Hildreth, Hiram Powers, Theodore Parker, with the ex-slave Frederick Douglass visiting their tombs), against the employment of children in mines and factories (EBB, Frances Trollope, Southwood Smith), many for the rights of women and many for the freeing of nations such as Greece and Italy under foreign oppression (EBB, Walter Savage Landor, Hiram Powers, Theodosia Trollope, Isa Blagden, Giampietro Vieusseux, the son of Ferenc Pulszky, the husband of Mary Somerville). The burial registers and accounts are meticulously hand-written in French by the Swiss owners, the archive thus being simultaneously chiselled on marble and inscribed on enduring rag paper. The tombs are sculpted by the leading nineteenth century Italian, English, American and Russian sculptors.