Contributo Alla Conoscenza Dei Dialetti Della Val Calanca
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Il Problema Economico Della Fusione Dei Comuni Della Valle Calanca
Il problema economico della fusione dei comuni della Valle Calanca Autor(en): Tamo, Sandro Objekttyp: Article Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani Band (Jahr): 43 (1974) Heft 4 PDF erstellt am: 06.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-33663 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch SANDRO TAMO' II problema economico della fusione dei comuni della Valle Calanca 11 (Fine) TERZA PARTE La realizzazione della fusione dei comuni della Valle Calanca Dopo aver osservato, nelle parti precedenti di questo studio, le difficili e particolari condizioni di vita e i vantaggi di cui potrebbero beneficiare i comuni della Valle Calanca con la realizzazione della loro fusione, porto- remo ora la nostra osservazione dalla parte teorica alla parte pratica. -

Mandato Di Prestazione Centro Giovanile
Mandato di prestazione tra i Comuni politici di Buseno, Calanca, Cama, Castaneda, Grono, Lostallo, Mesocco, Roveredo, Rossa, San Vittore, Santa Maria, Soazza, rappresentati dai loro Municipi (in seguito Comuni), e l’Associazione Centro giovanile del Moesano, con sede in 6535 Roveredo, (in seguito Associazione) relativo alla gestione del “Centro Giovanile del Moesano”. Premesso che: 1. L’Associazione ha quale scopo la gestione di un centro giovanile per ragazzi/ragazze dai 12 ai 18 anni e di proporre attività sane e costruttive per il loro tempo libero. Per raggiungere tale scopo sociale, l’Associazione intende in particolare locare un immobile e impiegare un animatore/una animatrice professionale. 2. I Comuni intendono promuovere le attività a favore dei/delle minori garantite dall’Associazione e a tal fine sono disposti a partecipare al finanziamento delle sue attività, segnatamente ai costi di locazione, dello stipendio dell’animatore/animatrice e delle assicurazioni necessarie alla gestione di un centro giovanile. Le parti convengono: 1. L’Associazione si impegna a costituire e gestire un centro giovanile per ragazzi/ragazze dai 12 ai 18 anni – denominato “Centro giovanile del Moesano” – e a proporre attività sane e costruttive per il loro tempo libero. A tal fine l’Associazione locherà un immobile e assumerà un animatore/una animatrice professionale. 2. I Comuni si impegnano a versare annualmente all’Associazione fr. 72’000.- entro il 31. marzo secondo la chiave di ripartizione allegata, la prima volta il 31.03.2021 , quale contributo per la gestione del “Centro giovanile del Moesano”. Tale importo comprende ogni spesa legata alla gestione del centro giovanile (locazione degli spazi, animatore/animatrice professionale, assicurazioni, acquisto materiale, ecc.). -

Graubünden for Mountain Enthusiasts
Graubünden for mountain enthusiasts The Alpine Summer Switzerland’s No. 1 holiday destination. Welcome, Allegra, Benvenuti to Graubünden © Andrea Badrutt “Lake Flix”, above Savognin 2 Welcome, Allegra, Benvenuti to Graubünden 1000 peaks, 150 valleys and 615 lakes. Graubünden is a place where anyone can enjoy a summer holiday in pure and undisturbed harmony – “padschiifik” is the Romansh word we Bündner locals use – it means “peaceful”. Hiking access is made easy with a free cable car. Long distance bikers can take advantage of luggage transport facilities. Language lovers can enjoy the beautiful Romansh heard in the announcements on the Rhaetian Railway. With a total of 7,106 square kilometres, Graubünden is the biggest alpine playground in the world. Welcome, Allegra, Benvenuti to Graubünden. CCNR· 261110 3 With hiking and walking for all grades Hikers near the SAC lodge Tuoi © Andrea Badrutt 4 With hiking and walking for all grades www.graubunden.com/hiking 5 Heidi and Peter in Maienfeld, © Gaudenz Danuser Bündner Herrschaft 6 Heidi’s home www.graubunden.com 7 Bikers nears Brigels 8 Exhilarating mountain bike trails www.graubunden.com/biking 9 Host to the whole world © peterdonatsch.ch Cattle in the Prättigau. 10 Host to the whole world More about tradition in Graubünden www.graubunden.com/tradition 11 Rhaetian Railway on the Bernina Pass © Andrea Badrutt 12 Nature showcase www.graubunden.com/train-travel 13 Recommended for all ages © Engadin Scuol Tourismus www.graubunden.com/family 14 Scuol – a typical village of the Engadin 15 Graubünden Tourism Alexanderstrasse 24 CH-7001 Chur Tel. +41 (0)81 254 24 24 [email protected] www.graubunden.com Gross Furgga Discover Graubünden by train and bus. -
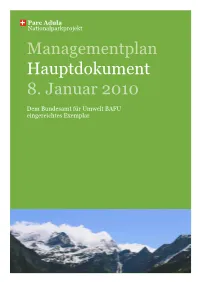
Verein Parc Adula Format
Parc Adula Nationalparkprojekt Managementplan Hauptdokument 8. Januar 2010 Dem Bundesamt für Umwelt BAFU eingereichtes Exemplar Parc Adula Managementplan für die Errichtungsphase Hauptdokument Dem Bundesamt für Umwelt BAFU eingereichtes Exemplar Deutsche Version 8. Januar 2010 Verein Parc Adula Ca’ Rossa Tel. 091 820 38 10 CH-6537 Grono Fax 091 820 38 12 www.parcadula.ch / [email protected] Managementplan Parc Adula Impressum Projektleitung: Riccardo Tamoni Verein Parc Adula Ca' Rossa 6537 Grono Leitungsausschuss: Fabrizio Keller, Präsident, Calanca und Mesolcina Luca Baggi, Vizepräsident, Regione delle Tre Valli Nello Bruni. Regione delle Tre Valli Sep Cathomas, Regiun Surselva Gion Michael, regioViamala Sandro Vanina, Regione delle Tre Valli Geschäftsführer der Regionalverbände: Duri Blumenthal, Regiun Surselva Nadia Ghisolfi, Regione delle Tre Valli Martin Hilfiker, Regione Mesolcina Alessandro Massa, Organizzazione Regionale della Calanca Casper Nicca, regioViamala Dario Zanni, Regione Tre Valli Koordination Managementplan: Stefan Forster Remo Kellenberger ZHAW Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen IUNR Fachstelle Tourismus und Nachhaltige Entwicklung FS TNE Center da Capricorns 7344 Wergenstein Copyright © Associazione Parc Adula 2009 Managementplan Parc Adula Autoren . Vorwort Fabrizio Keller Zusammenfassung…………………………..Riccardo Tamoni 1 Parkgebiet 1.1 Vorgeschichte Riccardo Tamoni 1.2 Perimeter Riccardo Tamoni 1.3 Natur und Landschaft, Teil Natur Dunja Meyer 1.3 Natur und Landschaft, Teil Flora Franziska Andres 1.3 Natur -

DPD EXPRESS Laufzeiten Für DPD 10:00, DPD 12:00
DPD EXPRESS Laufzeiten für DPD 10:00, DPD 12:00 Je nach Empfängeradresse erfolgt die Zustellung um 10 Uhr und in Randgebieten ist das Paket garantiert bis 12 Uhr ausgeliefert. DPD DPD DPD DPD DPD DPD PLZ Ort 10:00 12:00 PLZ Ort 10:00 12:00 PLZ Ort 10:00 12:00 1000 Lausanne ■ 1041 Montaubion-Chardonney ■ 1091 Chenaux ■ 1001 Lausanne ■ 1042 Bettens ■ 1092 Belmont-sur-Lausanne ■ 1002 Lausanne ■ 1042 Assens ■ 1093 La Conversion ■ 1003 Lausanne ■ 1042 Bioley-Orjulaz ■ 1094 Paudex ■ 1004 Lausanne ■ 1042 Malapalud ■ 1095 Lutry ■ 1005 Lausanne ■ 1043 Sugnens ■ 1096 Cully ■ 1006 Lausanne ■ 1044 Fey ■ 1096 Villette (Lavaux) ■ 1007 Lausanne ■ 1045 Ogens ■ 1097 Riex ■ 1008 Prilly ■ 1046 Rueyres ■ 1098 Epesses ■ 1008 Jouxtens-Mézery ■ 1047 Oppens ■ 1099 Montpreveyres ■ 1009 Pully ■ 1051 Le Mont-sur-Lausanne ■ 1110 Morges ■ 1010 Lausanne ■ 1052 Le Mont-sur-Lausanne ■ 1112 Echichens ■ 1011 Lausanne ■ 1053 Bretigny-sur-Morrens ■ 1113 St-Saphorin-sur-Morges ■ 1012 Lausanne ■ 1053 Cugy VD ■ 1114 Colombier VD ■ 1014 Lausanne ■ 1054 Morrens VD ■ 1115 Vullierens ■ 1015 Lausanne ■ 1055 Froideville ■ 1116 Cottens VD ■ 1017 Lausanne ■ 1058 Villars-Tiercelin ■ 1117 Grancy ■ 1018 Lausanne ■ 1059 Peney-le-Jorat ■ 1121 Bremblens ■ 1019 Lausanne ■ 1061 Villars-Mendraz ■ 1122 Romanel-sur-Morges ■ 1020 Renens VD ■ 1062 Sottens ■ 1123 Aclens ■ 1022 Chavannes-près-Renens ■ 1063 Peyres-Possens ■ 1124 Gollion ■ 1023 Crissier ■ 1063 Boulens ■ 1125 Monnaz ■ 1024 Ecublens VD ■ 1063 Chapelle-sur-Moudon ■ 1126 Vaux-sur-Morges ■ 1025 St-Sulpice VD ■ 1063 Martherenges ■ 1127 -

Rapporto Annuale 2019
RAPPORTO ANNUALE 2019 Buseno Cama Castaneda Calanca Grono Lostallo Mesocco Rossa Roveredo San Vittore Soazza Sta. Maria INDICE Rapporto annuale 2019 ..................................................................................................................................... 1 Conferenza dei Sindaci ...................................................................................................................................... 2 Comitato Regionale ........................................................................................................................................... 4 Consultazioni ..................................................................................................................................................... 6 Ufficio Esecuzioni e Fallimenti ........................................................................................................................... 7 Ufficio di Stato Civile........................................................................................................................................ 14 Ufficio Curatori Professionali ........................................................................................................................... 15 Notariato Regionale ......................................................................................................................................... 17 Pianificazione regionale .................................................................................................................................. -

Individuale Concorso
Augio - 25° concorso del tiro di caccia al camoscio sabato, 28 luglio 2018 Classifica individuale camoscio Cognome nome Domicilio 1°2° 3° 4° 5° 6° MEtà 1 Milani Mauro 6535 Roveredo 10 10 10 10 10 10 2 62 60 Pregaldini Fabio 6540 Castaneda 10 10 10 10 10 10 2 49 60 Serafini Stefano 6535 Roveredo 10 10 10 10 10 10 2 30 60 4 Crespi Lucio 6534 San Vittore 10 10 10 10 9 10 2 68 59 Fasani Stefano 6563 Mesocco 10 9 10 10 10 10 2 41 59 Theus Mario 6544 Braggio 10 10 10 10 10 9 2 39 59 Savioni Giacomo 6563 Mesocco 10 10 10 10 10 9 2 20 59 Theus Toni 6544 Braggio 10 9 10 10 10 10 0 70 59 Patt Stefano 6537 Grono 10 9 10 10 10 10 0 62 59 10 Papa Paolo 6558 Rossa 10 10 9 9 10 10 2 70 58 Papa Nicolas 6543 Arvigo 10 10 10 9 9 10 2 26 58 Losa Marco 6540 Castaneda 10 9 9 10 10 10 1 36 58 Fumi Edoardo 6542 Buseno 10 9 9 10 10 10 1 27 58 Fasani Otello 6542 Buseno 10 9 10 10 10 9 0 64 58 Balzer Mauro 6548 Rossa 10 10 10 9 9 10 0 33 58 Spadini Egon 6557 Cama 10 10 9 9 10 10 0 30 58 Atanes Samuel 6534 San Vittore 9 10 10 10 9 10 0 25 58 18 Giulietti Flavio 6534 San Vittore 10 10 10 9 10 8 2 69 57 Colombini Gianfranco 6548 Rossa 9 9 10 10 10 9 1 62 57 Fumi Domenico 6542 Buseno 8 10 9 10 10 10 1 57 57 Peretti Romano 6546 Cauco 10 9 10 9 9 10 1 40 57 Wellig Alessandro 6565 san bernardino 10 9 10 9 9 10 0 62 57 Von Wyll Martin 6556 Leggia 10 10 9 9 9 10 0 47 57 Capriroli Sebastiano 6548 Rossa 9 9 9 10 10 10 0 38 57 Giulietti Jonathan 6534 San Vittore 9 10 10 9 9 10 0 27 57 26 Fumi Boris 6542 Buseno 9 10 9 9 9 10 0 53 56 Maggini Marco 6540 Castaneda 9 10 10 9 8 10 0 50 56 28 Arcioni Lucia 6702 Claro 10 8 10 7 10 10 2 34 55 Grassi Chris 6535 Roveredo 10 9 9 9 8 10 2 25 55 Pacciarelli Dario 6541 St. -

La Valle Calanca Nella Crisi Economica
La Valle Calanca nella crisi economica Autor(en): Simoni, Diego Objekttyp: Article Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani Band (Jahr): 9 (1939-1940) Heft 2 PDF erstellt am: 04.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-10879 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch La valle calanca nella crisi economica Versione del dott. Diego Simoni (Continuazione vedi numero precedente) b) L'economia forestale. Piü di un terzo della superficie totale della valle e ricoperta da boschi. La mancanza di limiti precisi tra boschi, pascorj e terreni sterili ed il fatto che gli uni penetrano negli altri, formando delle 2one intermedie, rende difficile il calcolo esatto della superficie bo- schiva spettante ad ogni comune. -

Calancatal: Arvigo – Santa Maria in Calanca (Misox)
Calancatal: Arvigo – Santa Maria in Calanca (Misox) Wegbeschrieb leicht | 2.40 h | 8.3 km | 428 Hm 291 Hm | Santa Maria | Apr – Nov Ausgangspunkt der Wanderung ist die Bushaltestelle Arvigo Filovia bei der Seilbahnsta- tion, die nach Braggio im Calancatal führt. Den Ausgangspunkt Arvigo erreicht man von Wanderung im Calancatal im Misox von Arvigo nach Santa Maria in Grono im Valle Mesolcina (Misox), welcher an der Route zum San Bernardino und nach Calanca oberhalb von Grono. Unterwegs warten herrliche Aussichten Bellinzona liegt. Das Val Calanca ist ein Seitental des Misox und gehört zum italienisch- auf die Berge des Misox und der See Laghet di Buseno lädt mit schö- sprachigen Gebiet des Kantons Graubünden. nen Feuerstellen zum Stopp ein. Von der Bushaltestelle führt der Weg parallel dem Fluss Calancasca, auf der wenig befah- renen Strasse entlang abwärts, Richtung Buseno. Man passiert einen Gneiss-Steinbruch Ausgangspunkt: Arvigo, Filovia – Bushaltestelle und vereinzelte Häuser, bis man nach rund 20 Minuten die Strasse nach rechts überquert. Endpunkt: Sta. Maria in Calanca, Paese– Bushaltestelle Nun geht es auf dem Wanderweg leicht bergauf, dann über ein Geröllfeld und schliesslich Einkehr: nur Verpflegung in Santa Maria in Calanca: Ristorante Bellavista, im stetig leichten Auf und Ab zum Weiler Buseno. Nachdem man den Weiler hinter sich Ristorante-Bar Molera, Ristorante Baita gelassen hat, überquert man ein Flüsschen auf einer Brücke, wo man kurz darauf zu einer Anforderungen: T2 – Bergwandern Weggablung kommt. Hier geht man nach links hinab zum Laghet di Buseno. Die Route führt Highlights: Laghet di Buseno, Ausblicke von Piöt und Santa Maria in Calanca, nun in den schönen Wald hinein bis zum Ufer des Stausees. -

Regesti Dei Contratti, Concessioni, Fondazioni E Legati Nell'archivio Di Stato Del Grigioni 1803- 1961 (Segnatura: C1)
Regesti dei contratti, concessioni, fondazioni e legati nell'archivio di Stato del Grigioni 1803- 1961 (Segnatura: C1) Autor(en): Jenny, Rodolfo Objekttyp: Article Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani Band (Jahr): 33 (1964) Heft 2 PDF erstellt am: 27.09.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-26539 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Estratto da: REGESTI dei contratti, concessioni, fondazioni e legati nell'archivio di Stato del Grigioni 1803-1961 (Segnatura: C I) A cura delT Archivista Cantonale Dr. Rodolfo Jenny N. 828 Accordo tra il governo del Cantone dei Grigioni e il comune di Soazza circa l'eso- nero dall'obbligo di trasporto di ghiaia. -
Calendario Crer 2021 (Pdf)
6535 ROVEREDO CORPORAZIONE DEI COMUNI DEL MOESANO PER LA RACCOLTA E L’ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI WWW.CRER.CH 2021 23esima edizione San Vittore Roveredo Grono Lostallo Soazza Mesocco San Bernardino Santa Maria Val Calanca Braggio Landarenca Calanca Interna Foto dagli archivi della libreria del Politecnico federale di Zurigo San Vittore (anni ’50) non c’è ancora il campo di aviazione – foto Willi Borelli Gennaio 2021 Il giorno cresce 30 minuti 1 V MARIA SS. MADRE DI DIO Apparecchi elettrici e elettrodomestici (refrigeranti, Radio-TV, lampade fluorescenti, ecc.) 2 S SS. BASILIO M. E GREGORIO N. Da consegnare puliti. Consegna gratuita ai rivenditori, oppure alla ditta S. GENEVIÈVE 3 D Casso di Cama. 4 L S. AQUILINO 5 M S. EMILIANA 6 M EPIFANIA Raccolta carta 7 G S. RAIMONDO ➡ Calanca e Verdabbio 8 V S. ERARDO La carta va depositata impacchettata non in sacchi di 9 S S. ALESSIA plastica, in prossimità dei contenitori dei rifiuti, oppure nei luoghi designati dai Comuni, il giorno della raccolta 10 D S. GUGLIELMO 11 L S. IGINO 12 M S. CESIRA 13 M S. ILARIO 14 G S. FIRMINO 15 V S. MAURO 16 S S. MARCELLO 17 D S. ANTONIO ABATE 18 L S. PRISCA 19 M SS. LIBERATA E FAUSTINA 20 M SS. FABIANO E SEBASTIANO 21 G S. AGNESE 22 V S. VINCENZO 23 S S. EMERENZIANA 24 D S. FRANCESCO DI SALES 25 L CONVERSIONE DI S. PAOLO 26 M SS. TIMOTEO E TITO 27 M S. ANGELA MERICI 28 G S. TOMMASO D'AQUINO 29 V S. VALERIO Raccolta ingombranti 30 S S. -

Alluvioni Catastrofiche Nel Moesano
Alluvioni catastrofiche nel Moesano Autor(en): Boldini, Rinaldo Objekttyp: Article Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani Band (Jahr): 21 (1951-1952) Heft 1 PDF erstellt am: 21.01.2015 Persistenter Link: http://dx.doi.org/10.5169/seals-19072 Nutzungsbedingungen Mit dem Zugriff auf den vorliegenden Inhalt gelten die Nutzungsbedingungen als akzeptiert. Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die angebotenen Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungshinweisen und unter deren Einhaltung weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://retro.seals.ch XX A Lcuaauaaerni K^jrvityi&viitaiianiytriaiöviihali