“Una Legge Costituzionale Per Roma Capitale”1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Antonella Clementoni 956141
Scuola Dottorale di Ateneo Graduate School Dottorato di ricerca in Storia delle Arti Ciclo XXIX Anno di discussione 2017 Gli architetti e l’ archeologia: Roma 1922 - 1938 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE DI AFFERENZA : ICAR/18 Tesi di Dottorato di Clementoni Antonella, matricola 956141 Coordinatore del Dottorato Supervisore del Dottorando Prof. Martina Frank Prof. Guido Zucconi Supervisore esterno Arch. Michele Campisi a mio Padre 2 INDICE Ringraziamenti 4 Introduzione 5 Capitolo 1 Archeologi e architetti: quali discipline per il restauro? 12 Capitolo 2 I protagonisti del Ventennio 60 2 .1 Corrado Ricci Lo studio della storia e dell’archeologia: i Fori 60 2.2 Alfonso Bartoli Lo studioso del Palatino e Foro Romano: il caso del tempio di Vesta 83 2.3 Antonio Munoz La ricomposizione dell’immagine: il tempio di Venere e Roma 103 2.4 Gustavo Giovannoni Il restauro dei “monumenti morti” 124 Capitolo 3 La Mostra Augustea della Romanità e i disegni inediti di Pasquale Carbonara e Luigi Piccinato 145 3.1 L’Ara Pacis Augustae e la sua ricomposizione 175 3.2 L’isolamento del Mausoleo di Augusto 196 Capitolo 4 La Mostra del Restauro dei Monumenti nell’Era Fascista 216 Conclusioni 244 Bibliografia 253 Fonti archivistiche 274 3 Ringraziamenti Colgo, con vivo piacere, l’occasione per dichiarare il mio debito di gratitudine verso Guido Zucconi, supervisore di questa ricerca, che pur non conoscendomi ha creduto fin dall’inizio in questo lavoro dedicato ad un periodo storico ancora controverso e oscuro sulla storia del nostro paese. Stessa gratitudine è rivolta a Michele Campisi e al suo incitamento dimostratomi in periodi di crisi. -

Download Download
L’ARCHITETTURA DELLE CITTÀ Q Società Scientifica Ludovico Quaroni L’ARCHITETTURA DELLE CITTÀ Q Società Scientifica Ludovico Quaroni L’ADC L’architettura delle città. The Journal of the Scientific Society Ludovico Quaroni n. 18/2021: Frammenti Romani Edited by: Anna Irene Del Monaco direttore scientifico | managing editor Lucio Valerio Barbera, Sapienza University of Rome comitato scientifico-editoriale| editorial-scientific board Maria Angelini, University ‘G. d’Annunzio’ of Chieti-Pescara Luisa Anversa, University of Rome Sapienza Lucio Valerio Barbera, University of Rome Sapienza Yung Ho Chang, Massachusetts Institute of Technology MIT, Boston Jean-Louis Cohen, New York University NYU, New York Mario Guido Cusmano, University of Florence († 2016) Stanley Ira Halley, Catholic University of Washington DC Martha Kohen, University of Florida, Gainesville Jean-Francois Lejeune, University of Miami Jian Liu, Tsinghua University, Beijing Roberto Maestro, University of Florence Paolo Melis, University of Rome Sapienza Ludovico Micara, University ‘G. d’Annunzio’ of Chieti-Pescara Giorgio Muratore, University of Rome Sapienza († 2017) Franz Oswald, ETH Zurich, Switzerland Attilio Petruccioli, Polytechnic of Bari Richard Plunz, Columbia University in the City of New York Vieri Quilici, University of Roma Tre Ruan Xing, University of New South Wales, Australia / Shanghai Jiaotong University, China Daniel Sherer, Columbia University in the City of New York / Yale University Daniel Solomon, University of California UCB, Berkeley Antonino Terranova, -

Toponomastica Riordinamenti
RIORDINAMENTI TOPONOMASTICA INTRODUZIONE a cura di Laura Francescangeli (2017) La serie Riordinamenti Toponomastica è stata versata nel 2016 all’Archivio Storico Capitolino dal Servizio Toponomastica e Numerazione Civica ed è costituita da 399 fascicoli (o unità di descrizione archivistica) raccolti in 26 faldoni con documentazione relativa a vari nuclei tematici riferentisi ai diversi aspetti dell’attività svolta dall’Ufficio della Toponomastica. In primo luogo a supporto dei lavori della Commissione di Toponomastica, organo consultivo cui è a tutt’oggi demandato il parere sulle iniziative di intitolazione di aree stradali e di denominazione, variazione o riordino dei comprensori toponomastici cittadini (articolati dal centro storico alle aree periferiche della Capitale in: Rioni, Quartieri, Suburbi, Zone dell’Agro Romano). Tale parere precede le deliberazioni adottate in materia di nomenclatura delle aree pubbliche in via d’urgenza (nell’imminenza dello svolgimento del censimento) dalla Giunta Municipale e in via ordinaria dal Consiglio Comunale fino alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso. Entrata in vigore la legge 8 giugno 1990 n. 142 di riforma dell’ordinamento degli EE.LL., l’organo deliberante in materia di nomenclatura stradale è stato individuato nella Giunta Comunale. La documentazione è costituita in buona parte da planimetrie (riproduzioni cianografiche) prodotte dal “Reparto Cartografico” del “Servizio Toponomastica” negli anni Cinquanta-Ottanta del Novecento. Il servizio era allora dipendente dalla Direzione II del Segretariato Generale. Già incardinato nella Ripartizione IV “Anagrafe e Stato Civile” esso era stato aggregato alla Ripartizione IX “Affari Generali” nel 1936 quando, in vista del nuovo censimento generale della popolazione, furono implementate le competenze demandate a questa struttura istituita nel 1927 e già titolare dei servizi di statistica e censimento scorporati dalla Ripartizione IV 1. -

Sindaci Di Roma - Wikipedia
Sindaci di Roma - Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Sindaci_di_Roma Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Segue la cronotassi dei sindaci di Roma, dal 1870, data del passaggio della Capitale dallo Stato Pontificio al Regno d'Italia, ad oggi. Indice 1 Cronotassi dei sindaci 1.1 Regno d'Italia (1870-1946) 1.2 Repubblica Italiana (1946-oggi) 2 Amministrazione attuale 3 Note 4 Voci correlate Regno d'Italia (1870-1946) 1 di 6 20/11/2010 15.39 Sindaci di Roma - Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Sindaci_di_Roma Periodo Primo Cittadino Partito Carica Note Presidente 23 settembre 30 settembre Michelangelo Caetani della Giunta 1870 1870 di Governo 30 settembre novembre 1870 Guido di Carpegna Falconieri Commissario 1870 Facente novembre 1870 dicembre 1870 Giuseppe Lunati funzioni sindaco Facente dicembre 1870 marzo 1871 Filippo Andrea Doria Pamphili funzioni sindaco Facente marzo 1871 maggio 1871 Giovanni Angelini funzioni sindaco maggio 1871 ottobre 1871 Francesco Pallavicini Sindaco Facente ottobre 1871 maggio 1872 Francesco Grispigni funzioni sindaco Facente maggio 1872 maggio 1872 Giuseppe Troiani funzioni sindaco Facente maggio 1872 novembre 1872 Pietro Venturi funzioni sindaco novembre 1872 luglio 1874 Luigi Pianciani Sindaco[1] luglio 1874 novembre 1877 Pietro Venturi Sindaco[2] novembre 1877 luglio 1880 Emanuele Ruspoli Sindaco[3] Facente luglio 1880 ottobre 1881 Augusto Armellini funzioni sindaco ottobre 1881 maggio 1882 Luigi Pianciani Sindaco maggio 1882 dicembre 1887 Leopoldo Torlonia Sindaco[4] gennaio 1888 novembre 1889 Alessandro -

L'immagine Di Roma. Le Carte Dell'ufficio Del Cerimoniale
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO – XXX CICLO COORDINATORE: PROF. ALBERTO PETRUCCIANI L’IMMAGINE DI ROMA. LE CARTE DELL’UFFICIO DEL CERIMONIALE E DEI SERVIZI DELLA PROPAGANDA E DELL’UFFICIO STUDI DEL GOVERNATORATO DI ROMA (1935-1945) Dottorando Paolo Saverio Pascone Tutor: prof.ssa Linda Giuva Co-tutor: prof.ssa Antonella Meniconi 2 Indice PREMESSA ......................................................................................................................................... 7 1. UN’AMMINISTRAZIONE PER LA CAPITALE D’ITALIA: IL GOVERNATORATO DI ROMA ................................................................................................................................................ 11 1.1 La genesi del Governatorato di Roma ................................................................................................... 11 1.2 La configurazione definitiva del Governatorato (1928-1943) ............................................................... 19 1.3 Il governo centrale, la periferia amministrativa e gli enti locali ............................................................ 23 1.4 I governatori di Roma (1925-1943) ....................................................................................................... 29 1.5 L’organizzazione degli uffici capitolini e la struttura del Governatorato .............................................. 37 1.6 Il vertice amministrativo ....................................................................................................................... -

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA XXIII C Coordinatore: Chiar.Mo Prof. Fulco Lanchester Relatore: Chiar.Mo Prof
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” DIPARTIMENTO DI TEORIA DELLO STATO DOTTORATO DI RICERCA IN TEORIA DELLO STATO E ISTITUZIONI POLITICHE COMPARATE XXIII CICLO TESI DI DOTTORATO L’ORDINAMENTO SPECIALE DI ROMA CAPITALE. PROBLEMI INTERPRETATIVI, ASPETTI PROBLEMATICI E SOLUZIONI GIURIDICHE DELLA LEGGE 42/2009 ALLA LUCE DEI SUOI PRECEDENTI STORICI Coordinatore: Chiar.mo Prof. Fulco Lanchester provided by Archivio della ricerca- Università di Roma La Sapienza View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk CORE Relatore: Chiar.mo Prof. brought to you by Beniamino Caravita di Toritto Candidato: Dott.ssa Federica Fabrizzi A mio padre, che non è riuscito a vedere questo mio lavoro del quale, sono certa, sarebbe stato molto orgoglioso 1 INDICE Introduzione Il perché di una ricostruzione storica…………………………….p. 4 Capitolo I “La Capitale inevitabile”…………………………………...…………….p.15 1. Dal 1861 al 1870: la scelta della capitale…………………………..................p.15 2. La presa di Roma e gli ordinamenti provvisori……………………………….p.25 3. I provvedimenti legislativi degli anni Settanta e Ottanta……………………...p.31 4. Crispi e lo Stato accentratore………………………………………………….p.37 5. Giolitti ed i provvedimenti di inizio secolo…………………………………...p.43 5.1 L’amministrazione Nathan…………………………………………………..p.47 Capitolo II Il fascismo e Roma. Il Governatorato, “organo di carattere statale con scopi e funzioni municipali” .......p.53 1. La relazione del “gruppo di competenza” del PNF……………………………p.54 2. Il Regio Decreto 28 ottobre 1925 n. 1949……………………………………..p.64 3. Le modifiche apportate alla legge ed il definitivo assetto del Governatorato…………………………………………...p.70 4. La natura giuridica del nuovo ente…………………………………………....p.73 5. I Governatori………………………………………………………………….p.83 6. -
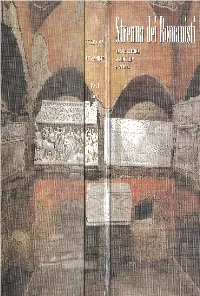
2001 Parte 1 Pp. 1-325
STRENNA DEI ROMANISTI NATALE DI ROMA 2001 ab U.c. MMDCCLIV BARBERITO - BATTELLI - BENOCCI - BIANCINI - CARLONI - CAZZOLA - CECCARELLI - CECCOPIERI MARUFFI - CERESA - CIAMPAGLIA - CRESCENTINI - D' AMBROSIO - DEL RE - DI CARPEGNA FALCONIERI - DI CASTRO - DOMACAVALLI - ESCOBAR - FAITROP PORTA - FLORIDI - FRAPISELLI - GRIMALDI - GUIDONI - HARTMANN - LEFEVRE - LIMITI - LONDEI - LOTTI - MALIZIA - MARIOTTI BIANCHI - MASETTI ZANNINI - NORCI CAGIANO- F. ONORATI - U. ONORATI - PAGLIALUNGA - POCINO - PORFIRI - PROIETTI - QuINTAVALLE - RAVAGLIOLI - Russo BoNADONNA - Russo DE CARO - SANTINI - TAMBLÈ - TOURNON - TRASTULLI - VERDONE - VIAN ((7,MATURIS N1S18US EDITRICE ROMA AMOJ In copertina: 1980 La necropoli vaticana dopo il restauro realizzato dalla Reverenda Fabbrica di S. Pietro in Vaticano. EDITRICE ROMA AMOR 1980 Comitato dei curatori: MANLIO BARBERITO UMBERTO MARIOTTI BIANCHI ANTONIO MARTIN! FRANCO ONORATI <; - -,-~- MARIA TERESA Russo BONADONNA ~--- . '~~,,,~- ,- - ~- ~---- ~~~ DONATO TAMBLÈ .. ""' d __.._-,;;: ~ -~-~~) ,, J ·l'r--, -.- ,- FRANCESCO PICCOLO s _./~<·:;. ~,....__,__.--!_é;:...-----'~':. Coordinamento e impaginazione: GEMMA HARTMANN EMANUELA PEDANESI FRANCO PEDANESI Consulenza editoriale: ANDREA MARINI MMDCCLIV AB VRBE CONDITA © EDITRICE ROMA AMOR 1980 Te!. 06.32.34.375 Indirizzo di saluto del Presidente del Gruppo dei Romanisti al Presidente della Repubblica in occasione della sua visita al Caffè Greco il 7 giugno 2000 Signor Presidente, il Gruppo dei Romanisti è consapevole dell'alto onore della Sua visita; e non soltanto perché