Rivista Di Scienze Storiche E Sociali
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Book Review | a Duty to Resist: When Disobedience Should Be Uncivil by Candice Delmas Page 1 of 4
Democratic Audit: Book Review | A Duty to Resist: When Disobedience Should Be Uncivil by Candice Delmas Page 1 of 4 Book Review | A Duty to Resist: When Disobedience Should Be Uncivil by Candice Delmas In A Duty to Resist: When Disobedience Should Be Uncivil, Candice Delmas aims to foster understanding of resistance to injustice as a capacious concept that can include the possibility of lawful dissent, principled disobedience and revolution. This is a provocative and rewarding contribution to the literature, writes Suzanne Smith, that is particularly valuable for its attention to the question of the situational conditions of obligatory, potentially uncivil resistance. Marchers carrying banner reading ‘We march with Selma!’, Harlem, New York City. Picture: Stanley Wolfson, New York World Telegram & Sun. This image is available from the United States Library of Congress‘s Prints and Photographs division under the digital ID cph.3c35695. No known copyright restrictions) A Duty to Resist: When Disobedience Should Be Uncivil. Candice Delmas. Oxford University Press. 2018. ‘A commonly heard complaint’, remarked Alexis de Tocqueville in his analysis of events leading up to 1789, ‘is that the French have no respect for law’. To his mind, given the corruption characteristic of the Ancien Régime, this was not surprising. He blamed this lack of respect on the deficit of ‘intermediary powers’ capable of integrating the concerns of ‘private individuals’ with the policies of the state. Yet what Tocqueville wrote with respect to attitudes concerning law in pre-Revolutionary France is sometimes also said of the post-1945 Republic, when intermediary powers were quite robust. No sooner did World War II end than did resistance – often violent – arise against dirigisme économique. -
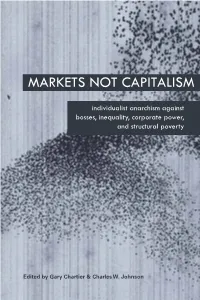
Markets Not Capitalism Explores the Gap Between Radically Freed Markets and the Capitalist-Controlled Markets That Prevail Today
individualist anarchism against bosses, inequality, corporate power, and structural poverty Edited by Gary Chartier & Charles W. Johnson Individualist anarchists believe in mutual exchange, not economic privilege. They believe in freed markets, not capitalism. They defend a distinctive response to the challenges of ending global capitalism and achieving social justice: eliminate the political privileges that prop up capitalists. Massive concentrations of wealth, rigid economic hierarchies, and unsustainable modes of production are not the results of the market form, but of markets deformed and rigged by a network of state-secured controls and privileges to the business class. Markets Not Capitalism explores the gap between radically freed markets and the capitalist-controlled markets that prevail today. It explains how liberating market exchange from state capitalist privilege can abolish structural poverty, help working people take control over the conditions of their labor, and redistribute wealth and social power. Featuring discussions of socialism, capitalism, markets, ownership, labor struggle, grassroots privatization, intellectual property, health care, racism, sexism, and environmental issues, this unique collection brings together classic essays by Cleyre, and such contemporary innovators as Kevin Carson and Roderick Long. It introduces an eye-opening approach to radical social thought, rooted equally in libertarian socialism and market anarchism. “We on the left need a good shake to get us thinking, and these arguments for market anarchism do the job in lively and thoughtful fashion.” – Alexander Cockburn, editor and publisher, Counterpunch “Anarchy is not chaos; nor is it violence. This rich and provocative gathering of essays by anarchists past and present imagines society unburdened by state, markets un-warped by capitalism. -

Liberty Magazine January 1995.Pdf Mime Type
The Bell Curve, Stupidity, and January 1995 Vol. 8, No.3 $4.00 You ~ ,.';.\, . ~00 . c Libertarian Bestsellers autographed by their authors - the ideal holiday gift! Investment Biker The story of a legendary Wall Street investor's·travels around the world by motorcycle, searching out new investments and adventures. "One of the most broadly appealing libertarian books ever published." -R.W. Bradford, LffiERTY ... autographed by the author, Jim Rogers. (402 pp.) $25.00 hard cover. Crisis Investing for the Rest of the '90s This perceptive classic updated for today's investor! "Creative metaphors; hilarious, pithy anecdotes; innovative graphic analyses." -Victor Niederhoffer, LffiERTY ... autographed by the author, Douglas Casey. (444 pp.) $22.50 hard cover. It Carne froIn Arkansas David Boaz, Karl Hess, Douglas Casey, Randal O'Toole, Harry Browne, Durk Pearson, Sandy Shaw, and others skewer the Clinton administration ... autographed by the editor, R.W. Bradford. (180 pp.) $12.95 soft cover. We the Living (First Russian Edition) Ayn Rand's classic novel ofRussia translated into Russian. A collector's item ... autographed by the translator, Dimitry Costygin. (542 pp.) $19.95 hard cover. The God of the Machine Isabel Paterson's classic defense of freedom, with a new introduction by Stephen Cox. Autographed by the editor. (366 pp.) $21.95 soft cover. Fuzzy Thinking: The New Science of Fuzzy Logic A mind-bending meditation on the new revolution in computer intelligence - and on the nature of science, philosophy, and reality ... autographed by the author, Bart Kosko. (318 pp.) $12.95 soft cover. Freedorn of Informed Choice: The FDA vs Nutrient Supplements A well-informed expose of America's pharmaceutical "fearocracy." The authors' "'split label' proposal makes great r----------------------------,sense." -Milton Friedman .. -

Course Syllabus
Freedom Political Theory Project Course Description: Freedom has been called the greatest political concept of the modern world. But what is freedom? And if freedom is important, what should we do about it? Does freedom conflict with other important values, such as gender equality or distributive fairness? Can political systems that claim allegiance to freedom also make room for other values? Is the best society the one that cares only about freedom? Format: This is a demanding, reading intensive freshman seminar. As a seminar, classroom discussion is of the utmost importance. Be sure to complete all the readings before class meets each week, and come to class ready to join in the conversation. In this class, we are a team. So join in. Presentations: Each week, seminar will be opened by a brief presentation prepared by a team of two students. When it is your turn to present, your mission is NOT to teach the whole class, or to become world-class experts on the issues at hand. Rather, each presentation team is expected to study the assigned readings carefully, briefly summarize the main points, and to identify a few fundamental questions or challenges posed by the readings that they found most interesting (or confusing!). Requirements: 1. Students are expected to attend in each seminar, and to participate actively. We will allow one excused absence during the semester. Any additional absence will be penalized by a grade unit deduction from your final grade (so, if you had an A++, your final grade would be reduced to a measly A+, though of course if you had a B-, that would become a C+. -

2020 Annual Meeting 201 2 Contents
20Advancing PPE at every opportunity 2020 ANNUAL MEETING 201 2 CONTENTS Welcome 05 Schedule 06 Thursday 06 Friday 14 Saturday 24 New Orleans Suggestions 34 Index and Notes 35 3 WELCOME Dear PPE Conference Participants, This is the Fourth Annual Meeting of the PPE Society! Welcome. The PPE Society continues to grow dramatically, as does the number of submissions for our annual conference. Our hope is that the resulting program gives you too much of interest and leaves you wishing you had more time to navigate the questions people in the sessions are exploring. New this year is our use of the Whova app, on which you will find details about the various sessions and information about speakers and other participants. In order to offer as many options as possible, we are again offering a large number of concurrent sessions. But we do have two keynote addresses, one by Steven Macedo (on Thursday) and one by Elizabeth Anderson (on Saturday). Receptions will follow each keynote address. As in the past, the days will be filled to the brim, but the evenings are free for you to enjoy New Orleans and the company of a fascinating group of people. The PPE Society’s mission is to encourage the interaction and cross-pollination of three intellectual disciplines that are historically deeply intertwined and continue to have much to offer one another. If you have not already joined the PPE Society, please do (using http://ppesociety.web.unc.edu/join-the-ppe-society/). If you have any suggestions about how we might effectively pursue our mission, please do not hesitate to pass them on to me. -

Rivista Di Scienze Storiche E Sociali Rivista Scientifica Semestrale Fondata Nell’Anno 2015
Rivista di scienze storiche e sociali Rivista scientifica semestrale fondata nell’anno 2015 www.StoriaLibera.it [email protected] Anno VII (2021), n. 13 ISSN 2421-0269 Direttore Beniamino Di Martino Capo Redattore Rosa Castellano [email protected] Redazione + Maria Rosaria Abagnale Cesarano Michele Arpaia Antonio Caragliu Giovanni Chierchia Bernardo Ferrero Rosa Saviano Lucia Sorrentino Antonino Trunfio Accanto ai redattori, la Redazione si avvale della collaborazione di altri otto coadiutori. Altre informazioni sono sul sito web della rivista. StoriaLibera anno VII (2021), n. 13 Direzione presso Beniamino Di Martino via Motta Carità, 43 80050 Santa Maria la Carità (Napoli) [email protected] Editore Monolateral PO Box 940451 Plano, Texas (USA) 75094 https://monolateral.com Gli elaborati pubblicati su «StoriaLibera» sono sottoposti a controllo di qualità secondo la procedura della peer review in doppio cieco. I contenuti degli articoli sono di esclusiva responsabilità degli autori. Gli autori cedono i propri contributi alla rivista gratuitamente. Anche ogni altro tipo di collaborazione alla rivista è offerta a titolo totalmente volontario e gratuito. I fascicoli della rivista vengono preparati con cadenza semestrale e vengono diffusi on line a gennaio (numero invernale) e a luglio (numero estivo). La data di uscita di ciascun numero è riportata nell’ultima pagina del fascicolo. I testi contenuti nei fascicoli della rivista sono protetti da copyright. La riproduzione, anche parziale, deve essere svolta citando con precisione -
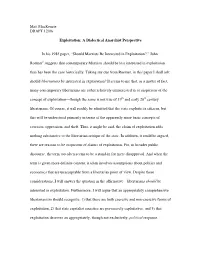
Matt Mackenzie DRAFT 12/06 Exploitation: a Dialectical Anarchist
Matt MacKenzie DRAFT 12/06 Exploitation: A Dialectical Anarchist Perspective In his 1985 paper, “Should Marxists Be Interested in Exploitation?,” John Roemer1 suggests that contemporary Marxists should be less interested in exploitation than has been the case historically. Taking my cue from Roemer, in this paper I shall ask: should libertarians be interested in exploitation? It seems to me that, as a matter of fact, many contemporary libertarians are either relatively uninterested in or suspicious of the concept of exploitation—though the same is not true of 19th and early 20th century libertarians. Of course, it will readily be admitted that the state exploits its citizens, but this will be understood primarily in terms of the apparently more basic concepts of coercion, oppression, and theft. Thus, it might be said, the claim of exploitation adds nothing substantive to the libertarian critique of the state. In addition, it could be argued, there are reasons to be suspicious of claims of exploitation. For, in broader public discourse, the term too often seems to be a stand-in for mere disapproval. And when the term is given more definite content, it often involves assumptions about politics and economics that are unacceptable from a libertarian point of view. Despite these considerations, I will answer the question in the affirmative—libertarians should be interested in exploitation. Furthermore, I will argue that an appropriately comprehensive libertarianism should recognize, 1) that there are both coercive and non-coercive forms of exploitation, 2) that state capitalist societies are pervasively exploitative, and 3) that exploitation deserves an appropriately, though not exclusively, political response. -

H-Diplo Roundtable, Vol
2018 H-Diplo Roundtable Editors: Diane Labrosse and Daniel Steinmetz- @HDiplo Jenkins Roundtable and Web Production Editor: George Fujii Roundtable Review Volume XIX, No. 38 (2018) Introduction by Daniel Steinmetz-Jenkins Rev. B (formatting corrections) 1 June 2018 Melinda Cooper. Family Values: Between Neoliberalism and the New Social Conservatism. Cambridge: MIT Press for Zone Books, 2017. ISBN: 9781935408840 (hardcover, $29.95). URL: http://www.tiny.cc/Roundtable-XIX-38 Contents Introduction by Daniel Steinmetz-Jenkins, Yale University ................................................................2 Review by Kristen Loveland, Southern District of New York ..............................................................5 Review by Andrea Muehlebach, University of Toronto ..................................................................... 10 Review by Gabriel N. Rosenberg, Duke University .............................................................................. 15 Review by Charlotte Walker-Said, John Jay College- City University New York ....................... 19 Author’s Response by Melinda Cooper, the University of Sydney ................................................ 25 © 2018 The Authors. Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States License. H-Diplo Roundtable Review, Vol. XIX, No. 38 (2018) Introduction by Daniel Steinmetz-Jenkins, Yale University t is often forgotten that in the early days of the Cold War, vital center/consensus liberals were opposed not simply to Communism but also to doom and -
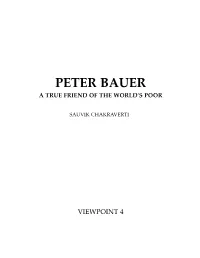
Peter Bauer a True Friend of the World's Poor
PETER BAUER A TRUE FRIEND OF THE WORLD'S POOR SAUVIK CHAKRAVERTI VIEWPOINT 4 Peter Bauer A True Friend of the World's Poor Sauvik Chakraverti n the west Bauer is being A friend who will be sorely missed. remembered as the man who And a friend who will one day be opposed foreign aid most read and honoured in every trenchantly. He called aid Economics classroom in the Third "government-to-government World and whose bust will be Itransfers" and said that they went prominently displayed in every from the poor of the developed Third World bazaar. world to the rich of the underde- A few days before Lord Bauer’s veloped. Margaret Thatcher was death, a report appeared in the strongly influenced by Bauer—she papers saying that the Delhi gov- was instrumental in getting him ernment was putting out posters elevated to the House of Lords in telling the citizens not to give alms 1982, and reportedly asked Third to beggars. Officials were quoted as World leaders at a Commonwealth saying that beggary had become an meeting to read Peter Bauer—but "industry" and a traffic hazard. even she did not close down And further, that judging by the Britain’s Office of Development sheer number of crippled Assistance (ODA). To the bleeding beggars—mainly children—they hearts brigade, Bauer’s opposition were sure there was a "supply to aid would make him an enemy chain" ensuring that cripples were of the world’s poor. In this tribute available in plenty for the trade. to the greatest development econo- If Lord Bauer were here, he mist that ever lived, I will take the would greet this news with a wry position that, contrary to the views smile. -

The Man from Mars Who Is This Guy Challenging Lech .....Ian Ua.....Ry 199 1 V O 14, N O3 $4 ,00 Walesa, Anyway?
The Man From Mars Who is this guy challenging Lech .....Ian_ua.....ry_199_1 V_o_14,_N_o3 $4_,00 Walesa, anyway? ''5!{{ ofourgreatness was 60rn ofLi6erty. II -John Peter .9l{tge{tf Mint State $5 Liberty $225! During the past few weeks, the only $225. ly small, averaging less than 300,000. collapse of the organized market for That's the lowest price in more The $5.00 Liberty was issued at a so-called "investor" coins has created than a decade! time when the United States was on a an unprecedented opportunity to ac Much rarer than $20 Liberty gold standard. Gold coins were the quire certain classic, old U.S. gold or $20 St Gaudensl sinews of the prosperity that free men coins at remarkably low prices. The $5.00 Liberty is much rarer acting in an economy free from gov U.S. gold coins have long been ernment control could create. considered the "blue chip" of rare than the popular (and more expen sive!) $20 St Gaudens or $20 Liberty. And the $5 Liberty circulated coins. And for good reason: they widely, unlike the $20 gold coins The chart at the bottom of the page have a long term track record of safe which were held as reserves by banks. compares the rarity of these three gold ty and capital gain that goes back As a result, it is much rarer today than decades. coins. By every measuring standard, the its relative mintage figures would An unprecedented bargainl $5.00 Liberty is the rarest of the three. suggest. In terms of average mintage, the $5 But the panic in the market for ex Liberty is more than 3 times rarer than Professionally Certified tremely high grade certified rare the $20 Liberty and almost 5 times rar This offering of $5.00 Liberty gold coins has carried over even into blue coins consists solely of specimens cer er than the $20 St Gaudens. -

Egalitarian Liberalism and Economic Freedom
University of Pennsylvania ScholarlyCommons Publicly Accessible Penn Dissertations 2019 Egalitarian Liberalism And Economic Freedom Pierce Randall University of Pennsylvania Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/edissertations Part of the Philosophy Commons Recommended Citation Randall, Pierce, "Egalitarian Liberalism And Economic Freedom" (2019). Publicly Accessible Penn Dissertations. 3680. https://repository.upenn.edu/edissertations/3680 This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/edissertations/3680 For more information, please contact [email protected]. Egalitarian Liberalism And Economic Freedom Abstract This dissertation considers three major challenges to egalitarian liberal institutions made by classical liber- als: that egalitarian liberal institutions involve too much coercive interference with individual economic decisions, that free markets tend to do better at rewarding people on the basis of their economic choices, and that only by recognizing full liberal rights of ownership can a society best promote a stable property regime consistent with our pre-political conventions of ownership. Each of these objections fails, but they point to an underlying concern that egalitarian liberal institutions fail to adequately protect economic freedom. The dissertation then develops and defends a conception of economic freedom that is reflected in egalitar- ian liberal institutions. Economic freedom depends on the quality and availability of options individuals have in markets, -

Liberal Philosophy and Globalization
Original Paper UDC [141.7:329.12]: 316.42.063.3 Received April 22nd, 2009 Mislav Kukoč University of Split, Faculty of Philosophy, Ivana pl. Zajca b.b., HR–21000 Split [email protected] Liberal Philosophy and Globalization Abstract One of numerous definitions of globalization describes it as a dynamic process whereby the social structures of modernity, such as capitalism, bureaucracy, high technology, and philosophy of rationalism and liberalism are spread the world over. Indeed, in that sense, liberalism has in general prevailed as the authoritative policy frame- work in present-day globalization. Most governments have promoted neoliberal policies toward globalization, as well as influential multilateral agencies have continually linked globalization with liberalization. Champions of neoliberal globalization have also abound- ed in commercial circles, particularly in the financial markets and among managers of transborder firms. Business associations and business-oriented mass media have likewise figured as bastions of neoliberalism which has overall ranked as policy orthodoxy in re- spect of globalization. Generally speaking, neoliberal ideas recently gained widespread unquestioned acceptance as “common sense”. On the other hand, neoliberalism as a sort of philosophical, political and economic theory known as libertarianism, which has generally prevailed as theoretical approach in contem- porary globalization, does not have much in common with the ideal of liberal democracy of well-ordered society, which arises from quite different ideas, aspects and dimensions of liberal philosophy. Social philosophy of liberalism, developed by Kant, Hayek, Dworkin and Rawls, has pro- moted the idea of modern liberal democracy which is generally based on the rule of law, protection of human and civil rights, ideas of equality and justice as fairness.