Studi Emigrazione Roma
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Opera Ad Redactionem Missa VI-2017
Opera ad Redactionem missa VI-2017 Medioevo latino. Bollettino bibliografico della cultura europea da Boezio a Erasmo (secoli VI-XV) A Companion to Giles of Rome cur. Charles Fairbank Briggs - Peter S. Eardley, Leiden, E.J. Brill 2016 pp. XI-319 (Brill's Companions to the Christian Tradition. A Series of Handbooks and Reference Works on the Intellectual and Religious Life of Europe, 500-1800 71) Girolamo Arnaldi - Federico Marazzi Tarda Antichità e Alto Medioevo in Italia Roma, Viella 2017 pp. 231 (La storia. Temi 58) Monica Berté - Marco Petoletti La filologia medievale e umanistica Bologna, Il Mulino 2017 pp. 293 (Manuali Filologia e critica letteraria) Claus Ulrich Blessing Sacramenta in quibus principaliter salus constat. Taufe, Firmung und Eucharistie bei Hugo von St. Viktor Berlin, LIT-Verlag 2017 pp. 740 (Österreichische Studien zur Liturgiewissenschaft und Sakramententheologie 8) Orazio Antonio Bologna (ed. trad. comm.) Giovanni Pietro Arrivabene Gonzagide. Poema epico in quattro libri (sec. XV) praef. Manlio Sodi, Roma, Viella 2017 pp. X-226 (Studia humanitatis 1) Maria Burger (trad.) Albert der Große Super primum librum Sententiarum distinctio 3: De imagine. Das Bild Gottes im Menschen Freiburg i.Br.-Basel- Wien, Herder Verlag 2017 pp. 201 (Herders Bibliothek der Philosophie des Mittelalters 40) Guido Maria Cappelli Maiestas. Politica e pensiero politico nella Napoli aragonese (1443-1503) Roma, Carocci 2016 pp. 235 (Biblioteca di testi e studi 1097) Oronzo Casto (ed. comm.) Giuseppe Beschin (trad.) San Bonaventura Commento all'Ecclesiaste Roma, Città Nuova 2015 pp. 416 (Opere di San Bonaventura 8) Commercio, finanza e guerra nella Sardegna tardomedievale cur. Olivetta Schena - Sergio Tognetti, Roma, Viella 2017 pp. -
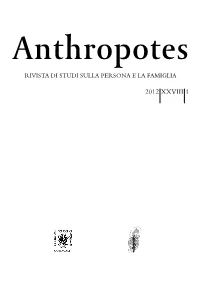
2012 Xxviii 1
Anthropotes RIVISTA DI STUDI SULLA PERSONA E LA FAMIGLIA 2012 XXVIII 1 ANTHROPOTES Rivista ufficiale del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia Direttore Scientifico: Livio Melina Direttore Editoriale: José Noriega Comitato dei Consulenti: Carl A. Anderson (Washington, D.C.); Domingo Basso (Buenos Aires); S. E. Mons. Jean Louis Brugues (Roma); Carlo Cardinal Caffarra (Bologna); Roberto Colombo (Roma); John Finnis (Oxford); Luke Gormally (London); José Granados (Roma); Stanislaw Grygiel (Roma); Stephan Kampowski (Roma); S. E. Mons. Jean Laffitte (Roma); Antonio Lopez (Washington, D.C.); Nikolaus Lobkowicz (Eichstätt); Gilfredo Marengo (Roma); Pedro Morandé Court (Santiago de Chile); S. E. Mons. Gerhard L. Müller (Regensburg); Bruno Ognibeni (Roma); Marc Cardinal Ouellet (Roma); S. E. Mons. Juan Antonio Reig Plá (Alcalá de Henares); David Schindler (Washington, D.C.); Angelo Cardinal Scola (Venezia); Andrej Szostek (Lublino); Pedro Juan Viladrich (Pamplona); Gianfrancesco Zuanazzi (Verona). Redazione: Prof. José Noriega, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II Piazza San Giovanni in Laterano, 4 – 00120 Città del Vaticano Tel.: ++39 06698 95 535 - Fax: ++39 06698 86 103 E-mail: [email protected] Internet: http://www.istitutogp2.it/anthropotes.htm Segretaria di Redazione: Susanna Befani Abbonamenti: Edizioni Cantagalli srl Via Massetana Romana, 12 – C.P. 155 – 53100 SIENA Te l. ++39 0577/42102 - Fax ++39 0577 45363 E-mail: [email protected] Pagina web: www.edizionicantagalli.com/anthropotes -

Augustin (Saint, 0354-0430)
1/61 Data Augustin (saint, 0354-0430) Langue : Latin Sexe : Masculin Naissance : 13-11-0354 Mort : 28-08-0430 Note : Docteur de l'Église latine. - Évêque d'Hippone Domaines : Religion Autres formes du nom : Augustinus (saint, 0354-0430) (latin) Augustine (saint, 0354-0430) (anglais) Augustin d'Hippone (0354-0430) (français) Augustinus Hipponensis (0354-0430) (latin) Aurelius Augustinus (0354-0430) (latin) Aurelius Augustinus Hipponensis (0354-0430) (latin) ISNI : ISNI 0000 0001 2137 6443 (Informations sur l'ISNI) Augustin (saint, 0354-0430) : œuvres (1 376 ressources dans data.bnf.fr) Œuvres textuelles (1 287) De spiritu et anima a été publié sous le nom de Collatio cum Pascentio ariano attribué, à tort, à Augustin (saint, 0354-0430) Augustin (saint, 0354-0430) (1151) (500) Sermones tres de symbolo attribué autrefois à Augustin Sur le don de la persévérance (saint, 0354-0430) (428) (435) De la prédestination des saints De haeresibus (428) (428) Conlatio cum Maximino Arrianorum episcopo La doctrine chrétienne (427) (426) Les révisions De miraculis sancti Stephani protomartyris attribué, à (426) tort, à Augustin (saint, 0354-0430) (425) data.bnf.fr 2/61 Data Sur la grâce et le libre arbitre Manuel (425) (421) Contra adversarium Legis et Prophetarum Contre le mensonge (420) (420) Nature et origine de l'âme Mariage et concupiscence (420) (419) Contra sermonem arianorum Commentaire de la première épître de saint Jean (418) (415) Ad Demetriadem attribué, à tort, à Augustin (saint, La foi et les oeuvres 0354-0430) (413) (414) -

Antonio Rosmini on Property It Showed Itself As a Part of God’S Calling
Journal of Markets & Morality Volume 7, Number 1 (Spring 2004): 63–97 Copyright © 2004 A Sphere Around Alberto Mingardi Policy Director the Person: Istituto Bruno Leoni (Turin, Italy) Antonio Rosmini and Visiting Fellow Centre for the New Europe on Property* (Brussels, Belgium) Father Antonio Rosmini-Serbati (1797–1855) is an author of growing interest and curiosity to his fellow churchmen, as well as to secular intellectuals, as a philosopher who successfully reconciled reason and faith. Nevertheless, the political nuances of his thought have barely been explored by English-speaking scholars, and even among his Italian followers these have not been fully appre- ciated. This article attempts to present an overview of Rosmini’s political philoso- phy, focusing on his concern for the protection of private property rights and arguing that it is precisely his advocacy of private property that determines his attitude toward the general organization of associated life, government, and democracy. The organization of this investigation consists of four parts. The first pro- vides a brief biographical sketch of Antonio Rosmini. The second tentatively enlists the main influences in the development of Rosmini’s thought as far as politics and economics are concerned. The third is devoted to examining his approach toward property. The fourth examines his definition of social justice in the light of his justification of property. Introduction In this article, I introduce the reader to the figure of Antonio Rosmini, provide a biographical sketch, and subsequently approach his thought on private prop- erty. As a priest and a devout Catholic, religious faith was central to every aspect of Rosmini’s philosophy. -

Écrits Sur Bergson
Écrits sur Bergson 1890 Georges Lechalas. “Le Nombre et le temps dans leur rapport avec l’espace, à propos de Les Données immédiates. ” Annales de Philosophie Chrétienne, N.S. 23 (1890): 516-40. Print. Eng. trans. “Number and Time in Relation to Space, as Concerns Time and Free Will .” 1893 Maurice Blondel. L’action. Essai d’une critique de la vie et d’une science de la pratique . Paris: Alcan, 1893, 495. (Bibliographie de Philosophie Contemporaine) Eng. trans. Action . This item is republished in 1950, Presses Universitaires de France. 1894 Jean Weber. “Une étude réaliste de l’acte et ses conséquences morales.” Revue de métaphysique et de morale . 2.6, 1894, 331-62. Eng. trans. “A Realist Study of the Act and its Moral Consequences.” 1897 Gustave Belot. “Un Nouveau Spiritualisme.” Revue Philosophique de la France et de l’Etranger , 44.8 (August 1897): 183-99. The author sees a danger of materialism in Matter and Memory. Print. Eng. trans. “A New Spiritualism.” Victor Delbos. “Matière et mémoire, étude critique.” Revue de Métaphysique et de Morale , 5 (1897): 353- 89. Print. Eng. trans. “ Matter and Memory , A Critical Study.” Frédéric Rauh. “La Conscience du devenir.” Revue de Métaphysique et de Morale , 4 (1897): 659-81; 5 (1898): 38-60. Print. Eng. trans. “The Awareness of Becoming.” L. William Stern. “Die psychische Präsenzzeit.” Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane 13 (1897): 326-49. The author strongly criticizes the concept of the point-like present moment. Print. Eng. trans. “The Psychological Present.” 1901 Émile Boutroux. “Letter to Xavier Léon. July 26, 1901” in Lettere a Xavier Léon e ad altri. -

Stampa Catalogo 21/04/15 11,21 O3 SCIENZE DELLA STORIA Foscaro Paola Pag
SebinaOpenLibrary 3.00 Stampa catalogo 21/04/15 11,21 O3 SCIENZE DELLA STORIA Foscaro Paola Pag. 1 di 407 Catalogo: Biblioteca Ordinamento: Autore principale + Titolo Solo inv. biblioteca corrente *1000 Jahre deutsch-italienischer Beziehungen : Die Ergebnisse der deutsch-italienischen Historikertagungen in Braunschweig (1953), Goslar (1956), Siena (1957), Bamberg (1958) und Erice (1959) 1 Id: 1236473 SBL0185344 Testo a stampa (moderno) Monografia 1960 MED 26/03/2009 *1000 Jahre deutsch-italienischer Beziehungen : Die Ergebnisse der deutsch-italienischen Historikertagungen in Braunschweig (1953), Goslar (1956), Siena (1957), Bamberg (1958) und Erice (1959). - Braunschweig : Limbach, 1960. - 223 p. ; 24 cm. (*Schriftenreihe des Internationalen Schulbuchinstituts ; 5) BOMS 6165-1818 ; HA PER ALTRO TITOLO 1537282 SBL0185345 *Tausend Jahre deutsch-italienischer Beziehungen. N. inv. 153 61493 10L. F.AGNOLETTO. C.0936 *11. Convegno Storico Toscano : il problema politico del Cattolicesimo nel Risorgimento : Castiglioncello, 25- 28 aprile 1958 2 Id: 1232483 USM1800506 Testo a stampa (moderno) Monografia 1958 REC 24/02/2009 *11. Convegno Storico Toscano : il problema politico del Cattolicesimo nel Risorgimento : Castiglioncello, 25-28 aprile 1958 / Società Italiana per la Storia del Risorgimento. - Firenze : Il Cenacolo, 1958. - [5] p. ; 16 cm. I *Società *toscana per la *storia del *Risorgimento Autore secondario N. inv. 153 60581 10L. F.AGNOLETTO. D.0138 *14. Convegno Storico Toscano : "La destra storica nel quadro del liberalismo europeo" : Siena, 1-4 giugno 1961 3 Id: 1225085 USM1791151 Testo a stampa (moderno) Monografia 1961 MIN 17/12/2008 *14. Convegno Storico Toscano : "La destra storica nel quadro del liberalismo europeo" : Siena, 1-4 giugno 1961. - Firenze : Il Cenacolo, 1961. - 31 p. ; 16 cm. -

'Il Primitivo Breviario Francescano', Miscellanea Francescana 60 (1960), 47-240
Abate 1960 - Abate, G.: 'Il primitivo breviario francescano', Miscellanea francescana 60 (1960), 47-240 Abert 1905 - Abert, Hermann: Die aesthetischen Grundsätze der mittelalterlichen Melodiebildung (Halle 1905) Abert 1905 - Abert, Hermann: Die Musikanschauung des Mittelalters und ihre Grundlagen (Halle 1905) Abrahamsen 1923 - Abrahamsen, Erik: Éléments romans et allemands dans le chant grégorien et la chanson populaire en Danemark, Publications de l'Académie grégorienne de Fribourg (Suisse) 11 (Copenhagen 1923) Ackermans 2012 - Ackermans, Franco: 'Custos in campo aperto', Beiträge zur Gregorianik 54 (2012), 55-58 Acta sanctorum - Acta sanctorum collecta . a Sociis Bollandianis (Antwerp 1643- ; 3rd edn., Paris and Brussels 1863 ) Acta sanctorum ordinis sancti Benedicti - Acta sanctorum ordinis sancti Benedicti, ed. Jean Mabillon, Luc d'Achery, et al. (9 vols., Paris 1668-1701) Adamko 2010 - Adamko, Rastislav: 'Spišský liturgický kalendár na základe zachovaných rukopisov v Spišskej Kapitule a Alba Iulii' / 'The Spiš calendar on the basis of the preserved liturgical manuscripts in the Spiš Chapter and Alba Iulia', Musica mediaeva liturgica. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dòa 4.-5. mája 2010, ed. Rastislav Adamko (Ružomberok 2010), 36-67 [parallel Slovak and English texts] Adler Festschrift 1930 - Studien zur Musikgeschichte: Festschrift für Guido Adler (Vienna 1930) Adsuara 1995 - Adsuara, Clara: 'Remarks on the structure of kalophonic stichera: working hypotheses', Cantus Planus Sopron 1995, 1-16 Aengenvoort 1955 - Aengenvoort, J.: Quellen und Studien zur Geschichte der Graduale Monasteriense, Kölner Beiträge zur Musikforschung 9 (Regensburg 1955) Agee 2007 - Agee, Richard J.: 'The printed dissemination of the Roman Gradual in Italy during the early modern period', Notes 64 (2007), 9-42 Agee 2011 - Agee, Richard J.: 'Ideological Clashes in Cinquecento Editon of Plainchant', Music, Dance, and Society. -

Franascan STUDIES a Quarterly Review
FRANaSCAN STUDIES A Quarterly Review V O L U M E 7 DECEMBER 1947 CONTENTS T h e 'Theologism ” o f Duns Scotus (P a rt I I ) by Alim B. Wolter, O.P.M. 367 Porerty in Perfectíon According to St. Bonaventure (Patt II) by Aidán Carr, O.F.M, Conv.___________ 415 Chfist Jesus the Secure Foundation According to St. Cyril of Alexandria (Part III) by Dominic J. Ungér, O.F.M. Cap. ______ 399 The litany of the Saints in the Breviary of the Román Curia and the Frtars Minor before Haymo of Faversham by Aurelian van Dijk, O.F.M. ___ _____ _ 4 26 Franciscan Bibliography fór 1946 by Irenaeus Herscher, ______ 4 3 9 Book Reviews — 508 Books Receivcd - 516 Editors Thkhcas PLASSMANN, O.F.M. PHILOTHEUS BOBKNBK, OJE'.M. Assistant Editors BAsn. H bisek , O .F.M . Co n v . Theodorb Robmbk, OJP31 C a p . Managing Editor Bo n a v e n t u r e Br o w n , O.F.M . COPYRIGHT 1947 Publishei by IHE FRANaSCAN INSTITUTE St. Bonavbntorb, N .Y. Under the Sponsorship of T h b Fk a n c b c a n Ed u c a t io n a l Co n f b k b n c e BOOK REVIEWS Péfe M. J. Ugrange, O.P.: The Gospel of Jesus Christ Joseph L Lilly, C M . l«ón Amorós, Bernardo Apperíbay, O.F.M., and Miguel Ofomí, O.F.M. (Editors): Obras de San Buenaventura Philotheus Boehner, O.F.M. Efrem Beitoni, O.F.M.: V m t’ Anni di Studi Scotisti (1920-1940) AUan B. -

Temas Medievales 17
TEMAS MEDIEVALES 17 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS INSTITUTO MULTIDISCIPLINARIO DE HISTORIA Y CIENCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES MEDIEVALES BUENOS AIRES, 2009 1 Ilustración de tapa: Diagrama del tímpano de la fachada oeste Priorato de Villesalem (Vienne – Francia) Diseño de tapa: Pablo Guiance Temas Medievales se propone como un ámbito interdisciplinario de reflexión, discusión y divulgación de asuntos referidos a historia, filosofía, literatura, arte medievales… Creada por un grupo de investigadores argentinos, intenta nuclear y acoger los trabajos y contribuciones de estudiosos de la especialidad. Artículos y notas críticas aspiran a dar razón de los intereses actuales de la historiografía del período, de sus tendencias y realizaciones, constituyendo volúmenes en que prime un eje temático sin dejar de incorporar otros varios enfoques. El presente volumen ha sido parcialmente financiado por la Sociedad Argentina de Estudios Medievales (SAEMED). 2 TEMAS MEDIEVALES Publicación del Departamento de Investigaciones Medievales (DIMED) Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas (IMHICIHU) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Director Nilda Guglielmi Consejo Consultivo Michel Balard (Universidad de París I – Francia) Franco Cardini (Universidad de Florencia – Italia) Salvador Claramunt (Universidad de Barcelona – España) Giovanni Cherubini (Universidad de Florencia – Italia) Jean Delumeau (Collège de France) Peter Dinzelbacher (Universidad de Salzburgo -

I 40 Anni Della CCDC Una Storia Lunga E Appassionata
Rolando Anni I 40 anni della CCDC una storia lunga e appassionata 1976 - 2016 Nel XL anno di attività della Cooperativa Cattolico-democratica di Cultura Cooperativa Padri filippini Cattolico-democratica di Cultura della Pace Venerdì 31 marzo 2017, ore 20,45 Sala Bevilacqua, via Pace n.10 - Brescia L’Europa al bivio Massimo Bordignon professore di Scienza delle Finanze nell’Università Cattolica di Milano, membro dell’European Fiscal Board Daniel Gros direttore del Centre for European Policy Studies (CEPS) www.ccdc.it Stampato per conto della Cooperativa Cattolico-democratica di Cultura via XX Settembre 72 - 25121 Brescia tel. 030 37421 www.ccdc.it I 40 ANNI DELLA CCDC una storia lunga e appassionata Interventi di: Rolando Anni Emilio Del Bono Michele Nicoletti 1976 - 2016 Nel XL anno di attività della Cooperativa Cattolico-democratica di Cultura Indice Quarant’anni cruciali 7 Emilio Del Bono Ringraziamenti 11 Filippo Perrini, Mariagrazia Dusi, Alberto Franchi La Cooperativa Cattolico-democratica di Cultura: una lunga storia 19 Rolando Anni Organi Sociali 47 Gli incontri di cultura 53 1. Conferenze e dibattiti 2. Pietre d’inciampo 87 3. Mostre 88 4. Spettacoli e concerti 90 5. Cinema 94 6. Libri 97 La reinvenzione del “cattolicesimo democratico”: l’esperienza della CCDC 101 Michele Nicoletti Quarant’anni cruciali Emilio Del Bono* La Storia non è un semplice cammino lineare, non è un percorso che conduce l’umanità inevitabilmente verso il progresso. La dimensione cristiana, grazie a una visione del mondo che non ripone le sue aspettative soltanto nella realtà immanente, può difenderci da questo potenziale abbaglio, perché consente di confrontarsi con i mutamenti della modernità, senza cedere a un infantile ottimismo. -

L'esperienza Ermeneutica Del «Verbum in Corde». Heidegger, Gadamer E Ricœur Interpreti Di Agostino
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI VERONA DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA DOTTORATO DI RICERCA IN FILOSOFIA CICLO XXIII TITOLO DELLA TESI DI DOTTORATO L’esperienza ermeneutica del «verbum in corde». Heidegger, Gadamer e Ricœur interpreti di Agostino Coordinatore: Prof. Ferdinando L. Marcolungo Tutor: Prof. Mario G. Lombardo Dottorando: Dott. Alberto Romele 1 INDICE INTRODUZIONE................................................................................p. 1. PARTE PRIMA. L’ESPERIENZA ERMENEUTICA DEL VERBUM IN CORDE. GADAMER INTERPRETE DI AGOSTINO...........................................p. 11. 1. LA NOZIONE DI VERBUM IN CORDE IN AGOSTINO........................p. 19. 1.1. Platone, Aristotele, i dogmatici e oltre..............................................p. 19. 1.2. La corrente giovannea...................................................................p. 28. 1.3. Agostino.....................................................................................p. 31. 1.4. Dopo Agostino.............................................................................p. 40. 2. GADAMER INTERPRETE DELLA NOZIONE AGOSTINIANA DI VERBUM IN CORDE..........................................................................................p. 42. 2.1. Uso strumentale di una nozione......................................................p. 42. 2.2. Una nozione pensata “fino in fondo”..............................................p. 45. 2.3. Una nozione davvero compresa.......................................................p. 48. 3. LA NOZIONE DI VERBUM -

Muka I Križ Isusa Krista U Spisima Franje Asiškoga I Izabranih Franjevačkih Teologa, Propovjednika I Mistika
Bogoslovska smotra, 88 (2018.) 1, 73–102 UDK 27-284-789.32-312.8-587-475.2 Primljeno: 14. 7. 2017. Prihvaćeno: 22. 2. 2017. Izvorni znanstveni rad Muk A I KRIž IsusA KRISTA U SPISIMA FRANJE ASIšKOGA I IZABRANIH FRANJEVAčKIH TEOLOGA, PROPOVJEDNIKA I MISTIKA Daniel PATAFTA Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb [email protected] Sažetak Ljubav Franje Asiškoga prema Isusu Kristu očitovala se u dvije točke: euharistiji i mu- ci. Otajstvo muke postalo je dominantno u Franjinu životu. Njegov put svetosti od sv. Damjana do La Verne govori o putu koji je bio obilježen patnjom i križem. Od tada Kri- stova patnja postaje dominantno polazište u franjevačkoj teologiji, mistici i propovjed- ništvu. Polazište za ovaj rad jest Franjina vizija raspetog Krista u njegovim autografima i kako su to zabilježili njegovi životopisci. Na temelju tih izvora daje se uvid u njegovo razmatranje, pobožnost i osobni doživljaj Kristove muke i križa. Nakon temelja koji je postavio Franjo Asiški prelazi se na teološko promišljanje i mistični doživljaj Kristove muke kod sv. Bonaventure, kojeg se naziva »teologom muke«. Bonaventurin nauk po- četak je sustavnoga teološkog promišljanja o Kristovoj muci na početcima franjevačke teološke i filozofske škole u XIII. stoljeću. Kod analize Bonaventurina nauka o križu obrađena su dva bitna vida tog nauka, koji sažimaju njegov teološki pristup muci i križu i postaju temelj franjevačke duhovnosti, osobito mistike, i propovjedništva u ka- snijim stoljećima. Franjevačko propovjedništvo obilježit će imena sv. Bernardina Sijen- skoga i njegovih učenika sv. Ivana Kapistrana i bl. Jakova Markijskoga, zatim mistiku imena bl.