Filmografia Di Frederick Wiseman
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Padis Opeda Ballet
FREDERICK WISEMAN BIOGRAPHY Frederick Wiseman is an American filmmaker, born on January 1969, Hospital in 1970, Juvenile Court in 1973 and Welfare 1st, 1930, in Boston, Massachusetts. A documentary filmmaker, in 1975. In addition to Zoo (1993), he directed three other most of his films paint a portrait of leading North American documentaries on our relationship with the animal world: Primate institutions. in 1974, Meat in 1976 and Racetrack in 1985 respectively about After studying law he started teaching the subject without any real scientific experiments on animals, the mass production of beef interest. In decided he should work at something he liked and had cattle destined for the slaughterhouse and consumers and the the idea to make a movie of Warren Miller’s novel, The Cool World. Belmont racetrack one of the major American racetracks. Since at that point he had no film experience he asked Shirley He began an examination of the consumer society with Model in Clarke to direct the film. ProducingThe Cool World demystified the 1980 and The Store in 1983. The sharpness of his gaze, his biting film making process for him and he decided to direct, produce and humour and his compassion characterize his exploration of the edit his own films. Three years later came the theatrical release of model agency and the big store Neiman Marcus, temples of western his first documentary,Titicut Follies, an uncompromising look at a modernity. In 1995, he slipped into the wings of the theatre and prison for the criminally insane. directed La Comédie-Française ou l’amour joué. -

Frederick Wiseman
Miranda Revue pluridisciplinaire du monde anglophone / Multidisciplinary peer-reviewed journal on the English- speaking world 15 | 2017 Lolita at 60 / Staging American Bodies Compte-rendu de Journée d’étude : Frederick Wiseman, « Ordre et résistance » Université Toulouse Jean Jaurès, Cinémathèque de Toulouse, 19 mai 2017 /Organisée par Zachary Baqué (CAS) et Vincent Souladié (PLH) Youri Borg et Damien Sarroméjean Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/miranda/10953 DOI : 10.4000/miranda.10953 ISSN : 2108-6559 Éditeur Université Toulouse - Jean Jaurès Référence électronique Youri Borg et Damien Sarroméjean, « Compte-rendu de Journée d’étude : Frederick Wiseman, « Ordre et résistance » », Miranda [En ligne], 15 | 2017, mis en ligne le 04 octobre 2017, consulté le 16 février 2021. URL : http://journals.openedition.org/miranda/10953 ; DOI : https://doi.org/10.4000/miranda. 10953 Ce document a été généré automatiquement le 16 février 2021. Miranda is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. provided by OpenEdition View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk CORE brought to you by Compte-rendu de Journée d’étude : Frederick Wiseman, « Ordre et résistance » 1 Compte-rendu de Journée d’étude : Frederick Wiseman, « Ordre et résistance » Université Toulouse Jean Jaurès, Cinémathèque de Toulouse, 19 mai 2017 /Organisée par Zachary Baqué (CAS) et Vincent Souladié (PLH) Youri Borg et Damien Sarroméjean 1 Organisée par les laboratoires CAS et PLH, en association avec la Cinémathèque de Toulouse, cette journée d’étude consacrée à Frederick Wiseman se propose d’aborder l’œuvre dense d’un cinéaste américain majeur du genre documentaire, reconnu tant par la critique que par ses pairs, mais dont les films (Titicut Follies (1967), Primate (1974) et Public Housing (1997) pour citer les plus connus) sont paradoxalement peu vus. -

Untersucht an Einem Film Von Frederick Wiseman
Abschlussarbeit zur Erlangung der Magistra Artium im Fachbereich Theater-, Film und Medienwissenschaft der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft Repräsentationsformen des Direct Cinema – untersucht an einem Film von Frederick Wiseman 1. Gutachterin: Prof. Dr. Heide Schlüpmann 2. Gutachter: Prof. Dr. Burkhardt Lindner vorgelegt von: Esther Zeschky aus: Schotten Einreichungsdatum: 09. 07. 2002 1 Antje, für alles. Thank You! 2 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 4 2. Vom non-fiction-Film zur documentary Frühe Formen des Dokumentarfilms 8 3. Das amerikanische Direct Cinema der 60er Jahre 17 3.1 Einflüsse auf das Direct Cinema 24 3.2 Ästhetik, Authentizität und Objektivität im Direct Cinema 41 3.3 Die Drew Associates 45 3.3.1 Die Erzählstruktur der Drew-Filme 52 3.3.2 Leacocks und Pennebakers Trennung von den Drew Associates und andere Filmemacher des Direct Cinema 55 4. Der Dokumentarfilmer Frederick Wiseman 57 4.1 Frederick Wisemans Vorgehensweise 64 4.2 Analyse des Films High School (1968) 69 5. Schlussbemerkung 83 6. Literaturverzeichnis 89 7. Anhang 85 Segmentierung des Films High School (1968) 96 Abbildungen 101 Frederick Wiseman’s Documentary Films 102 3 1. Einleitung Every film is a documentary. Even the most whimsical of fictions gives evidence of the culture that produced it and reproduces the likenesses of the people who perform within it. In fact, we could say that there are two kinds of film: (1) documentaries of wish-fulfillment and (2) documentaries of social representation. Each type tells a story, but the stories, or narratives, are of different sorts.1 Wie Bill Nichols in obigem Zitat treffend zum Ausdruck bringt, gibt es keine scharfe Trennungslinie zwischen Dokumentarfilm und Spielfilm. -

COM 321, Documentary Form in Film & Television
1 COM 321, Documentary Form in Film, Television, & Interactive Media Notes from and about Barnouw’s Documentary: A history of the non-fiction film 11. Documentarist as. Observer Definition(s): [British] Free Cinema—A series of showings at London’s National Film Theater, 1956-58 with films by such filmmakers as Lindsay Anderson (primarily known for his narrative films If. ., O Lucky Man), Karel Reisz & Tony Richardson (primarily known for his narrative films The Entertainer, Tom Jones), and Georges Franju (see below); characterized by filmmakers acting as observers, rejecting the role of promoter; made possible by new, light film equipment that allowed an intimacy of observation new to documentary (including both sound and image). [American] Direct Cinema—A term coined by filmmaker Albert Maysles, this is another type of “observer” documentary that attempts to limit the apparent involvement of the filmmaker, using little or no voiceover narration, no script, and no “setting up” subjects (stagings) or reenactments. As David Maysles has indicated, “direct” means “there’s nothing between us and the subject.” Following the British Free Cinema, the American Direct Cinema took advantage of the new, maneuverable 16mm film equipment; after a series of experiments, a wireless synchronizing sound system for this equipment was developed by the Drew Unit at Time, Inc. The main Documentarists: Robert Drew, Ricky Leacock, D. A. Pennebaker, David & Albert Maysles (and associates), Frederick Wiseman. The influence of Direct Cinema has been felt around the world (e.g., prominent films from Holland, Japan, India, Sweden, Canada). [French] Cinema Verite—According to Barnouw, this term is reserved for films following Jean Rouch’s notions of filmmaker as avowed participant, as provocateur (as what Barnouw calls catalyst), rather than the cool detachment of the Direct Cinema. -

Frederick Wiseman : Titicut Follies Est Une Comédie Musicale! »
ENTRETIENS Baumann, Fabien. « Entretien avec Frederick Wiseman : Titicut Follies est une comédie musicale! ». Positif, no 581-582, juillet-août 2009, pp.66-68. Ill. Le réalisateur Frederick Wiseman commente son film TITICUT FOLLIES et sa façon de présenter la folie. Repères bibliographiques 81 Béghin, Cyril. « Wiseman sur le ring ». Cahiers du Cinéma, no 656, mai 2010, pp.34-35. Ill. Le réalisateur Frederick Wiseman parle de son documentaire BOXING GYM, à l’occasion de sa projection au Festival de Cannes. Frederick Wiseman Mikles, Laetitia ; Lévy, Delphine. « Entretien avec Frederick Wiseman : un de 9 au 20 novembre 2011 mes films les plus abstraits ». Positif, no 608, octobre 2011, pp.37-41. Entretien avec Frederick Wiseman à propos de son film CRAZY HORSE, où le cinéaste présente l’origine du projet et l’approche qu’il a préconisée lors du tournage. Peary, Gerald ; Mikles, Laetitia. « Une leçon de sociologie : l'oeuvre de Frederick Wiseman ; Frederick Wiseman : "Je suis incapable de prononcer des vérités générales" ». Positif, no 445, mars 1998, pp.86-95. Ill. Analyse de l'oeuvre du documentariste Frederick Wiseman, accompagnée d'un entretien. Le cinéaste parle de ses méthodes de travail, de sa conception du documentaire et de la réalisation de PUBLIC HOUSING. Rapold, Nicolas. « The organisation man ». Sight & Sound, vol XIX, no 11, novembre 2009, p.23. Ill. Entretien avec Frederick Wiseman à propos de son film LA DANSE, LE BALLET DE L’OPÉRA DE PARIS, où il est notamment question de l’intérêt du cinéaste envers l’organisation entourant cette troupe de danse, et de sa première utilisation du logiciel Avid pour le montage de ce film. -

Frederick Wiseman: MONROVIA, INDIANA (2018, 143M) the Version of This Goldenrod Handout Sent out in Our Monday Mailing, and the One Online, Has Hot Links
April 30, 2019 (XXXVIII: 13) Frederick Wiseman: MONROVIA, INDIANA (2018, 143m) The version of this Goldenrod Handout sent out in our Monday mailing, and the one online, has hot links. Spelling and Style—use of italics, quotation marks or nothing at all for titles, e.g.—follows the form of the sources. DIRECTOR Frederick Wiseman PRODUCED BY Frederick Wiseman CINEMATOGRAPHY John Davey EDITING Frederick Wiseman SOUND EDITOR Valérie Pico FREDERICK WISEMAN (b. January 1, 1930 in Boston, Massachusetts) is an American documentary filmmaker (47 credits). His work is "devoted primarily to exploring American institutions.” He has been called "one of the most important and original filmmakers working today” (New York Times). After graduating from Yale Law School in 1954, Wiseman served in the military before taking a teaching position at Boston University Institute of Law and Medicine. It was at this time that he also began pursuing documentary filmmaking. He has received honorary doctorates from Bowdoin College, Princeton University, and Williams College, among others. He is a MacArthur Fellow, a Fellow of the American Academy of Arts and Sciences, an Honorary Member of the American Academy of Arts and Letters, and a recipient of a Guggenheim structure.” The notion that he is interested in finding a narrative Fellowship. He has won numerous awards, including four angle also complements his view that it is impossible for a Emmys. He is also the recipient of the Career Achievement documentary filmmaker to be completely objective or unbiased Award from the Los Angeles Film Society (2013), the in relation to his or her subject. -
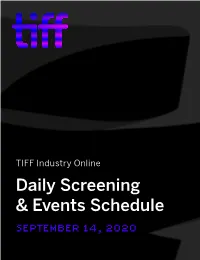
Daily Screening & Events Schedule
TIFF Industry Online Daily Screening & Events Schedule SEPTEMBER 14, 2020 TORONTO’S LARGEST PURPOSE-BUILT STUDIO The leading destination facility for f ilm and TV production New space coming soon Talk to us: t: +1 416 406 1235 e: [email protected] For further information on our studio, please visit: www.pinewoodtorontostudios.com I Industry user access P Press user access Press & Industry B Buyer user access * Availability per country on the schedule at TIFF.NET/INDUSTRY Daily Schedule Access TIFF Digital Cinema Pro September 14, 2020 at DIGITALPRO.TIFF.NET NEW TODAY Films are available for 48 hours from start time. 10 AM BECKMAN NEUBAU PIRATES DOWN THE STREET SWEAT EDT 90 min. | TIFF Digital Cinema Pro 82 min. | TIFF Digital Cinema Pro 90 min. | TIFF Digital Cinema Pro 80 min. | TIFF Digital Cinema Pro Private Screening Private Screening Private Screening TIFF Industry Selects I P B P B I B I P B FAIRY THE NORTH WIND RIVAL TELEFILM CANADA FIRST LOOK 152 min. | TIFF Digital Cinema Pro 122 min. | TIFF Digital Cinema Pro 96 min. | TIFF Digital Cinema Pro 51 min. | TIFF Digital Cinema Pro Private Screening Private Screening Private Screening Private Screening B B B I B LOVERS PEARL OF THE DESSERT SHOULD THE WIND DROP WISDOM TOOTH 102 min. | TIFF Digital Cinema Pro 86 min. | TIFF Digital Cinema Pro 100 min. | TIFF Digital Cinema Pro 104 min. | TIFF Digital Cinema Pro TIFF Industry Selects Private Screening TIFF Industry Selects Private Screening B I P B I P B I B 11 AM BANDAR BAND CITY HALL GOOD JOE BELL TRICKSTER EDT 75 min. -

The Poetry of Reality: Frederick Wiseman and the Theme of Time
THE POETRY OF REALITY: FREDERICK WISEMAN AND THE THEME OF TIME Blake Jorgensen Wahlert, B.A. Thesis Prepared for the Degree of MASTER OF ARTS UNIVERSITY OF NORTH TEXAS May 2019 APPROVED: Harry M. Benshoff, Major Professor George Larke-Walsh, Committee Member Melinda Levin, Committee Member Eugene Martin, Chair of the Department of Media Arts David Holdeman, Dean of the College of Liberal Arts and Social Sciences Victor Prybutok, Dean of the Toulouse Graduate School Wahlert, Blake Jorgensen. The Poetry of Reality: Frederick Wiseman and the Theme of Time. Master of Arts (Media Industry and Critical Studies), May 2019, 86 pp., reference list, 74 titles. Employing a textual analysis within an auteur theory framework, this thesis examines Frederick Wiseman’s films At Berkeley (2013), National Gallery (2014), and Ex Libris (2017) and the different ways in which they reflect on the theme of time. The National Gallery, University of California at Berkeley, and the New York Public Library all share a fundamental common purpose: the preservation and circulation of “truth” through time. Whether it be artistic, scientific, or historical truth, these institutions act as cultural and historical safe-keepers for future generations. Wiseman explores these themes related to time and truth by juxtaposing oppositional binary motifs such as time/timelessness, progress/repetition, and reality/fiction. These are also Wiseman’s most self-reflexive films, acting as a reflection on his past filmmaking career as well as a meditation on the value these films might have for future generations. Finally, Wiseman’s reflection on the nature of time through these films are connected to the ideas of French philosopher Henri Bergson. -

TITICUT FOLLIES UN FILM DE FREDERICK WISEMAN Avec Ce Film,Frederick Wiseman Pose Les Bases De Ce Qui Fait Son Cinéma Depuis 50 Ans
COUV MÉTÉORE FILMS ET ZIPPORAH FILMS INC. PRÉSENTENT TITICUT FOLLIES UN FILM DE FREDERICK WISEMAN Avec ce film,Frederick Wiseman pose les bases de ce qui fait son cinéma depuis 50 ans. Pour la première fois sur grand écran en version restaurée 4K. Météore Films et Zipporah Films Inc. présentent TITICUT FOLLIES UN FILM DE FREDERICK WISEMAN 1967 � ÉTATS-UNIS � 84 MIN. � DCP – IMAGE : 1.37 – SON : Mono � VISA : 85323 AU CINÉMA LE 13 SEPTEMBRE EX-LIBRIS - The New York Public Library le nouveau film de Frederick Wiseman sortira en salle le 1er Novembre PRESSE DISTRIBUTION RENDEZ-VOUS MÉTÉORE FILMS Viviana Andriani - Aurélie Dard 11, rue Taylor – 75010 Paris 2, rue Turgot – 75009 Paris Tél : +33(0)1 42 54 96 20 Tél : +33(0)1 42 66 36 35 [email protected] [email protected] [email protected] Photos et dossier de presse téléchargeables sur www.rv-press.com et www.meteore-films.fr SYNOPSIS Bridgewater (Massachusetts), 1967. Frederick Wiseman tourne Titicut Follies, son premier film, dans une prison d’État psychiatrique et atteste de la façon dont les détenus sont traités par les gardiens, les assistants sociaux et les médecins à l’époque. Ce que révèle le film lui a valu d’être interdit de projections publiques aux États-Unis pendant plus de 20 ans. Témoin discret et vigilant des institutions, Frederick Wiseman pose, avec Titicut Follies, les bases de ce qui fait son cinéma depuis 50 ans. Lesquelles ? filmés, comme dans tous les autres Si je réponds à cette question, il faut documentaires. Nous tournions à trois que j’explique le film et je n’aime pas personnes. -

Azette N° 357 Tous Les Programmes Et Horaires
CINÉMA 3 SALLES Du 21 août au 10 septembre2019 Classé Art et Essai/Recherche Labels Jeune public, Répertoire- Patrimoine et Europa Cinémas FILMS ÉTRANGERS EN V.O.S.T. azette N° 357 Tous les programmes et horaires www.cinevillefranche.com Espace Barmondière Les 400 Coups Villefranche 69400 Villefranche sur Saône Programmation établie avec les adhérents Tél : 04.74.65.10.85 de l'association "L'AUTRE CINÉMA" www.autrecinema.fr Pendant que beaucoup d’entre nous essayaient de faire une pause estivale régénératrice (à l’ombre !), le monde du cinéma apprenait une terrible injustice. La victime : le cinéaste iranien Mohammad Rasoulof dont nous avions programmé Un homme intègre (Le titre est déjà un positionnement fort). Ce film pourtant récompensé à Cannes 2017 a depuis, valu de graves ennuis à son auteur et le 22 juillet de cette année il vient même d’être condamné à un an de prison ferme par l‘état iranien pour "atteinte à la sécurité de l’Etat" ! Il y aurait de quoi rire si cela ne se soldait par une telle sanction. A l’heure qu’il est, il a encore la possibilité de faire appel de ce jugement inique… Dans le même temps et toujours à fin juillet - moment où sont écrites ces lignes – Le nouveau chef d’état ukrainien propose aux Russes d’échanger la libération du cinéaste Oleg Sentsov dont nous vous avions parlé l’an dernier au moment de sa grève de la faim, contre celle d’un journaliste russe emprisonné en Ukraine. On se croirait vraiment revenus aux temps cyniques de la guerre froide. -
Frederick Wiseman
Miranda Revue pluridisciplinaire du monde anglophone / Multidisciplinary peer-reviewed journal on the English- speaking world 15 | 2017 Lolita at 60 / Staging American Bodies Compte-rendu de Journée d’étude : Frederick Wiseman, « Ordre et résistance » Université Toulouse Jean Jaurès, Cinémathèque de Toulouse, 19 mai 2017 /Organisée par Zachary Baqué (CAS) et Vincent Souladié (PLH) Youri Borg et Damien Sarroméjean Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/miranda/10953 DOI : 10.4000/miranda.10953 ISSN : 2108-6559 Éditeur Université Toulouse - Jean Jaurès Référence électronique Youri Borg et Damien Sarroméjean, « Compte-rendu de Journée d’étude : Frederick Wiseman, « Ordre et résistance » », Miranda [En ligne], 15 | 2017, mis en ligne le 04 octobre 2017, consulté le 16 février 2021. URL : http://journals.openedition.org/miranda/10953 ; DOI : https://doi.org/10.4000/miranda. 10953 Ce document a été généré automatiquement le 16 février 2021. Miranda is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Compte-rendu de Journée d’étude : Frederick Wiseman, « Ordre et résistance » 1 Compte-rendu de Journée d’étude : Frederick Wiseman, « Ordre et résistance » Université Toulouse Jean Jaurès, Cinémathèque de Toulouse, 19 mai 2017 /Organisée par Zachary Baqué (CAS) et Vincent Souladié (PLH) Youri Borg et Damien Sarroméjean 1 Organisée par les laboratoires CAS et PLH, en association avec la Cinémathèque de Toulouse, cette journée d’étude consacrée à Frederick Wiseman se propose d’aborder l’œuvre dense d’un cinéaste américain majeur du genre documentaire, reconnu tant par la critique que par ses pairs, mais dont les films (Titicut Follies (1967), Primate (1974) et Public Housing (1997) pour citer les plus connus) sont paradoxalement peu vus. -

Zipporah Films
Motion Picture Film Sale and License Agreement 1. Definitions. As used in this agreement: (a) “Zipporah Films” means Zipporah Films, Inc., a corporation organized and existing under the laws of the Commonwealth of Massachusetts, and having its principal offices at One Richdale Avenue, Unit #4, Cambridge, Massachusetts 02140, USA. (b) “Customer” means anyone completing a purchase on www.zipporah.com or directly with Zipporah Films, Inc. (c) “The film” means a DVD, in b&w or color with soundtrack, distributed by Zipporah Films, Inc. 2. The film. Within 30 days after execution of this agreement, Zipporah Films shall deliver to Customer the DVD(s) which shall be used by Customer only in accordance with the terms of this agreement. 3. Use and care of the film. Customer shall not copy, duplicate or reproduce the film or any part thereof; shall retain the film in its custody and control at all times; and shall exhibit the film without the addition or deletion of any matter. 4. License to exhibit. Zipporah Films hereby grants to Customer a license to exhibit the film only for non- commercial purposes. Customer shall not make or permit any television showing of the film or any part thereof. Customer shall not make or permit any showing of the film(s) or any part thereof in any commercial motion picture theatre. Customer shall not make the film(s) available for any digital streaming or download by other parties, nor distribute it by any future technologies. Customer may not show the film in a public setting unless a license for public performance rights has been purchased.