I Bolognesi a Ferrara: Dai Carracci Ad Antonio Randa
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Storia Pittorica Della Italia Dell'abate Luigi Lanzi
STORIA PITTORICA DELLA ITALIA DELL’ABATE LUIGI LANZI ANTIQUARIO DELLA R. CORTE DI TOSCANA TOMO SECONDO PARTE SECONDA OVE SI DESCRIVONO ALTRE SCUOLE DELLA ITALIA SUPERIORE , LA BOLOGNESE , LA FERRARESE , E QUELLE DI GENOVA E DEL PIEMONTE BASSANO A SPESE REMONDINI IN VENEZIA 1795 - 1796 [1] DELLA STORIA PITTORICA DELLA ITALIA SUPERIORE LIBRO TERZO SCUOLA BOLOGNESE Abbiam osservato nel decorso di questa opera che la gloria del dipingere, non altrimenti che quella delle lettere e delle armi, è ita di luogo in luogo; e ovunque si è ferma ha perfezionata qualche parte della pittura meno intesa da' precedenti artefici o meno curata. Quando il secolo sestodecimo eclinava all'occaso non vi era oggimai in natura o genere di bellezza, o aspetto di essa, che non fosse stato da qualche professor grande vagheggiato e ritratto; talché il dipintore, voless'egli o non volesse, mentre era imitatore della natura, dovea esserlo a un tempo de' miglior maestri, e il trovar nuovi stili dovea essere un temperare in questo o in quell'altro modo gli antichi. Adunque la sola via della imitazione era aperta per distinguersi all'umano ingegno; non sembrando poter disegnar figure più maestrevolmente di un Bonarruoti o di un Vinci, o di aggraziarle meglio di Raffaello, o di colorirle più al vivo di Tiziano, o di muo[2]verle più spiritosamente che il Tintoretto, o di ornarle più riccamente che Paolo, o di presentarle all'occhio in qualunque distanza e prospetto con più arte, con più rotondità, con più incantatrice forza di quel che già facesse il Coreggio. Questa via della imitazione batteva allora ogni Scuola; ma veramente con poco metodo. -

Il Quadro Di Lucio Massari (1569
Il personaggio. L’ampia riflessione critica sulla Le note biografiche. Lucio Massari nasce a Bolo- pittura bolognese del periodo barocco, avvenuta gna il 22 gennaio 1569, nella parrocchia di S.Pro- in particolare tra il 1950 e il 1960, ha ampiamente colo, da Bartolomeo Massari e dalla sua prima riconsiderato l’arte pittorica di Lucio Massari e lo moglie Celidonia. La vivace intelligenza dimostrata ha definito un piccolo maestro di provincia (Carlo dal piccolo Lucio induce il padre ad affidarlo al Volpe, 1955). Questa rivalutazione rende giustizia pittore manierista Bartolomeo Passarotti (1529- della sottovalutazione che ne fecero critici e colle- 1592), pregandolo di insegnare al figlio a leggere ghi del suo tempo, influenzati sfavorevolmente e scrivere, e di avviarlo alla carriera artistica. dall'indolenza e irresolutezza che caratterizzarono Il giovane allievo si affeziona molto al suo mae- in negativo la personalità dell’artista. stro, e quando l’arte del Passarotti viene offuscata In tempi in cui nelle botteghe dei maestri barocchi dall’affermarsi a Bologna della grande pittura di si insegnava che composizione e decorazione dei Carracci, lo difen- l’arte non ammet- de strenuamente, e ingenuamente, senza accor- teva trascuratezza gersi della carica innovativa che questi ultimi stan- perchè era una ca- no portando nel pittura barocca della seconda ratteristica dei di- metà del ‘500. Superata l’acritica passionalità lettanti, ed era ne- giovanile, anche lo stesso Massari dovrà ricono- cessario dedicare scere la grandezza dei Carracci, e dopo la morte allo studio un im- del Passarotti si accosterà artisticamente a Ludo- pegno incondizio- vico Carracci e a suo cugino Annibale. -

The History of Painting in Italy, Vol. V
The History Of Painting In Italy, Vol. V By Luigi Antonio Lanzi HISTORY OF PAINTING IN UPPER ITALY. BOOK III. BOLOGNESE SCHOOL. During the progress of the present work, it has been observed that the fame of the art, in common with that of letters and of arms, has been transferred from place to place; and that wherever it fixed its seat, its influence tended to the perfection of some branch of painting, which by preceding artists had been less studied, or less understood. Towards the close of the sixteenth century, indeed, there seemed not to be left in nature, any kind of beauty, in its outward forms or aspect, that had not been admired and represented by some great master; insomuch that the artist, however ambitious, was compelled, as an imitator of nature, to become, likewise, an imitator of the best masters; while the discovery of new styles depended upon a more or less skilful combination of the old. Thus the sole career that remained open for the display of human genius was that of imitation; as it appeared impossible to design figures more masterly than those of Bonarruoti or Da Vinci, to express them with more grace than Raffaello, with more animated colours than those of Titian, with more lively motions than those of Tintoretto, or to give them a richer drapery and ornaments than Paul Veronese; to present them to the eye at every degree of distance, and in perspective, with more art, more fulness, and more enchanting power than fell to the genius of Coreggio. Accordingly the path of imitation was at that time pursued by every school, though with very little method. -

Visualizing Poetry in Practice in Early Modern Italian Art
Athens Journal of Humanities & Arts - Volume 8, Issue 3, July 2021 – Pages 189-208 Li Pittori Parlano con l’Opere: Visualizing Poetry in Practice in Early Modern Italian Art By James Hutson* The relative sophistication of artists in the early modern era is contested, especially with regards to their educational backgrounds. On one hand, Dempsey-esque intellectual history is vested in touting the structured, literary curricula in art-educational institutions; while on the other, a complete rejection of the ‚artist-philosopher‛ as historical fiction seeks to undermine this hegemonic construct. This study argues that the lack of early formal education in the cases of artist like Annibale Carracci and Nicolas Poussin, who, unlike Peter Paul Rubens, did not have a firm foundation in the classics and languages that would allow them to engage directly with source material, would later be supplemented through their relationships with literary figures in the circles of Torquato Tasso, Giambattista Marino, and the Accademia dei Gelati. In addition to such relationships, informal exchanges, gatherings, and supplemental materials like Giovanni Paolo Gallucci’s Della Simmetria could be called upon when treating poetic subjects. With intimate knowledge of vernacular poetry, literati themselves participating in lectures and studio visits, and, finally, quick reference guides for subject matter, these artists were able to produce works that spoke to both poetic and artistic theory of the day, as one naturally informed the other. Introduction ‚Poets paint with words, painters speak with their works.‛1 This aphorism of Annibale Carracci (1560-1609) followed a superb rendering of the Laocoön in charcoal, expertly rendered from memory. -

JI Canonico Malvasia Pretende Scrivere Contra Giorgio Vasari. La Elaboración De La Felsina Pittrice a Través Del Manuscrito Vita Del Mitelli (1665-1667)
JI Canonico Malvasia pretende scrivere contra Giorgio Vasari. La elaboración de la Felsina Pittrice a través del manuscrito Vita del Mitelli (1665-1667) 1l Canonico Malvasía pretende scrivere contra Giorgio Vasari. The writing of the Felsina Pittrice based on the manuscript Vita del Mitelli (1665-1667) García Cueto, David* Fecha de terminación del trabajo: junio de 2002. Fecha de aceptación por la revista: noviembre de 2002. C.D.U.: 929 Malvasía, Cario Cesare: 7 BIBLID [0210-962-X(2003); 34; 21-35] RESUMEN El manuscrito Vita et Opere di Agostino Mire/Ji, redactado entre 1665 y 1667, contiene noticias que exceden la mera biografía del artista. Algunas de éstas se refieren al historiógrafo boloñés Cario Cesare Malvasía, quién por aquellos años estaba redactando la que fue su principal obra, la Fe/sina Pittrice. En este estudio se reúnen por primera vez la totalidad de estas noticias, y se analiza el proceso de elaboración de la Fe/sina a través de ellas. Palabras clave: Historiografía del Arte; Biografía. Identificadores: Malvasía; Cario Cesare; Mitelli, Giovanni; Mitelli, Agostino; Felsina Pittrice. Topónimos: Bolonia; Florencia; Roma; Venecia; Italia. Período: Siglo 17. ABSTRACT The manuscript Vita et Opere di Agostino Mitelli, written between 1665 and 1667, includes information of wider relevance than that needed for a biography of the artist. Sorne of these pieces of information refer to the Bologna historiographer Cario Cesare Malvasía who at that time was writing his main work, the Felsina Pillrice. The present study brings together ali these data for the first time and analyses their importance in the writing of the Felsina. -

Felsina Pittrice LIVES of the BOLOGNESE PAINTERS
CARLO CESARE MALVASIA’S Felsina pittrice LIVES OF THE BOLOGNESE PAINTERS Published for the Center for Advanced Study in the Visual Arts, National Gallery of Art, Washington Harvey Miller Publishers An Imprint of Brepols Publishers THE FELSINA PITTRICE Count Carlo Cesare Malvasia’s Felsina pittrice, or Lives of the Bolognese Painters, first published in two volumes in Bologna in 1678, is one of the most important sources for the history and criticism of painting in Italy. Conceived in part as a response to Giorgio Vasari’s Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori (1550/1568), the Felsina pittrice combines close observation with documentary history, and careful analysis with polemical debate. It offers the fullest account of Bolognese artists from Simone dei Crocefissi to Prospero and Lavinia Fontana, from Guercino to Elisabetta Sirani. The Carracci are treated as a family of artists, and their school (including Guido Reni, Domenichino, and Francesco Albani, among others) is documented by Malvasia in far greater detail than by any other biographer. The great art historian Luigi Lanzi (1732- 1810) said that no other school in Italy had been described by a more capable pen, and he considered the two volumes of the Felsina pittrice to be “a treasure of the most beautiful knowledge gathered from the pupils of the Carracci, whom Malvasia knew, and who helped him in this work, which was, however, accused of sometimes burning with an excessively patriotic zeal.” 2. THE CRITICAL EDITION Accusations of excessive passion for his local school, combined with unjustified charges of forgery and unreliability, have for centuries clouded the reception and understanding of Malvasia’s extraordinarily important text, which was last edited and published in 1841-44. -

Collaborative Painting Between Minds and Hands: Art Criticism, Connoisseurship, and Artistic Sodality in Early Modern Italy
Collaborative Painting Between Minds and Hands: Art Criticism, Connoisseurship, and Artistic Sodality in Early Modern Italy by Colin Alexander Murray A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of Art University of Toronto © Copyright by Colin Murray 2016 Collaborative Painting Between Minds and Hands: Art Criticism, Connoisseurship, and Artistic Sodality in Early Modern Italy Colin Alexander Murray Doctor of Philosophy Department of Art University of Toronto 2016 Abstract The intention of this dissertation is to open up collaborative pictures to meaningful analysis by accessing the perspectives of early modern viewers. The Italian primary sources from the fifteenth to the seventeenth centuries yield a surprising amount of material indicating both common and changing habits of thought when viewers looked at multiple authorial hands working on an artistic project. It will be argued in the course of this dissertation that critics of the seventeenth century were particularly attentive to the practical conditions of collaboration as the embodiment of theory. At the heart of this broad discourse was a trope extolling painters for working with what appeared to be one hand, a figurative and adaptable expression combining the notion of the united corpo and the manifold meanings of the artist’s mano. Hardly insistent on uniformity or anonymity, writers generally believed that collaboration actualized the ideals of a range of social, cultural, theoretical, and cosmological models in which variously formed types of unity were thought to be fostered by the mutual support of the artists’ minds or souls. Further theories arose in response to Giovanni Paolo Lomazzo’s hypothesis in 1590 that the greatest painting would combine the most highly regarded old masters, each contributing their particular talents towards the whole. -

Prospettive Architettoniche Conservazione Digitale, Divulgazione E Studio VOLUME II T Omo Ii
Studi e Ricerche Scienze e Tecnologie Prospettive architettoniche conservazione digitale, divulgazione e studio VOLUME II T OMO ii a cura di Graziano Mario Valenti Collana Studi e Ricerche 55 Scienze e Tecnologie Prospettive architettoniche conservazione digitale, divulgazione e studio VOLUME II TOMO II a cura di Graziano Mario Valenti 2016 Scienze e Tecnologie Prospettive architettoniche conservazione digitale, divulgazione e studio VOLUME II TOMO II a cura di Graziano Mario Valenti 2016 Cura redazionale: Monica Filippa Organizzazione redazionale unità di ricerca locali: Giuseppe Amoruso (Milano), Francesco Bergamo (Venezia), Cristina Candito (Genova), Pia Davico (Torino), Giuseppe Fortunato (Cosenza), Monica Lusoli (Firenze), Barbara Messina (Salerno), Jessica Romor (Roma). Copyright © 2016 Sapienza Università Editrice Piazzale Aldo Moro 5 – 00185 Roma www.editricesapienza.it [email protected] Iscrizione Registro Operatori Comunicazione n. 11420 ISBN 978-88-9377-013-2 Pubblicato a dicembre 2016 Quest’opera è distribuita con licenza Creative Commons 3.0 diffusa in modalità open access. In copertina: Modello dell’architettura illusoria della parete ovest della Sala dei Cento giorni, restituito secondo la chiave architettonica e geometrica per determinare la posizione dell’osservatore O’. Immagine di Leonardo Baglioni A Orseolo Fasolo, indimenticato professore di fondamenti e applicazioni della geometria descrittiva alla ‘Sapienza’, Virtuoso del Pantheon e Maestro di prospettiva, che seppe raccogliere l’eredità di Francesco Severi e di Enrico Bompiani per restituire agli architetti, rinnovata e arricchita, l’antica scienza che vive in queste pagine. Indice TOMO I Prospettive architettoniche: metodo, progetto, valorizzazione 1 Graziano Mario Valenti Parte I. Le prospettive architettoniche e la loro interpretazione 15 europa 17 El diseño de espacios anamórficos. -

03-Villa Spada-A Historical Note-Gearoid O'broin.Pdf
Villa Spada — A Historical Note Gearóid Ó Broin As the Mother House in the period 1888-1895 and the place where the foundress, Mother Mary Ignatius OSF, died on 6 May 1894, the Villa Spada1 has a particular interest for members of the Missionary Franciscan Sisters of the Immaculate Conception. The story of the house is largely the story of two families, the Nobilis, who owned the property for about a hundred years and built the Casino, and the Spadas, who owned it for a further 200 years of its history. Although they came from noble families, who produced some scholars (Roberto Nobili S.J. and Virgilio Spada) and four Cardinals, none of the actual owners of the property left a deep mark on their times and none of them produced more than a footnote in the history books. Though not themselves great, they and their country house were often close to great people and great events. For ten days in 1849, Garibaldi and his red-shirts placed the Villa Spada at the centre of Italian history. Today's Villa on the Janiculum hill occupies an area of 7,300 square metres, but the original area was, at 30,366 square metres, more than four times as large. It stretched as far as Porta San Pancrazio-at 82 meters above sea level, the highest point in Rome within the city walls-and included much of what is now the American Academy. The name Janiculum is presumed to derive from the cult of Janus. Numa Pompilius, the second Roman king, built a temple to Janus and was buried on the Janiculum. -

Reconsidering Center-Periphery Pedagogy
Art and Design Review, 2019, 7, 150-173 http://www.scirp.org/journal/adr ISSN Online: 2332-2004 ISSN Print: 2332-1997 Le Accademie Bolognese e Romana: Reconsidering Center-Periphery Pedagogy James Hutson Art History Department, Lindenwood University, St. Charles, MO, USA How to cite this paper: Hutson, J. (2019). Abstract Le Accademie Bolognese e Romana: Recon- sidering Center-Periphery Pedagogy. Art and This article seeks a reevaluation of the relationship between the Carracci Ac- Design Review, 7, 150-173. cademia degli’Incamminati and the Accademia di San Luca in Rome with re- https://doi.org/10.4236/adr.2019.73014 gards to structure, goals and pedagogy. For although the perceived pedagogi- Received: July 13, 2019 cal goals of the Carracci, especially the prosaic Annibale, and the most Accepted: August 9, 2019 well-known Scholastic academician associated with the Roman Accademia, Published: August 12, 2019 Federico Zuccaro, have traditionally been viewed as conflicting, the early his- tory of the academy in Rome can be seen to parallel the Bolognese. Each was Copyright © 2019 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. established to address the uncertain and evolving nature of the profession This work is licensed under the Creative seen in each city, leading to a demand for a new type of educational institu- Commons Attribution International tion for the studiosi giovani; the curricula developed were designed to meet License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ the new andragogical challenges of these new “open” art academies; and, fi- Open Access nally, their foundations were designed with reformatory goals in mind due to their association with the same educatori riformanda. -
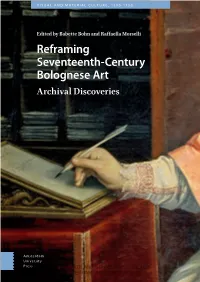
Observing Protest from a Place
VISUAL AND MATERIAL CULTURE, 1300-1700 Bohn & Morselli (eds.) Edited by Babette Bohn and Raffaella Morselli Reframing Seventeenth-CenturySeventeenth-century Bolognese Art Archival Discoveries Reframing Seventeenth-Century Bolognese Art Bolognese Seventeenth-Century Reframing FOR PRIVATE AND NON-COMMERCIAL USE AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Reframing Seventeenth-Century Bolognese Art FOR PRIVATE AND NON-COMMERCIAL USE AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Visual and Material Culture, 1300–1700 A forum for innovative research on the role of images and objects in the late medieval and early modern periods, Visual and Material Culture, 1300–1700 publishes monographs and essay collections that combine rigorous investigation with critical inquiry to present new narratives on a wide range of topics, from traditional arts to seemingly ordinary things. Recognizing the fluidity of images, objects, and ideas, this series fosters cross-cultural as well as multi-disciplinary exploration. We consider proposals from across the spectrum of analytic approaches and methodologies. Series Editor Dr. Allison Levy, an art historian, has written and/or edited three scholarly books, and she has been the recipient of numerous grants and awards, from the National Endowment for the Humanities, the American Association of University Women, the Getty Research Institute, the Dumbarton Oaks Research Library of Harvard University, the Whiting Foundation and the Bogliasco Foundation, among others. www.allisonlevy.com. FOR PRIVATE AND NON-COMMERCIAL USE AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Reframing Seventeenth-Century Bolognese Art Archival Discoveries Edited by Babette Bohn and Raffaella Morselli Amsterdam University Press FOR PRIVATE AND NON-COMMERCIAL USE AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Cover illustration: Guido Reni, Portrait of Cardinal Bernardino Spada, Rome, Galleria Spada, c. -
FB Catalogue Final.Pdf
Seattle, Seattle Art Museum Fort Worth, Kimbell Art Museum October 17 2019 - January 26 2020 March 01 2020 - June 14 2020 Curated by Sylvain Bellenger with the collaboration of Chiyo Ishikawa, George Shackleford and Guillaume Kientz Embassy of Italy Washington The Embassy of Italy in Washington D.C. Museo e Real Bosco di Capodimonte Seattle Art Museum Director Illsley Ball Nordstrom Director and CEO Front cover Sylvain Bellenger Amada Cruz Parmigianino Lucretia Chief Curator Susan Brotman Deputy Director for Art and 1540, Oil on panel Linda Martino Curator of European Painting and Sculpture Naples, Museo e Real Bosco Chiyo Ishikawa di Capodimonte Exhibition Department Patrizia Piscitello Curatorial Intern Exhibition Catalogue Giovanna Bile Gloria de Liberali Authors Documentation Department Deputy Director for Art Administration Sylvain Bellenger Alessandra Rullo Zora Foy James P. Anno Christopher Bakke Head of Digitalization Exhibitions and Publications Manager Proofreading and copyediting Carmine Romano Tina Lee Mark Castro Graphic Design Restoration Department Director of Museum Services Studio Polpo Alessandra Golia and Chief Registrar Lauren Mellon Photos credits Legal Consulting Museo e Real Bosco di Capodimonte Studio Luigi Rispoli Associate Registrar for Exhibitions © Alberto Burri by SIAE 2019, Fig. 5 Megan Peterson © 2019 Andy Warhol Foundation American Friends of Capodimonte President for the Visual Arts by SIAE, Fig. 6 Nancy Vespoli Director of Design and Installation Photographers Nathan Peek and his team Luciano Romano Speranza Digital Studio, Napoli Exhibition Designer Paul Martinez Published by MondoMostre Printed in Italy by Tecnostampa Acting Director of Communications Finished printing on September 2019 Cindy McKinley and her team Copyright © 2019 MondoMostre Chief Development Ofcer Chris Landman and his team All Rights Reserved.