Biografia Jean Miel
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
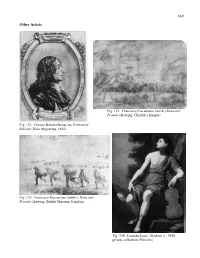
669 Other Artists
669 Other Artists Fig. 132. Francesco Fracanzano (attrib.) Rosa and Friends (drawing, Christie’s Images) Fig. 131. Giovan Battista Bonacina, Portrait of Salvator Rosa (engraving, 1662) Fig. 133. Francesco Fracanzano (attrib.), Rosa and Friends (drawing, British Museum, London) Fig. 134. Lorenzo Lippi, Orpheus (c. 1648, private collection, Florence) 670 Fig. 135. Lorenzo Lippi (and Rosa?), The Flight Fig. 136. Lorenzo Lippi, Allegory of Simulation into Egypt (1642, Sant’Agostino, Massa Marittima) (early 1640’s, Musèe des Beaux-Arts, Angers) Fig. 137. Baldassare Franceschini (“Il Volterrano”), Fig. 138. Baldassare Franceschini (“Il Volterrano”), A Sibyl (c. 1671?, Collezione Conte Gaddo della A Sibyl (c. 1671?, Collezione Conte Gaddo della Gherardesca, Florence) Gherardesca, Florence) 671 Fig. 140. Jacques Callot, Coviello (etching, Fig. 139. Jacques Callot, Pasquariello Trunno from the Balli di Sfessania series, early 1620’s) (etching, from the Balli di Sfessania series, early 1620’s) Fig. 142. Emblem of the Ant and Elephant (image from Hall, Illustrated Dictionary of Symbols in Eastern and Western Art, p. 8) Fig. 141. Coviello, from Francesco Bertelli, Carnavale Italiane Mascherato (1642); image from Nicoll, Masks Mimes and Miracles, p. 261) 672 Fig. 143. Jan Miel, The Charlatan (c. 1645, Hermitage, St. Petersburg) Fig. 144. Karel Dujardin, A Party of Charlatans in an Italian Landscape (1657, Louvre, Paris) Fig. 145. Cristofano Allori, Christ Saving Peter from Fig. 146. Cristofano Allori (finished by Zanobi the Waves (c. 1608-10, Collezione Bigongiari, Pistoia) Rosi after 1621), Christ Saving Peter from the Waves (Cappella Usimbardi, S. Trinità, Florence) 673 Fig. 148. Albrecht Dürer, St. Jerome in his Study (engraving, 1514) Fig. -

The Representation of Roma in Major European Museum Collections
The Council of Europe is a key player in the fight to respect THE REPRESENTATION OF ROMA the rights and equal treatment of Roma and Travellers. As such, it implements various actions aimed at combating IN MAJOR EUROPEAN discrimination: facilitating the access of Roma and Travellers to public services and justice; giving visibility to their history, MUSEUM COLLECTIONS culture and languages; and ensuring their participation in the different levels of decision making. Another aspect of the Council of Europe’s work is to improve the wider public’s understanding of the Roma and their place in Europe. Knowing and understanding Roma and Travellers, their customs, their professions, their history, their migration and the laws affecting them are indispensable elements for interpreting the situation of Roma and Travellers today and understanding the discrimination they face. This publication focuses on what the works exhibited at the Louvre Museum tell us about the place and perception of Roma in Europe from the15th to the 19th centuries. Students aged 12 to 18, teachers, and any other visitor to the Louvre interested in this theme, will find detailed worksheets on 15 paintings representing Roma and Travellers and a booklet to foster reflection on the works and their context, while creating links with our contemporary perception of Roma and Travellers in today’s society. 05320 0 PREMS ENG The Council of Europe is the continent’s leading human rights organisation. It comprises 47 member Volume I – The Louvre states, including all members of the European Union. Sarah Carmona All Council of Europe member states have signed up to the European Convention on Human Rights, a treaty designed to protect human rights, democracy and the rule of law. -

Nozioni Generali Sul Patrimonio Culturale Italiano
FormezPA MiBACT Banca dati prove preselettive MiBACT - Nozioni Generali sul Patrimonio Culturale Italiano MiBACT - Nozioni Generali sul Patrimonio Culturale Italiano Pagina 1 1 Il tempio della Concordia, voluto da M. Furio Camillo nel 366 a.C. e ricostruito da L. Opimio nel 121 A.C., fu ricostruito una seconda volta dall'imperatore: A Claudio. B Vespasiano. C Tiberio. 2 In quale museo di Palermo è conservata un'iscrizione lapidea cristiana del 1149 in quattro lingue: ebraico, latino, greco bizantino e arabo, che testimonia la multietnicità della Palermo medievale? A Galleria regionale della Sicilia "Palazzo Abatellis" situata all'interno del palazzo quattrocentesco, anche detto Palazzo Patella B Museo Archeologico Regionale "Antonio Salinas" situato nella ex Casa dei Padri della Congregazione di San Filippo Neri C Museo d'arte islamica, situato nel castello arabo-normanno della Zisa 3 Dove si trova il grande dipinto di Duilio Cambellotti raffigurante la "Redenzione dell'Agro" (1934)? A Chiesa della SS. Annunziata di Sabaudia. B Palazzo Comunale di Latina. C Palazzo della Prefettura di Latina. 4 Il monumento funebre del Cardinale De Braye in S. Domenico di Orvieto, è opera di: A Lorenzo Bernini. B Jacopo della Quercia. C Arnolfo di Cambio. 5 Nel centro agricolo di Caprarola, non lontano dal lago di Vico in provincia di Viterbo, si erge uno scenografico Palazzo della famiglia: A Colonna B Borgia C Farnese 6 Quale tra i seguenti monumenti è incluso nel sito UNESCO de "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568/774 d.C.)"? A Il centro storico di Ravenna B la Basilica Patriarcale di Aquileia C Il tempietto del Clitunno a Campello 7 Cosa raffigura la Pala d'altare della Cappella Bandini nella Chiesa di San Silvestro al Quirinale, opera ad olio su lavagna firmata e datata di Scipione Pulzone? A La Resurrezione di Cristo. -

The Collecting, Dealing and Patronage Practices of Gaspare Roomer
ART AND BUSINESS IN SEVENTEENTH-CENTURY NAPLES: THE COLLECTING, DEALING AND PATRONAGE PRACTICES OF GASPARE ROOMER by Chantelle Lepine-Cercone A thesis submitted to the Department of Art History In conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Queen’s University Kingston, Ontario, Canada (November, 2014) Copyright ©Chantelle Lepine-Cercone, 2014 Abstract This thesis examines the cultural influence of the seventeenth-century Flemish merchant Gaspare Roomer, who lived in Naples from 1616 until 1674. Specifically, it explores his art dealing, collecting and patronage activities, which exerted a notable influence on Neapolitan society. Using bank documents, letters, artist biographies and guidebooks, Roomer’s practices as an art dealer are studied and his importance as a major figure in the artistic exchange between Northern and Sourthern Europe is elucidated. His collection is primarily reconstructed using inventories, wills and artist biographies. Through this examination, Roomer emerges as one of Naples’ most prominent collectors of landscapes, still lifes and battle scenes, in addition to being a sophisticated collector of history paintings. The merchant’s relationship to the Spanish viceregal government of Naples is also discussed, as are his contributions to charity. Giving paintings to notable individuals and large donations to religious institutions were another way in which Roomer exacted influence. This study of Roomer’s cultural importance is comprehensive, exploring both Northern and Southern European sources. Through extensive use of primary source material, the full extent of Roomer’s art dealing, collecting and patronage practices are thoroughly examined. ii Acknowledgements I am deeply thankful to my thesis supervisor, Dr. Sebastian Schütze. -
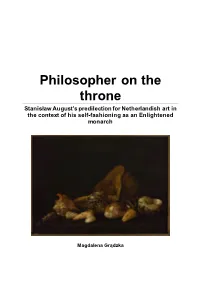
Open Access Version Via Utrecht University Repository
Philosopher on the throne Stanisław August’s predilection for Netherlandish art in the context of his self-fashioning as an Enlightened monarch Magdalena Grądzka Philosopher on the throne Magdalena Grądzka Philosopher on the throne Stanisław August’s predilection for Netherlandish art in the context of his self-fashioning as an Enlightened monarch Magdalena Grądzka 3930424 March 2018 Master Thesis Art History of the Low Countries in its European Context University of Utrecht Prof. dr. M.A. Weststeijn Prof. dr. E. Manikowska 1 Philosopher on the throne Magdalena Grądzka Index Introduction p. 4 Historiography and research motivation p. 4 Theoretical framework p. 12 Research question p. 15 Chapters summary and methodology p. 15 1. The collection of Stanisław August 1.1. Introduction p. 18 1.1.1. Catalogues p. 19 1.1.2. Residences p. 22 1.2. Netherlandish painting in the collection in general p. 26 1.2.1. General remarks p. 26 1.2.2. Genres p. 28 1.2.3. Netherlandish painting in the collection per stylistic schools p. 30 1.2.3.1. The circle of Rubens and Van Dyck p. 30 1.2.3.2. The circle of Rembrandt p. 33 1.2.3.3. Italianate landscapists p. 41 1.2.3.4. Fijnschilders p. 44 1.2.3.5. Other Netherlandish artists p. 47 1.3. Other painting schools in the collection p. 52 1.3.1. Paintings by court painters in Warsaw p. 52 1.3.2. Italian paintings p. 53 1.3.3. French paintings p. 54 1.3.4. German paintings p. -

Entertaining Genre of Matthijs Naiveu - Depicting Festivities and Performances at the Dawn of the ‘Theatre Age’
Research Master Thesis Art History of the Low Countries in its European Context Entertaining genre of Matthijs Naiveu - depicting festivities and performances at the dawn of the ‘Theatre Age’. Student: Adele-Marie Dzidzaria 0507954 Supervisor: Prof. Dr. Rudi Ekkart Utrecht University 2007 Table of contents Introduction....................................................................................................................3 1 Biography/Overview of Naiveu’s oeuvre ..............................................................5 1.1 From Leiden to Amsterdam...........................................................................5 1.2 From early genre to theatrical compositions..................................................8 1.3 Portraiture ....................................................................................................14 2 Historiographic context/ Theatricality in genre painting.....................................19 3 Naiveu’s genre paintings – innovating on old subjects and specialising in festivities..............................................................................................................24 4 Theatrical paintings - thematic sources and pictorial models..............................32 4.1 Out-door festivities and performances.........................................................32 4.2 In-door celebrations and amusements..........................................................56 5 Conclusion ...........................................................................................................62 -

A Catalogue of the Paintings at Doughty House, Richmond, & Elsewhere in the Collection of Sir Frederick Cook, Bt., Visconde
A CATALOGUE OF THE PAINTINGS IN THE COLLECTION of SIR FREDERICK COOK, BT. A CATALOGUE OF THE PAINTINGS AT DOUGHTY HOUSE RICHMOND AND ELSEWHERE IN THE COLLECTION OF SIR FREDERICK COOK BT VISCONDE DE MONSERRATE Edited by HERBERT COOK, M.A., F.S.A. VOLUME I ITALIAN SCHOOLS By DR TANCRED BORENIUS LONDON • WILLIAM HEINEMANN A CATALOGUE OFTHE PAINTINGS AT DOUGHTY HOUSE RICHMOND ELSEWHERE IN THE COLLECTION OF SIR FREDERICK COOK BT VISCONDE DE MONSERRATE EDITED BY HERBERT COOK, M.A., F.S.A. HON. MEMBER OF THE ROYAL ACADEMY OF MILAN VOLUME II DUTCH AND FLEMISH SCHOOLS By J. O. KRONIG LONDON WILLIAM HEINEMANN M DCCCC XIV PREFATORY NOTE THE second volume of the Cook colledtion is devoted to the Dutch and Flemish Schools. The art of the so-called School of the Early Netherlands is reserved for the third volume, which will also contain the English, French, German and Spanish se&ions. In the present volume 190 Dutch and Flemish piitures are recorded, and of these 100 are illustrated either on photogravure plates or by collotype process. The former are executed by the Rembrandt Photogravure Co., of 36 Basinghall Street, E.C.; the latter are the work of Messrs Knighton & Cutts, of Red Lion Court, Fleet Street, E.C. As in the previous volume, single photographs can be obtained either from Signor Domenico Anderson, of Rome, or from Mr W. E. Gray, of 92 Queen’s Road, Bays- water; the register number for ordering is always quoted whenever the photograph exists. The text has been entrusted to Mr J. -

Die Rospigliosi
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Die barocke Vereinigung zweier Kunstsammlungen: Die Gemälde der Familie Rospigliosi-Pallavicini anhand der Inventare von 1682, 1708 und 1713“ Verfasserin Magistra der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (Mag. rer. soc. oec) Camilla Tinnacher angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 315 Studienrichtung lt. Studienblatt: Kunstgeschichte Betreuerin / Betreuer: Univ.-Prof. Dr. Sebastian Schütze INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung .................................................................................................................... 1 2. Die Ursprünge in Pistoia: Die Rospigliosi ................................................................. 2 3. Die Ursprünge in Genua: Die Pallavicini ................................................................. 12 4. Der soziale Aufstieg in Caput Mundi ....................................................................... 15 5. Die Inventare der Kunstsammlung Rospigliosi-Pallavicini ..................................... 22 6. Das Referenzinventar von 1713 ............................................................................... 24 7. Das Inventar von 1682 .............................................................................................. 30 7.1. Inventario della Guardarobba del 1682 ................................................................ 33 7.2. Die Note ............................................................................................................... -

Altre|Stanze
COPERTINA.pdf 2 13/11/2017 16:38:55 altre|stanze C anni ‘50 – ‘60 M Y opere dalle raccolte della Banca d’Italia CM MY CY CMY K Progetto grafico e immagine coordinata Federica Cecchi Fotografie Archivio della Banca d’Italia Domenico Capone Alessandra Como Giuseppe Schiavinotto Maurizio Necci per Azimut In copertina: Corrado Cagli, Altre stanze, 1950 Comune di Frascati Assessorato alle Politiche Culturali Scuderie Aldobrandini Banca d’Italia altre|stanze anni ’50-’60 opere dalle raccolte della Banca d’Italia a cura di Mariastella Margozzi - Morena Costantini COMUNE DI FRASCATI ASSESSORATO ALLA CULTURA Frascati, Scuderie Aldobrandini 21 Novembre 2017 - 14 Gennaio 2018 altre|stanze anni ’50-’60 opere dalle raccolte della Banca d’Italia a cura di Mariastella Margozzi - Morena Costantini Frascati, Scuderie Aldobrandini 21 Novembre 2017- 14 Gennaio 2018 COMUNE DI FRASCATI BANCA D’ITALIA Sindaco Direttore generale Roberto Mastrosanti Salvatore Rossi Assessore alla Cultura Vice Direttore generale Emanuela Bruni Valeria Sannucci Delegato alla Programmazione Spazi della Cultura e Grandi Eventi Capo del Dipartimento Immobili e Appalti Franco Paolo Posa Luigi Donato Museo Tuscolano - Scuderie Aldobrandini Capo del Servizio Immobili Direttrice e Responsabile Servizio Cultura Paolo Anselmi Giovanna Cappelli Coordinamento ed organizzazione Servizio Cultura Stefano Aschettino Roberta Bonamore Maria Bracaloni Emanuela Cicerchia Manuela Desideri Sabrina Cordella Alessandra Massetti Collaborazione tecnica Roberto Morelli STS Multiservizi Supporto logistico Pierluigi Ermacora Applicazione multimediale Umberto Scocca Supporto alla Sicurezza Divisione Sicurezza-normativa e sistemi Supporto allestimento e illuminotecnica Divisione Gestione tecnica immobili Roma 3 Stampa e Relazioni esterne Antonella Dragotto Trasporti, allestimenti e pubblicità Montenovi Srl Crea snc STE.M.AL Teknexpress 84 Revisione e controllo opere in mostra Soc. -

BAMBOCCIANTI SCHOOL (Before 1650)
THOS. AGNEW & SONS LTD. 6 ST. JAMES’S PLACE, LONDON, SW1A 1NP Tel: +44 (0)20 7491 9219. www.agnewsgallery.com BAMBOCCIANTI SCHOOL (before 1650) A Shepherd Boy in a Landscape Oil on canvas 70 x 60 cm PROVENANCE Baron Vetter von der Lilie, Hautzenbichl Castle, Knittenfeld, Austria; from whom purchased by the previous owner in 1950 The Bamboccianti were genre painters active in Rome from about 1625 until the end of the seventeenth century. Most were Dutch and Flemish artists, including Andries and Jan Both, Karel Dujardin, Jan Miel and Johannes Lingelbach, who brought existing traditions of depicting peasant subjects from sixteenth-century Netherlandish art with them to Italy. The name, meaning ‘ugly doll’, derived from the nickname of Pieter van Laer, credited with initiating the Bamboccianti School, due to his ungainly proportions. In Rome during this period, the work of the Bamboccianti School served as an important countermovement which eschewed the lofty subject matter and grand scale of the conventional art of the time. Artists such as Salvator Rosa lamented that the city had been invaded by a group of painters whose works represented “nothing but rogues, cheats, pickpockets, bands of drunks and gluttons, scabby tobacconists, barbers, and other sordid subjects”1. Rosa was outraged that 1 Levine, David A. (December 1988). "The Roman Limekilns of the Bamboccianti". The Art Bulletin (College Art Association) 70 (4): 569–589 Thos Agnew & Sons Ltd, registered in England No 00267436 at 21 Bunhill Row, London EC1Y 8LP VAT Registration No 911 4479 34 THOS. AGNEW & SONS LTD. 6 ST. JAMES’S PLACE, LONDON, SW1A 1NP Tel: +44 (0)20 7491 9219. -

Fotokatalog Photographic Catalogue Catalogo Fotografico
Fotokatalog Photographic Catalogue Catalogo fotografico Source: http://www.khi.fi.it/5201080/Fotokataloge Stable URL: http://wwwuser.gwdg.de/~fotokat/Fotokataloge/Amsler_o_J_6_l.pdf Published by: Photothek des Kunsthistorischen Instituts in Florenz, Max-Planck-Institut http://www.khi.fi.it XVII . Jahrhundert. Spanien. 10808 Bildniss König Philipps IV. von Spanien. IV M. 12, -. Lond on. Desgl. (1129). 10809 Christus an der Martersäule. IV M. 12,-. London. Desgl. (1148). 108(() Bildniss des Infanten Don Balthasar. II M. 3,5°. London. Hertford Gallery. [oS[ I Bildniss einer Dame mit einem Fächer. n M. 3,5°. Erklärung der Abkürzungen. London. Desgl. 10812 Bildniss des Carlo M. Altogradi. TI M. -,80. IV M. 3,-· Cie. _ Jac. Burckhardt, Der Cicerone, Fünfte Auflage, bearbeitet von Lucca Privatbesitz (March. Gir. Mansi). Wilh. Bode. 108 [3 Die Anbetung der Könige. n M. 1,5°. m M. 3,-· ~1ad rid. Prado (1054). C. = J. A. Crowe & G. B. CavaIcasell e, Geschichte der ital. Malerei. \OSq Di~ Madonna mit dem Kinde. Theil aus No. IOS[3· V M. 6.-. Woerm. = Woltmann - Woermann, Geschichte der Malerei. Madrid. IJesf{l. Mor. = Lermolieff, Die Werke ital. Maler in den Galerien ,'on München, roS[ S Christus am Kreuz. II M. [,50. III M. 3,-· IV M. 12,-. Dresden und Berlin. V M. 6,-. VI M. 48,-. Madrid. Desg-\. (1055). Vasari = Le opere di Giorgio Vasari. [0816 Die Krönung Mariae. Il M. 1,50. III M. 3,-. IV M. [2,-. V M. 6,-. Madrid. Desg\. (1056). [08 I 7 Der Kopf Mariae. Theil aus No. \0816. III M. 3,-. Scala der Formate. Mad rid. Desgl. -
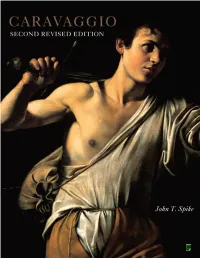
Caravaggio, Second Revised Edition
CARAVAGGIO second revised edition John T. Spike with the assistance of Michèle K. Spike cd-rom catalogue Note to the Reader 2 Abbreviations 3 How to Use this CD-ROM 3 Autograph Works 6 Other Works Attributed 412 Lost Works 452 Bibliography 510 Exhibition Catalogues 607 Copyright Notice 624 abbeville press publishers new york london Note to the Reader This CD-ROM contains searchable catalogues of all of the known paintings of Caravaggio, including attributed and lost works. In the autograph works are included all paintings which on documentary or stylistic evidence appear to be by, or partly by, the hand of Caravaggio. The attributed works include all paintings that have been associated with Caravaggio’s name in critical writings but which, in the opinion of the present writer, cannot be fully accepted as his, and those of uncertain attribution which he has not been able to examine personally. Some works listed here as copies are regarded as autograph by other authorities. Lost works, whose catalogue numbers are preceded by “L,” are paintings whose current whereabouts are unknown which are ascribed to Caravaggio in seventeenth-century documents, inventories, and in other sources. The catalogue of lost works describes a wide variety of material, including paintings considered copies of lost originals. Entries for untraced paintings include the city where they were identified in either a seventeenth-century source or inventory (“Inv.”). Most of the inventories have been published in the Getty Provenance Index, Los Angeles. Provenance, documents and sources, inventories and selective bibliographies are provided for the paintings by, after, and attributed to Caravaggio.