SIA Sintesi Non Tecnica Mongrassano
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Long Lasting Differences in Civic Capital: Evidence from a Unique Immigration Event in Italy
Long Lasting Differences in Civic Capital: Evidence from a Unique Immigration Event in Italy. E. Bracco, M. De Paola and C. Green Abstract We examine the persistence of cultural differences focusing on the Arberesh in Italy. The Arberesh are a linguistic and ethnic minority living in the south of Italy. They settled in Italy at the end of the XV century, following the invasion of the Balkans by the Ottoman Empire. Using a large dataset from the Italian parliamentary elections of the lower chamber of the Parliament, taking place from 1946 to 2008, we compare turnout in Arberesh municipalities with turnout in indigenous municipalities located in the same geographical areas. We also use two alternative different indicators of social capital like turnout at referendum and at European Parliament Elections. We find that in Arberesh municipalities turnout and compliance rates are higher compared to indigenous municipalities located in the same area. 1 I. INTRODUCTION A range of evidence now exists that demonstrates the relationship between social capital and a range of important socio-economic outcomes. Using a variety of proxies, social capital has been shown to have predictive power across a range of domains, including economic growth (Helliwell and Putnam, 1995; Knack and Keefer, 1997; Zak and Knack, 2001), trade (Guiso et al., 2004), well- functioning institutions (Knack, 2002), low corruption and crime (Uslaner, 2002; Buonanno et al., 2009) and well functioning financial markets (Guiso et al., 2004a). While this literature demonstrates large and long-lived within and across country differences in values, social and cultural norms rather less is known about the origins of these differences. -

Regione Calabria OCDPC 344/2016 Graduatoria Definitiva in Ordine Di Punteggio
Regione Calabria OCDPC 344/2016 Graduatoria Definitiva in ordine di punteggio Progressivo Codice richiesta Cognome Nome Comune Intervento Ammissibilità Punteggio Contributo Contributo da erogare 1 NCCLNS61M07G372W-03072017-175905-62533 NACCARATO ALFONSO FRANCESCO Dipignano Miglioramento_sismico Ammissibile 12000 € 1.500,00 € 1.500,00 2 TMNRSO59P51D261D-18072017-153140-30160 TOMAINO ROSA Decollatura Miglioramento_sismico Ammissibile 11017 € 15.000,00 € 15.000,00 3 PLTSVR49H19F207B-01082017-120011-34203 POLITO SAVERIO Mileto Demolizione_e_ricostruzione Ammissibile 9057 € 12.000,00 € 12.000,00 4 MZZGPP90D20F537D-01082017-114522-74072 MUZZOPAPPA GIUSEPPE Mileto Miglioramento_sismico Ammissibile 9024 € 81.900,00 € 81.900,00 5 MCCPQL75P03E223D-17072017-135246-20596 MACCHIA PASQUALE Roma Demolizione_e_ricostruzione Ammissibile 9000 € 9.600,00 € 9.600,00 6 GNNNTN81M15F537W-02082017-120209-65560 GENNARO ANTONIO Spilinga Miglioramento_sismico Ammissibile 7239 € 56.550,00 € 56.550,00 7 PLTMGH53E45F207B-01082017-115428-64487 POLITO MARGHERITA Mileto Miglioramento_sismico Ammissibile 7104 € 15.300,00 € 15.300,00 8 NNLFTN72P58F207W-01082017-103631-93482 IANNELLO FORTUNATA Mileto Miglioramento_sismico Ammissibile 6083 € 15.000,00 € 15.000,00 9 SCLSRG52A06F001J-17072017-131442-19027 SICILIA SERGIO Marzi Miglioramento_sismico Ammissibile 5796 € 15.000,00 € 15.000,00 Intervento escluso ai sensi della D.G.R: n° 393 del 13 ottobre 2016. 10 VNNLRT68A41I359V-03082017-212554-73298 VENNERI LIBERATA Rogliano Rafforzamento_locale 5685 € 6.600,00 € 0,00 11 GRSRCC58S18F207S-01082017-113128-41608 -
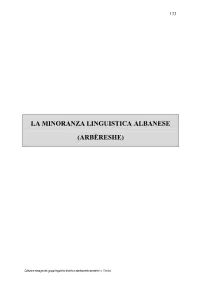
La Minoranza Linguistica Albanese (Arbëreshe)
133 LA MINORANZA LINGUISTICA ALBANESE (ARBËRESHE) Cultura e immagini dei gruppi linguistici di antico insediamento presenti in Italia 134 Ministero Interno – Ufficio Centrale zone di confine e minoranze etniche - Ufficio minoranze linguistiche 135 Area geografica e lingua La minoranza linguistica albanese si è costituita insediandosi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia. In particolare nelle province di: - Avellino, comune di Greci; - Campobasso, comuni di Campomarino, Montecilfone, Portocannone e Ururi; - Catanzaro, comuni di Andali e Caraffa di Catanzaro, Marcedusa, Vena di Maida (fraz. di Maida) e Zangarona; - Cosenza, comuni di Acquaformosa, Castroregio, Cervicati, Cerzeto, Civita, Falconara Albanese, Firmo, Frascineto, Lungro, Mongrassano, Plataci, Santa Caterina Albanese, San Basile, San Benedetto Ullano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Martino di Finita, Santa Sofia d'Epiro, Spezzano Albanese e Vaccarizzo Albanese; - Crotone, comuni di Carfizzi, Pallagorio e San Nicola dell'Alto; - Foggia, comuni di Casalvecchio di Puglia e Chieuti; - Palermo, comuni di Contessa Entellina, Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela; - Pescara, comune di Villa Badessa, (fraz. di Rosciano); - Potenza, comuni di Barile, Brindisi di Montagna, Ginestra, Maschito, San Costantino Albanese e San Paolo Albanese; - Taranto, comune di San Marzano di San Giuseppe. La minoranza è individuata con l’etnonimo arbëresh, che significa appunto ‘albanese’, prendendo origine dal termine arbër/arbëri con il quale s'individuava la nazione ‘Albania’ tra il XV e XVI secolo, nel periodo, cioè, delle migrazioni dall'Albania. Attualmente, infatti, l'etnonimo è shqipëri e non più arbëri. Cultura e immagini dei gruppi linguistici di antico insediamento presenti in Italia 136 La lingua parlata è l'arbërisht, una forma dialettale che si collega con la variante linguistica del sud dell'Albania, da dove ha avuto origine la diaspora. -

Second Report Submitted by Italy Pursuant to Article 25, Paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities
Strasbourg, 14 May 2004 ACFC/SR/II(2004)006 SECOND REPORT SUBMITTED BY ITALY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES (received on 14 May 2004) MINISTRY OF THE INTERIOR DEPARTMENT FOR CIVIL LIBERTIES AND IMMIGRATION CENTRAL DIRECTORATE FOR CIVIL RIGHTS, CITIZENSHIP AND MINORITIES HISTORICAL AND NEW MINORITIES UNIT FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES II IMPLEMENTATION REPORT - Rome, February 2004 – 2 Table of contents Foreword p.4 Introduction – Part I p.6 Sections referring to the specific requests p.8 - Part II p.9 - Questionnaire - Part III p.10 Projects originating from Law No. 482/99 p.12 Monitoring p.14 Appropriately identified territorial areas p.16 List of conferences and seminars p.18 The communities of Roma, Sinti and Travellers p.20 Publications and promotional activities p.28 European Charter for Regional or Minority Languages p.30 Regional laws p.32 Initiatives in the education sector p.34 Law No. 38/2001 on the Slovenian minority p.40 Judicial procedures and minorities p.42 Database p.44 Appendix I p.49 - Appropriately identified territorial areas p.49 3 FOREWORD 4 Foreword Data and information set out in this second Report testify to the considerable effort made by Italy as regards the protection of minorities. The text is supplemented with fuller and greater details in the Appendix. The Report has been prepared by the Ministry of the Interior – Department for Civil Liberties and Immigration - Central Directorate for Civil Rights, Citizenship and Minorities – Historical and new minorities Unit When the Report was drawn up it was also considered appropriate to seek the opinion of CONFEMILI (National Federative Committee of Linguistic Minorities in Italy). -

MONGRASSANO Scuola Dell’Infanzia, Primaria E Secondaria I Grado Via M
Istituto Comprensivo FAGNANO CASTELLO - C.F. 99003240787 C.M. CSIC81500X - Ufficio Protocollo - Fagnano Castello - Via M.Montessori 22/26 Prot. 0005233/U del 18/11/2020 11:09:43Ammissioni e iscrizioni Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ISTITUTO COMPRENSIVO FAGNANO CASTELLO - MONGRASSANO Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado Via M. Montessori, 22/26 – 87013 FAGNANO CASTELLO (Cosenza) Cod. Min. CSIC81500X – Codice Fiscale 99003240787 – Codice Ufficio per fattura elettronica UFFZJK Tel. 0984/525234 – Fax 0984/526735 Sito Internet: www.icfagnanocastello.edu.it E mail: [email protected] – Pec: [email protected] Circ. n. 71 Fagnano Castello 17/11/2020 Ai Sigg.ri genitori degli alunni delle future classi prime All’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura del Comune di Fagnano Castello del Comune di Santa Caterina Albanese del Comune di Mongrassano A tutti i docenti in servizio Al personale ATA All’Albo on line Al sito web dell’Istituto Oggetto: iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/22 Si rende noto che, dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2022, sono aperte le iscrizioni degli alunni che dovranno frequentare i plessi di Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado di questo Istituto, per l’anno scolastico 2021/2022, secondo quanto previsto dalla Nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO- UFFICIALEU.0020651 del 12 novembre 2020. Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro” (possono anche utilizzare l’applicazione “Scuola in chiaro in un app”), il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere nei prossimi anni. -

Acquaformosa 760 250 Acquappesa 1280 400 Acri 14000 4250 Aiello
Mascherine Comune Chirurgiche Montrasio Acquaformosa 760 250 Acquappesa 1280 400 Acri 14000 4250 Aiello Calabro 1120 350 Aieta 560 150 Albidona 880 250 Alessandria del Carretto 280 100 Altilia 480 150 Altomonte 3040 900 Amantea 9720 2950 Amendolara 2000 600 Aprigliano 2000 600 Belmonte Calabro 1320 400 Belsito 640 200 Belvedere Marittimo 6400 1950 Bianchi 880 250 Bisignano 6960 2100 Bocchigliero 840 250 Bonifati 1920 600 Buonvicino 1520 450 Calopezzati 960 300 Caloveto 840 250 Campana 1160 350 Canna 480 150 Cariati 5600 1700 Carolei 2320 700 Carpanzano 160 50 Casali del Manco 6880 2100 Cassano all'Ionio 12520 3800 Castiglione Cosentino 2040 650 Castrolibero 6720 2050 Castroregio 200 50 Castrovillari 15120 4600 Celico 1920 600 Cellara 360 100 Cerchiara di Calabria 1600 500 Cerisano 2120 650 Cervicati 560 150 Cerzeto 920 300 Cetraro 6920 2100 Civita 600 200 Cleto 880 250 Colosimi 840 250 Corigliano-Rossano 25400 7750 Cosenza 46520 14150 Cropalati 720 200 Crosia 6880 2100 Diamante 3640 1100 Dipignano 3000 900 Domanico 640 200 Fagnano Castello 2600 800 Falconara Albanese 1000 300 Figline Vegliaturo 800 250 Firmo 1400 400 Fiumefreddo Bruzio 2000 600 Francavilla Marittima 2000 600 Frascineto 1400 450 Fuscaldo 5640 1700 Grimaldi 1120 350 Grisolia 1560 450 Guardia Piemontese 1320 400 Lago 1720 550 Laino Borgo 1280 400 Laino Castello 560 150 Lappano 640 200 Lattarico 2720 800 Longobardi 1640 500 Longobucco 2040 600 Lungro 1720 500 Luzzi 6320 1950 Maierà 840 250 Malito 520 150 Malvito 1200 350 Mandatoriccio 1880 600 Mangone 1280 400 Marano Marchesato -
L'apparato Digerente
Storia di Mongrassano Mongrassano fu costruita dagli albanesi (arbëreshë) di rito greco-bizantino che, dopo aver lasciato la patria a causa della conquista ottomana (turca), si diressero verso l’Italia. Era quello che nel Regno di Napoli veniva definito "casale", ossia un villaggio non fortificato inserito nel territorio di un centro abitato più importante. In questo caso, Mongrassano era casale di San Marco Argentano sede vescovile e, per secoli, centro principale dell'omonimo ducato, che risaliva al tempo dei Longobardi e poi dei Normanni. A far ripopolare il casale dai profughi albanesi che fuggivano dall'invasione ottomana musulmana, attorno al 1470, fu quasi certamente l'allora duca di San Marco, Luca Sanseverino, il quale era anche principe di Bisignano e, in ogni caso, uno dei più influenti baroni del Regno di Napoli. Qualche anno più tardi, nel 1479, il figlio di Luca e nuovo feudatario di quei luoghi, Geronimo (Gerolamo) Sanseverino, concesse alla Mensa vescovile di San Marco una parte delle sue prerogative feudali relative al casale albanese, e da quel momento i vescovi di San Marco Argentano si fregiarono del titolo di Baroni di Mongrassano. Nel 1543 gli abitanti furono oggetto, come negli altri 44 casali albanesi esistenti in Calabria Citeriore, di uno specifico censimento fiscale che diede questi risultati: 63 "fuochi", ossia nuclei familiari, per un totale di 194 abitanti; i cognomi registrati dai numeratori regi furono: Arrigoni, Capparello, Cingaro, Drames, Lo Russo, Migliano, Mosciara, Petta, Rotundo, Smilara, Tabularo (Tavolaro/Tavolari), Yerbes (o Ayerbes). Dei successivi censimenti si conoscono solo i totali: 62 fuochi nel 1561; 55 fuochi nel 1595; 70 fuochi nel 1648; 43 fuochi nel 1669 (periodo difficile, quest'ultimo, in cui era ricomparsa la peste). -

Aree Territoriali Della Provincia Di Cosenza
Aree Territoriali della Provincia di Cosenza Area Pollino Acquaformosa - Altomonte - Castrovillari - Cervicati - Civita - Fagnano Castello - Firmo - Frascineto - Laino Borgo - Laino Castello - Lungro - Malvito - Mongrassano - Morano Calabro - Mormanno - Mottafollone - Roggiano Gravina - San Basile - San Donato di Ninea - San Lorenzo del Vallo - San Marco Area Jonio Argentano - San Sosti - Santa Caterina Albanese - Nocara Saracena - Spezzano Albanese - Sant'Agata d'Esaro - Rocca Imperiale Albidona - Alessandria del Carretto - Canna Tarsia - Terranova da Sibari Amendolara - Bocchigliero - Calopezzati Oriolo - Caloveto - Campana - Canna - Cassano Montegiordano Castroregio allo Ionio - Cariati - Castroregio - Roseto Capo Spulico Cerchiara di Calabria - Corigliano Castroregio Alessandria del Carretto Laino Borgo Calabro - Cropalati - Francavilla M. - Tortora Amendolara Longobucco - Mandatoriccio - Mirto Albidona Laino Castello Crosia - Montegiordano - Nocara - Aieta San Lorenzo Bellizzi Plataci Oriolo - Paludi - Pietrapaola - Plataci - Mormanno Praia a Mare Trebisacce Rocca Imperiale - Roseto Capo Spulico - Morano Calabro Papasidero San Rossano - San Cosmo Albanese - San Nicola Frascineto Cerchiara Di Calabria Arcella Castrovillari Santa Villapiana Demetrio Corone - San Giorgio Albanese Domenica Talao Civita Francavilla Marittima - San Lorenzo Bellizzi - Scala Coeli - Scalea Orsomarso San Basile Terravecchia - Trebisacce - Vaccarizzo Saracena Albanese Santa Maria Verbicaro Verbicaro Del Cedro Lungro San Donato Di Ninea Cassano allo Jonio Grisolia -

Collaboratore Scolastico
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA ELENCO BENEFICIARI POSIZIONI ECONOMICHE PROVINCIA COSENZA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO 0001) ABATE FRANCESCO NATO IL 10/11/1967 A ORIOLO CODICE FISCALE: BTAFNC67S10G110N SEDE DI TITOLARITA': CSIC80400D IC ORIOLO COMUNE DI : ORIOLO DECORRENZA DEL BENEFICIO ECONOMICO : 01/09/2008 0002) ABATE SILVANA MARISA NATA IL 22/04/1965 A RENDE CODICE FISCALE: BTASVN65D62H235X SEDE DI TITOLARITA': CSEE12300T CD RENDE II COMUNE DI : RENDE DECORRENZA DEL BENEFICIO ECONOMICO : 01/09/2008 0003) ABBRUZZESE ENZO NATO IL 09/09/1968 A BISIGNANO CODICE FISCALE: BBRNZE68P09A887K SEDE DI TITOLARITA': CSIC89000N IC RENDE N.1 COMUNE DI : RENDE DECORRENZA DEL BENEFICIO ECONOMICO : 01/09/2008 0004) ABENANTE FRANCO NATO IL 23/01/1962 A TORANO CASTELLO CODICE FISCALE: BNNFNC62A23L206O SEDE DI TITOLARITA': CSIS01900B I.I.S. CASTROVILLARI "IPSIA-IPSC" COMUNE DI : CASTROVILLARI DECORRENZA DEL BENEFICIO ECONOMICO : 01/09/2008 0005) ABRITTA FRANCA NATA IL 10/01/1961 A ROGGIANO GRAVINA CODICE FISCALE: BRTFNC61A50H488U SEDE DI TITOLARITA': CSEE09800A CD LUZZI COMUNE DI : LUZZI DECORRENZA DEL BENEFICIO ECONOMICO : 01/09/2008 0006) ACCATTATO GIUSEPPINA NATA IL 24/09/1964 A ORIOLO CODICE FISCALE: CCTGPP64P64G110M SEDE DI TITOLARITA': CSRC07000E IPSC ORIOLO COMUNE DI : ORIOLO DECORRENZA DEL BENEFICIO ECONOMICO : 01/09/2008 PAG. 1 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 0007) ACCIARDI EVARISTO DANIELE NATO -

Sources: Esri, USGS, NOAA Negative 10000 M. Province Municipality
Sarconi San Chirico Noepoli Valsinni Rotondella Nova Siri Rotondella Gallipoli Castronuovo Lecce Moliterno Raparo Calvera NoepoliSan Gallipoli Castelsaraceno di Sant'Andrea Senise Giorgio 31/12/2018 Lagonegro Lucano Rocca Gallipoli Carbone Teana Chiaromonte Nocara Imperiale Canna Lecce Fardella Potenza ¯ Noepoli Latronico Episcopia Nemoli Francavilla Chiaromonte in Sinni Oriolo Montegiordano Rivello Fardella San Cersosimo Lauria Costantino Fardella Fardella Roseto Castelluccio Albanese Castroregio Chiaromonte San Capo Maratea Superiore Severino San Paolo Castroregio Spulico Albanese Trecchina Castelluccio Lucano Inferiore Terranova Oriolo Amendolara Viggianello di Pollino Alessandria Maratea del Carretto Tortora Laino Borgo Maratea Fardella Albidona Potenza Chiaromonte San Laino Rotonda Lorenzo Bellizzi Plataci Castello Cerchiara Aieta Trebisacce Mormanno di Calabria Cerchiara Praia a Mormanno Morano Villapiana Papasidero Frascineto di Calabria Praia Mare Calabro a Mare San !( 0 5 10 20 Nicola Arcella !( Civita Francavilla km San Nicola Santa Marittima Arcella Domenica Paterno Calabro San Basile Scalea Talao Orsomarso Saracena !( Domanico Castrovillari Cassano !( all'Ionio Santa Maria Verbicaro Lungro !( !( del Cedro Acquaformosa !( !( !(Firmo Spezzano San Donato San Grisolia Lorenzo Albanese di Ninea Diamante Maierà del Vallo !( Altomonte Terranova Diamante !( San Sosti da Sibari Malito Buonvicino San Giorgio Belsito !( !( Corigliano-Rossano Albanese Belvedere Roggiano !( !( Mottafollone Tarsia !( Marittimo Gravina !( San Crosia Sant'Agata -

Long Lasting Differences in Civic Capital: Evidence from a Unique Immigration Event in Italy
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Bracco, Emanuele; De Paola, Maria; Green, Colin P. Working Paper Long Lasting Differences in Civic Capital: Evidence from a Unique Immigration Event in Italy IZA Discussion Papers, No. 8808 Provided in Cooperation with: IZA – Institute of Labor Economics Suggested Citation: Bracco, Emanuele; De Paola, Maria; Green, Colin P. (2015) : Long Lasting Differences in Civic Capital: Evidence from a Unique Immigration Event in Italy, IZA Discussion Papers, No. 8808, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/108687 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von -

The Arbёresh Culture: an Ace in the Hole, in the Heart Of
THE ARBЁRESH CULTURE: AN ACE IN THE HOLE, IN THE HEART OF CALABRIA by Edna Lubonja A Dissertation Submitted to the Faculty of Dorothy F. Schmidt College of Arts & Letters In Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of Doctor of Philosophy Florida Atlantic University Boca Raton, FL December 2017 Copyright by Edna Lubonja 2017 ii ACKNOWLEDGMENTS The author wishes to express sincere gratitude to her committee members for all their guidance and support, and special thanks to my advisor for her persistence, patience and encouragement during the writing of this manuscript. The author is grateful to college of Arts & Letters for providing financial support to conduct the study. Last, but not least, the author wishes to thank all the locals of the Arbëresh towns in Calabria who were extremely friendly and helpful in providing research contacts. iv ABSTRACT Author: Edna Lubonja Title: The Arbëresh Culture: An Ace in the Hole, in the Heart of Calabria Institution: Florida Atlantic University Dissertation Advisor: Dr. Ilaria Serra Degree: Doctor of Philosophy Year: 2017 The Arbëresh of Italy founded their communities in the 1400s when they were forced to flee their homeland, Albania, as the country was conquered and ruled by the Ottoman Empire. For centuries, they kept a close community in the Italian villages preserving their language, culture, rituals and traditions. These elements have defined them as “others” in the Italian community over the centuries, but today, they are better described as Italians who also embrace the Arbëresh culture. This dissertation explores the narratives of Arbëresh authors such as Carmine Abate, Anna Stratigò, and Pino Cacozza, who have preserved glimpses of their culture in their writings, thus creating an oasis that I call “the Arbëresh Utopia.” I situate them in the larger context of Arbëresh history, and in the environment where their stories are located.