Monte Adamello
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Notifica Ai Contribuenti Gentili Contribuenti, Si
PAT/RFS133/U251-28/09/2020-0590025 - Allegato Utente 1 (A01) Servizio Catasto Ufficio del Catasto di Tione Via III Novembre, 38 - 38079 Tione T +39 0465 324086 F +39 0465 328407 pec [email protected] @ [email protected] web www.catasto.provincia.tn.it Notifica Ai contribuenti Oggetto: Notifica ai sensi dell'art. 7, comma 9 bis, D.L. 19062015, n. 78 Gentili contribuenti, - ai sensi dell'art. 7, c. 9-bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 - in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 6 e dall'art.2, c.33 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 si notifica che, è stato effettuato l'aggiornamento delle informazioni censuarie relative ai terreni iscritti al Catasto Fondiario sulla base degli elenchi forniti da APPAG (Agenzia Provinciale per i Pagamenti), che li ha prodotti tenendo conto delle dichiarazioni rese agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli. Da questa operazione deriva, la determinazione di un nuovo reddito dominicale e di un nuovo reddito agrario, per le particelle dei Comuni Catastali di Bondo, Roncone, Breguzzo I, Lardaro I, Breguzzo II. Gli interessati possono prendere visione degli aggiornamenti consultando l'elenco delle particelle modificate presso : - il Comune di Sella Giudicarie; - l'Ufficio del Catasto di Tione, previo appuntamento; - sul sito del Servizio Catasto all'indirizzo http://www.catasto.provincia.tn.it/notifiche/notifiche_variaz_coltura/ La presente comunicazione è stata redatta, inoltre, tenendo conto degli articoli 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione) e 7 (Chiarezza e motivazione degli atti) della legge 27 luglio 2000, n. -

21-Trentino Alto Adige
REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Opere generali 100 itinerari sulle Alpi. Dalla Liguria al Friuli-Venezia Giulia”. - Novara : De Agostini, 1993. - 223 p. 15^ rassegna internazionale dell’editoria di montagna. Trento, 27 aprile-6 maggio 2001. Bolzano, 20 settembre-7 ottobre 2001”. - S.l. : s.n., 2001. - 309 p. Andreotti , Giuliana “Euroregione Tirolo. Un nuovo modo di pensare l’Europa”. - Trento : Edizioni Colibrì, 1995. - 275 p. Atti della II conferenza internazionale sulla sicurezza in montagna. Bolzano, 4-6 ottobre 1983”. - Bolzano : Provincia Autonoma, s.d. - 171 p. + 57 c. Bazan , Carlo “La Valle del Vanoi. Il nuovo documentario”. - Crocetta del Montello : Carlo Bazan Produzioni Video, 1998. - VHS ; 59 min. Berti , Camillo “Nei parchi delle Dolomiti Orientali (Sesto, Bràies-Sènnes-Fànes, Ampézzo). Guida per l’escursionismo”. - Pieve d’Alpago : Nuove Edizioni Dolomiti, 1991. - 335 p. Biotopo di Sluderno (Il)”. - Bolzano : Provincia Autonoma, s.d. - 28 c. + 1 c. Boccaccini , Guido “I Monti pallidi. Le Dolomiti dal Catinaccio alle Tre Cime di Lavaredo”. - Novara : De Agostini, 1992. - VHS ; 30 min. Boccaccini , Guido “La terra tra i monti. Le valli dell’Alto Adige”. - Novara : De Agostini, 1992. - VHS ; 30 min. Camanni , Stefano “Le più belle escursioni delle Alpi. Dalle Liguri alle Giulie”. - Torino : Vivalda, 1993. - 81 p. Cammelli , Fabio “Primi passi nelle Alpi Aurine e Pusteresi. 105 facili passeggiate”. - Trento : Edizioni Panorama, 2000. - 152 p. Cammelli , Fabio e Vanni “Primi passi nelle Dolomiti. Escursioni scelte per famiglie e non esperti”. - Trento : Edizioni Panorama, 1999. - 245 p. Carmignola , Giorgio e Krause, Michaela “Lo stambecco in Alto Adige”. - Bolzano : Provincia Autonoma : Athesia, 2000. -

Brescian Trails Hiking in the Province of Brescia - Brescia, Provincia Da Scoprire Bibliography
Brescian Trails Hiking in the Province of Brescia www.rifugi.lombardia.it - www.provincia.bs.it Brescia, provincia da scoprire Bibliography Grafo Edolo, l’Aprica e le Valli di S. Antonio, 2010 Le Pertiche nel cuore della Valsabbia, 2010 Gargnano tra lago e monte, 2010 I colori dell’Alto Garda: Limone e Tremosine, 2008 Il gigante Guglielmo tra Sebino e Valtrompia, 2008 L’Alta Valcamonica e i sentieri della Guerra Bianca, 2008 L’antica via Valeriana sul lago d’Iseo, 2008 Sardini Editrice Guida ai sentieri del Sebino Bresciano, 2009 Guida al Lago d’Iseo, 2007 Parco Adamello Guida al Parco dell’Adamello Provincia di Brescia Parco dell’Adamello Uffici IAT - Informazione e Accoglienza Turistica Sentiero Nr1, Alta Via dell’Adamello Brescia Lago di Garda Piazza del Foro 6 - 25121 Brescia Desenzano del Garda Ferrari Editrice Tel. 0303749916 Fax 0303749982 Via Porto Vecchio 34 [email protected] 25015 Desenzano del Garda I Laghi Alpini di Valle Camonica Vallecamonica Tel. 0303748726 Fax 0309144209 [email protected] Associazione Amici Capanna Lagoscuro Darfo Boario Terme Il Sentiero dei Fiori Piazza Einaudi 2 Gardone Riviera 25047 Darfo Boario Terme Corso Repubblica 8 - 25083 Gardone Riviera Tel. 0303748751 Fax 0364532280 Tel. 0303748736 Fax 036520347 Nordpress [email protected] [email protected] Il sentiero 3v Edolo Salò La Val d’Avio Piazza Martiri Libertà 2 - 25048 Edolo Piazza Sant’Antonio 4 - 25087 Salò Tel. 0303748756 Fax 036471065 Tel. 0303748733 Fax 036521423 [email protected] [email protected] Ponte di Legno Sirmione Corso Milano 41 Viale Marconi 6 - 25019 Sirmione Maps 25056 Ponte di Legno Tel. -

PGST03 Teaching Workshop Building – Or Rebuilding – the Websites and the Web Presence of Regional Dmos Responsible: Professor Roberto Giovanni Peretta
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO Academic year 2014-2015, second term: 2014 November through December Master’s Degree Course in Progettazione e gestione dei sistemi turistici / Planning and Management of Tourism Systems. Curriculum: International Tourism and Local Governance PGST03 Teaching Workshop Building – or rebuilding – the websites and the web presence of Regional DMOs Responsible: Professor Roberto Giovanni Peretta. Full Professor: Professor Rossana Bonadei. Final report, released on December 23, 2014 by the workshop’s participants Débora Bañuelos Luna, Alice Bozzoni, Francesca Breda, Veronica Calvi, Marilena Cretti, Maria Giovanna Demontis, Cristina Ferrari, Daniela Larcher, Chiara Mafessoni, Mattia Polimeni, Marta Poloni, Svetlana Repina, Regina Sapego, Nhat Vuong Quang 1. The PGST03 2014-2015 workshop 2. Valle Camonica 3. La Valle dei Segni project 4. The web presence of Valle Camonica tourism 4.1 Web visibility of Valle Camonica as a destination 4.2 Valle Camonica’s official tourism websites 4.3 Facebook pages for tourism in Valle Camonica 4.4 Valle Camonica tourism’s web presence in social networks other than Facebook 4.5 Valle Camonica’s web presence in travel communities 1. The PGST03 2014-2015 workshop The workshop was designed to consider existing literature, visit a chosen area assisted by local experts, evaluate the digital resources in existence, share discussions, and deliver a final report. The chosen area was the Valle Camonica, a mountain sub-region of Northern Italy which is currently in the process of building its own Destination Management Organization (DMO) under La Valle dei Segni project. It appears that – thanks also to the assistance of the local Cooperativa Voilà, which we warmly thank for their cooperation – the workshop’s tasks have been completed. -

I Nomi Locali Dei Comuni Di Bolbeno, Bondo, Breguzzo, Roncone, Zuclo
I nomi locali dei comuni di Bolbeno, Bondo, Breguzzo, Roncone, Zuclo a cura di Lidia Flöss Trento : Provincia autonoma di Trento, Servizio Beni librari e archivistici, 1996. Dall'età longobarda ai nostri giorni In epoca longobarda Bolbeno, Bondo, Breguzzo, Roncone e Zuclo vennero a far parte di quell'assetto giuridico-istituzionale che prende il nome di Judicaria Summa Laganensis: "la regione a nord del Garda che probabilmente comprendeva pressapoco lo spazio racchiuso entro il quadrilatero irregolare formato dai bacini orografici del Sarca e del Chiese."1 Nel codicillo del 927 al suo testamento del 921 il vescovo di Verona Notkerio lasciò tutti i suoi beni ubicati appunto in Judicaria Summa Laganensis, in locis et fundis Bregutio, Belveno et Bundo ai canonici del Duomo di Verona, che vi esercitavano anche la giurisdizione.2 Il territorio dell'immunità comprendeva i paesi di Bolbeno, Bondo e Breguzzo, nonché il paese di Zuclo che, nel corso degli anni, si era staccato da Bolbeno ed era divenuto comunità autonoma.3 Questi territori rimasero soggetti all'autorità della chiesa veronese per più secoli, come risulta dalle riconferme dei Ottone II nel 983, di Enrico II nel 1014 e di Enrico III nel 1047.4 Anche dopo la formazione della contea vescovile (con la donazione di Corrado II al vescovo Uldarico - 1027 - del Comitatus Tridentinus), questa zona costituì fino alla fine del XIII secolo un'enclave immunitaria nel Principato vescovile.5 In un documento steso a Zuclo il 19 luglio 1238 e conservato all'Archivio capitolare di Verona6 sono descritti i confini del territorio soggetto all'immunità: Nos dicimus per nostra sacramenta quod sicut trahit a rivulo riverio usque in summo Azie montis in montibus et planitiis et deinde usque ad aquam pioclosam et inde usque ad Clozam Laci Ronconi et inde usque in summo Copedelli, sicuti possident illi de Bondo et de Bergucio et illi de Bolbeno et de Desuculo.7 Questa enclave era mal tollerata dal vescovo di Trento che, con l'aiuto dei suoi vassalli Conti da Campo, cercò in più occasioni di appropriarsene. -

CYCLING ALONG the MOST FAMOUS “GIRO D'italia” PASSES Tour for Passionate Road Cyclists
CYCLING ALONG THE MOST FAMOUS “GIRO D'ITALIA” PASSES Tour for passionate road cyclists WHAT YOU’LL DISCOVER In these tours you will cycle along Lombardy, among the most famous passes of the “Giro d'Italia”: in CAMONICA VALLEY (2) and in TELLINA VALLEY (1). The color that represents the Camonica Valley is GREY, the color of the UNESCO heritage rocks engraved in the Neolithic, and the high peaks, cradle of the majestic Presena glacier. Camonica valley is also a UNESCO Biosphere Reserve since 2019. The color of Valtellina is VIOLET, which represents the crisp air of high mountains between the famous passes of northern Italy: Stelvio, Gavia but also towns like Bormio, Livigno and Saint Moritz in nearby Switzerland. Violet are also the grapes and the wines produced in this land CHOOSE WHAT SUITS YOU BEST! Here you will find some passes routes for cycling enthusiasts. They are all part of the “Giro d’Italia” the most famous and important annual multiple-stage bicycle race. The passes we chose are all located in north-eastern Lombardy in Camonica Valley and Valtellina. You have to know that we could personalize everything for you, as ascent and distance. Choose far in advance which of these routes you will want to ride with other people or with a groups of friends. This way you will be sure to reserve the best period for you and to do it with our organization. Lovere (Bg) my little town, is situated in the upper Sebino (lake Iseo) and in 2019 was the starting point of the most hard step of the much followed tour “Giro d’Italia”. -

Large Carnivores Report 2018
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO LARGE CARNIVORES REPORT 2018 www.grandicarnivori.provincia.tn.it Bianca PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO APT FORESTRY AND WILDLIFE DEPARTMENT Large Carnivores Division LARGE CARNIVORES REPORT 2018 grandicarnivori.provincia.tn.it [email protected] Supervision Maurizio Zanin - Manager of the Forestry and Wildlife Department - Autonomous Province of Trento (APT) Coordination Claudio Groff Edited by Fabio Angeli Daniele Asson Natalia Bragalanti Claudio Groff Luca Pedrotti Paolo Zanghellini With the contribution of Museo delle Scienze di Trento (MUSE), Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino (PNPPSM), Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA) and the Fondazione Edmund Mach (FEM). Recommended Citation “Groff C., Angeli F., Asson D., Bragalanti N., Pedrotti L., Zanghellini P. (editors), 2019. 2018 Large Carnivores Report, Forestry and Wildlife Department - Autonomous Province of Trento” All the graphs, maps and all the data contained in this report may be quoted, making reference to the above citation. Cover page “Female bear with cubs in the Brenta Range” Photo Franco Cadonna - APT Forestry and Wildlife Department Archives Back cover Photo Ruggero Alberti - APT Forestry and Wildlife Department Archives Photos without captions APT Forestry and Wildlife Department Archives Layout and graphics APT Large Carnivores Division - Publistampa Arti grafiche Printed in 100 copies by: Print centre of the Autonomous Province of Trento Trento, May 2019 Digital version at: grandicarnivori.provincia.tn.it/Rapporto-grandi-carnivori-2018/ INDEX 1. MONITORING 1.1 Bear pag. 5 1.2 Wolf pag. 21 1.3 Lynx pag. 27 2. DAMAGE COMPENSATION AND PREVENTION pag. 28 3. MANAGEMENT OF EMERGENCIES pag. -
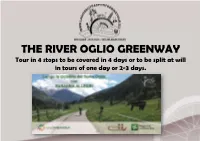
THE RIVER OGLIO GREENWAY Tour in 4 Stops to Be Covered in 4 Days Or to Be Split at Will in Tours of One Day Or 2-3 Days
THE RIVER OGLIO GREENWAY Tour in 4 stops to be covered in 4 days or to be split at will in tours of one day or 2-3 days. WHAT YOU’LL DISCOVER In these tours and stops you will cycle along a portion of the RIVER OGLIO GREENWAY: a route that will take you from the mountains of the upper Camonica Valley (2) along the shores of Lake Iseo (5) reaching the vineyards of Franciacorta (6). This greenway was awarded as the most beautiful cycle path in Italy at the Italian Green Road Awards 2019, it starts from the Tonale Pass at an altitude of 1883 and ends in the plain, in the province of Mantua, with an altitude difference of 1862mt, spread along its 280 km. The colors of the different areas will accompany you in the description of these stops. The tour can be cycled completely or can be split into 1- or 2-3-days tours. STOP N° 1 UPPER CAMONICA VALLEY You will set off from Tonale Pass riding along a dirt road, then reach Ponte di Legno, a nice high mountain town in Camonica Valley, where the two springs Frigidolfo and Narcanello merge and create the River Oglio. Tonale Pass, that marks the border between Lombardy and Trentino regions, is surrounded by the mountains where soldiers fought WW1 at the foot of Mount Adamello. We will cycle across part of Camonica Valley, stopping at a typical Italian trattoria if you wish. Then on to the land of the prehistoric Camuni, the first Italian Unesco World Heritage site: the rock engravings. -

Tree Rings Have Characteristics That Made Them an Exceptionally Source
Università degli Studi di Pisa Dipartimento di Scienze della Terra Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze di Base Galileo Galilei Programma di Scienze della Terra XXIII Ciclo 2008 – 2010 Dissertazione Finale Anna Coppola Dendroclimatic analysis in the Adamello-Presanella Group (Central Italian Alps) Tutore: prof. Carlo Baroni Referees: prof.M. Pelfini Co-tutore: dott. Giovanni Leonelli prof. A. Carton Direttore della Scuola prof. Fabrizio Broglia Presidente del Programma prof. Roberto Santacroce Table of contents Abstract ..................................................................................................................................... 1 1 Introduction ...................................................................................................................... 3 2 Study area .......................................................................................................................... 5 Geological lineaments ............................................................................................................ 7 Vegetation lineaments ............................................................................................................ 9 Larix decidua Mill. characteristics and distribution ............................................................ 12 Picea abies ( L.) Karst. characteristics and distribution ..................................................... 14 3 Materials and methods .................................................................................................. -

Intervento Del Presidente Sezione Di Controllo Per La Regione Trentino
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2021 INTERVENTO DEL PRESIDENTE Anna Maria Rita Lentini TRENTO, 5 MARZO 2021 SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2021 INTERVENTO DEL PRESIDENTE Anna Maria Rita Lentini TRENTO, 5 MARZO 2021 La cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 non può avere svolgimento nelle consuete forme, a causa della grave emergenza sanitaria che ha colpito il Paese, imponendo misure di massima cautela. Ciò non impedirà tuttavia di assolvere, sia pure nelle modalità consentite, attraverso il deposito e la comunicazione di una relazione, al dovere di resa del conto di quanto concretamente svolto nell’esercizio delle funzioni intestate alla Sezione del controllo della Corte dei conti, sede di Trento, che ho l’onore di presiedere. Il bilancio è “bene pubblico”. L’abbiamo sentito dire più volte e io stessa l’ho ricordato in più occasioni, ma mi sembra importante avere sempre ben presente l’obiettivo del nostro lavoro. Il bilancio come bene pubblico è l’espressione sintetica di uno scrigno di valori di cui è custode la Corte dei conti, valori che danno ragione dell’intestazione delle funzioni di controllo esterno ad un organo magistratuale di rilevanza costituzionale, terzo e indipendente. La ragione di tale intestazione è, dunque, una ragione alta: la Corte, custode del “bene pubblico bilancio” è al servizio dello Stato-Comunità, al servizio dei cittadini e non vi può essere responsabilità più grande, responsabilità che evidentemente condividiamo con gli amministratori, con tutti coloro che svolgono funzioni pubbliche, ciascuno per la sua parte. -

The Southern Frontiers of Austria Author(S): Douglas W
The Southern Frontiers of Austria Author(s): Douglas W. Freshfield Source: The Geographical Journal, Vol. 46, No. 6 (Dec., 1915), pp. 414-433 Published by: geographicalj Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1780110 Accessed: 06-05-2016 12:49 UTC Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://about.jstor.org/terms JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Wiley, The Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers) are collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to The Geographical Journal This content downloaded from 143.89.105.150 on Fri, 06 May 2016 12:49:48 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms 414 THE SOTJTHERN FRONTIERS OF ATJSTRIA. number of new members who will have joined us this year. These figures speak well for the patriotism and the good sense of our Fellows. I mention patriotism, for economy is in the air; it is preaehed every- where and practised in most places?except, perhaps, some Government departments. But it is a false economy that would try to dispense with necessaries, and our Society at the present moment is in more ways than one a necessary for the nation. To have at hand, collected and collated, and ready for use, a store of geographical facts as to any possible seat of war; to cultivate the habit of mind?the sense of country, the geographical attitude?that can reason and act promptly on such facts, are obvious conditions of military and naval success. -

Progetto CARG Per APAT - Dipartimento Difesa Del Suolo: F
tione_059_10-01-06_E 6-03-2006 17:27 Pagina 1 NOTE ILLUSTRATIVE della CARTA GEOLOGICA D’ITALIA alla scala 1:50.000 foglio 059 TIONE DI TRENTO a cura di Alberto Castellarin(1), Giorgio Vittorio Dal Piaz(2), Vincenzo Picotti(1), Luigi Selli(1), Luigi Cantelli(1), Silvana Martin(7), Laura Montresor(2), Guido Rigatti(2), Giacomo Prosser(3), Guido Bollettinari(4), Giovanni PROGETTO Battista Pellegrini(2), Alberto Carton(5), Mario Nardin(6). con il contributo degli Autori citati nell’Introduzione (1) Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico Ambientali, Università di Bologna; (2) Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica, Università degli Studi di Padova; (3) Dipartimento di Scienze Geologiche, Università degli Studi della Basilicata; (4) Libero Professionista; (5) Dipartimento di Scienze delle Terra, Università di Pavia; (6) Provincia Autonoma di Trento, Servizio Geologico; (7) Università dell’Insubria - sede di Como. Provincia Autonoma CARG di Trento Ente realizzatore: Servizio Geologico tione_059_10-01-06_E 6-03-2006 17:27 Pagina 2 Direttore Responsabile del Dipartimento Difesa del Suolo (APAT): L. SERVA Responsabile del Progetto CARG per APAT - Dipartimento Difesa del Suolo: F. GALLUZZO Responsabile del Progetto CARG - P.A.T.: M. NARDIN (1992-1998), S. COCCO (dal 1998) Coordinatore scientifico: A. CASTELLARIN e collaborazione di: G. V. DAL PIAZ Comitato Geologico Nazionale (D.P.C.M. 23-3-1999 e 9-12-1999): L. Serva (presidente), G. Arnone, A. Boscherini, S. Cocco, V. Coccolo, U. Crescenti, L. Del Sordo, M. Grasso, P. Manetti, G. Mariotti, G. Pasquaré, R. Pignone, R. Polino, A. Praturlon, M. Santantonio, F. Trincardi Si ringraziano i componenti del precedente Comitato Geologico Nazionale per il loro contributo scientifico.