Forma Urbis Compie Ventʼanni
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

9781107013995 Index.Pdf
Cambridge University Press 978-1-107-01399-5 — Rome Rabun Taylor , Katherine Rinne , Spiro Kostof Index More Information INDEX abitato , 209 , 253 , 255 , 264 , 273 , 281 , 286 , 288 , cura(tor) aquarum (et Miniciae) , water 290 , 319 commission later merged with administration, ancient. See also Agrippa ; grain distribution authority, 40 , archives ; banishment and 47 , 97 , 113 , 115 , 116 – 17 , 124 . sequestration ; libraries ; maps ; See also Frontinus, Sextus Julius ; regions ( regiones ) ; taxes, tarif s, water supply ; aqueducts; etc. customs, and fees ; warehouses ; cura(tor) operum maximorum (commission of wharves monumental works), 162 Augustan reorganization of, 40 – 41 , cura(tor) riparum et alvei Tiberis (commission 47 – 48 of the Tiber), 51 censuses and public surveys, 19 , 24 , 82 , cura(tor) viarum (roads commission), 48 114 – 17 , 122 , 125 magistrates of the vici ( vicomagistri ), 48 , 91 codes, laws, and restrictions, 27 , 29 , 47 , Praetorian Prefect and Guard, 60 , 96 , 99 , 63 – 65 , 114 , 162 101 , 115 , 116 , 135 , 139 , 154 . See also against permanent theaters, 57 – 58 Castra Praetoria of burial, 37 , 117 – 20 , 128 , 154 , 187 urban prefect and prefecture, 76 , 116 , 124 , districts and boundaries, 41 , 45 , 49 , 135 , 139 , 163 , 166 , 171 67 – 69 , 116 , 128 . See also vigiles (i re brigade), 66 , 85 , 96 , 116 , pomerium ; regions ( regiones ) ; vici ; 122 , 124 Aurelian Wall ; Leonine Wall ; police and policing, 5 , 100 , 114 – 16 , 122 , wharves 144 , 171 grain, l our, or bread procurement and Severan reorganization of, 96 – 98 distribution, 27 , 89 , 96 – 100 , staf and minor oi cials, 48 , 91 , 116 , 126 , 175 , 215 102 , 115 , 117 , 124 , 166 , 171 , 177 , zones and zoning, 6 , 38 , 84 , 85 , 126 , 127 182 , 184 – 85 administration, medieval frumentationes , 46 , 97 charitable institutions, 158 , 169 , 179 – 87 , 191 , headquarters of administrative oi ces, 81 , 85 , 201 , 299 114 – 17 , 214 Church. -

The Streets of Rome Walking Through the Streets of the Capital
Comune di Roma Tourism The streets of Rome Walking through the streets of the capital via dei coronari via giulia via condotti via sistina via del babuino via del portico d’ottavia via dei giubbonari via di campo marzio via dei cestari via dei falegnami/via dei delfini via di monserrato via del governo vecchio via margutta VIA DEI CORONARI as the first thoroughfare to be opened The road, whose fifteenth century charac- W in the medieval city by Pope Sixtus IV teristics have more or less been preserved, as part of preparations for the Great Jubi- passed through two areas adjoining the neigh- lee of 1475, built in order to ensure there bourhood: the “Scortecchiara”, where the was a direct link between the “Ponte” dis- tanners’ premises were to be found, and the trict and the Vatican. The building of the Imago pontis, so called as it included a well- road fell in with Sixtus’ broader plans to known sacred building. The area’s layout, transform the city so as to improve the completed between the fifteenth and six- streets linking the centre concentrated on teenth centuries, and its by now well-es- the Tiber’s left bank, meaning the old Camp tablished link to the city centre as home for Marzio (Campus Martius), with the northern some of its more prominent residents, many regions which had risen up on the other bank, of whose buildings with their painted and es- starting with St. Peter’s Basilica, the idea pecially designed facades look onto the road. being to channel the massive flow of pilgrims The path snaking between the charming and towards Ponte Sant’Angelo, the only ap- shady buildings of via dei Coronari, where proach to the Vatican at that time. -
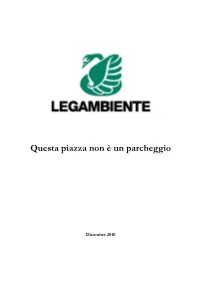
Questa Piazza Non Un Parcheggio
Questa piazza non è un parcheggio Dicembre 2010 Torino - Piazza Vittorio non vuol tornare ad essere un parcheggio I torinesi ne vanno orgogliosi perché è la più grande piazza d’Europa interamente porticata. Piazza Vittorio Veneto negli ultimi anni si è affermata sempre più come cuore pulsante della vita notturna cittadina. Ad innescare il crescente legame tra i torinesi e la piazza è stata senza dubbio la sua pedonalizzazione, avvenuta nel 2006 a ridosso dei Giochi Olimpici Invernali, che ha valorizzato i tratti ottocenteschi dei palazzi che vi si affacciano e favorito l’insediamento dei locali; inoltre, con l’eliminazione dei parcheggi in superficie la piazza ha ritrovato la sua naturale predisposizione a luogo di ritrovo e di aggregazione. La piazza, soprattutto nelle notti del fine settimana, perde però di colpo tutta la sua armonia subendo l’invasione di centinaia di auto a ridosso delle esedre pedonali. Il parcheggio sotterraneo realizzato insieme alla pedonalizzazione, come previsto dalle associazioni ambientaliste ai tempi della progettazione, funge da attrattore di traffico, innescando un vero e proprio cortocircuito: le trincee di auto in sosta selvaggia e i conseguenti ingorghi bloccano, perfino in piena notte, le linee di trasporto pubblico. Risulta così che il servizio di bus notturni “Night Buster” inaugurato nel 2008 sia sott’utilizzato e i parcheggi d’interscambio ai confini della città restino completamente deserti. Brescia – Piazza Paolo VI assediata dalla macchine Piazza Paolo VI, situata nel cuore di Brescia a pochi passi da Piazza Loggia, è ricca dei segni che la storia ha lasciato sulla città. Passaggio del Decumano romano nell’antichità, il largo ospita oggi edifici medievali, dei quali alcuni di inconfondibile stile veneziano. -

Piazze Scomparse Di Roma
PIAZZE SCOMPARSE DI ROMA VISITA ALLE PIAZZE SCOMPARSE DI ROMA TRA STORIA, ARTE, FOLCLORE E RICORDI DEI NONNI Possibile itinerario in bici: piazza Scossacavalli, piazza delle Carrette, piazza Giudea, piazza Montanara, piazza di Campo Carleo. INTRODUZIONE Con questo itinerario vogliamo soffermarci per un attimo sulle tante piazze e vicoli che le operazioni urbanistiche del Ventennio hanno cancellato. Tali interventi sono nati dalla necessità di dare aria e luce ai monumenti più antichi, soprattutto a quelli della Roma imperiale a cui il regime si rifaceva. In tale operazione sono state le piazzette a farne le spese. Oltre a quelle trattate in questo testo ricordiamo piazza dell’Aracoeli, trasformata da un cannocchiale sul Campidoglio in un vialone verso il mare, piazza San Marco diventata uno spazio alberato, una delle pochissime piazze con alberi del centro storico di Roma, le piazze intorno all’Augusteo completamente sparite, piazza Madama, di fronte al palazzo omonimo ridotta ad un semplice toponimo visto che è tutta compresa in corso Rinascimento. Con queste piazzette tutto un mondo si è dissolto. Quando non c’è stata la sparizione fisica degli ambienti, c’è stata la sparizione dell’antico contenuto umano, i veri “romani de’ roma” sono stati deportati nella periferia cittadina, alla borgata Gordiani, al Prenestino, a Pietralata, ad Acilia. Una parte di Roma è morta con loro, noi vogliamo far rivivere proprio quel mondo. PIAZZA DELLE CARRETTE IN CAMPO MARZIO Si trovava alle spalle di San Carlo al Corso venne spazzata via dalle demolizioni degli anni Trenta per far spazio intorno al Mausoleo di Augusto. Si chiamava così perché tale spazio era destinato a rimessa dei mezzi di trasporto per merci e materiali che, all’epoca, consistevano in carri e carrette, come è ovvio. -

UNIVERSITY of CALIFORNIA Los Angeles Female Biographies In
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles Female Biographies in Renaissance and Post-Tridentine Italy A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Italian by Sienna Star Hopkins 2016 © Copyright by Sienna Star Hopkins 2016 ABSTRACT OF THE DISSERTATION Female Biographies in Renaissance and Post-Reformation Italy by Sienna Star Hopkins Doctor of Philosophy in Italian University of California, Los Angeles, 2016 Professor Massimo Ciavolella, Chair This dissertation explores the development of female biography in Renaissance Italy, particularly highlighting the thematic changes the genre experienced as a result of the Counter Reformation, and how the female ideals it portrayed often conflicted with the societal expectations of the donna illustre. The first chapters lay the groundwork for this investigation by providing a survey of the biographical genre in Italy and its ancient Greek and Roman influences, then highlighting the cultural attitudes about women as portrayed in querelle literature and female conduct manuals of 16th and 17th-century Italy. These communicate the standard of expected behavior for women in the Italian Renaissance, by which the female protagonists of biographies are measured, and the juxtaposition reveals that while the protagonists in the earlier biographies generally conform to the standards of contemporary conduct manuals, those in Post Tridentine ii biographies do not. Their protagonists are instead lauded for their fervent, often extreme, religious practices and for their inward search for humility. The investigation thus reveals the genre’s shift in focus to be one that moves from the civic to the religious, from the public donna illustre to the private donna umile. -

Renovatio Urbis
CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by University of Lincoln Institutional Repository renovatio urbis Architecture, Urbanism and Ceremony in the Rome of Julius II Nicholas Temple 1 Agli amici di Antognano, Roma (Accademia Britannica) e Lincoln 2 Contents Illustration Credits Acknowledgements Introduction Chapter 1 - SIGN-POSTING PETER AND PAUL The Tiber’s Sacred Banks Peripheral Centres “inter duas metas” Papal Rivalries Chigi Chapel Chapter 2 - VIA GIULIA & PAPAL CORPORATISM The Politics of Order The Julian ‘Lapide’ Via Giulia The Legacy of Sixtus IV Quartière dei Banchi Via del Pellegrino, via Papale and via Recta Solenne Possesso and via Triumphalis Papal Corporatism Pons Neronianus and Porta Triumphalis Early Christian Precedents 3 Meta-Romuli and Serlio’s Scena Tragica Crossing Thresholds: Peter and Caesar The Papal ‘Hieroglyph’ and the Festa di Agone Chapter 3 - PALAZZO DEI TRIBUNALI and the Meaning of Justice sedes Iustitiae The Four Tribunals The Capitol and Communal/Cardinal’s Palace St Blaise and Justice Iustitia Cosmica Caesar and Iustitia pax Romana Chapter 4 – CORTILE DEL BELVEDERE, VIA DELLA LUNGARA and vita contemplativa “The Beautiful View” via suburbana/via sanctus Passage and Salvation Chapter 5 - ST. PETER’S BASILICA Orientation and Succession Transformations from Old to New Territorium Triumphale Sixtus IV and the Cappella del Coro Julius II and Caesar’s Ashes Janus and Peter 4 Janus Quadrifrons The Tegurium Chapter 6 - THE STANZA DELLA SEGNATURA A Testimony to a Golden Age Topographical and Geographical Connections in facultatibus Triune Symbolism Conversio St Bonaventure and the Itinerarium Mentis in Deum Justice and Poetry Mapping the Golden Age Conclusion - pons/facio: POPES AND BRIDGES The Julian ‘Project’ Pontifex Maximus Corpus Mysticum Raphael’s Portrait Notes Bibliography Index 5 Illustration Credits The author and publishers gratefully acknowledge the following for permission to reproduce images in the book. -

Carlo Fontana 1638-1714 Celebrato Architetto
ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA BIBLIOTHECA HERTZIANA MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR KUNSTGESCHICHTE CONVEGNO INTERNAZIONALE CARLO FONTANA 1638-1714 CELEBRATO ARCHITETTO 22-24 OTTOBRE 2014 Comitato scientifico Paolo Portoghesi, Francesco Moschini, Giuseppe Bonaccorso, Elisabeth Kieven ABSTRACTS Il convegno è organizzato in collaborazione con DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’IMPRESA . UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA CARLO FONTANA 1638-1714 CELEBRATO ARCHITETTO convegno internazionale organizzato da Accademia Nazionale di San Luca Bibliotheca Hertziana - Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Roma in collaborazione con Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa, Università degli Studi di Roma Tor Vergata COMITATO SCIENTIFICO Paolo Portoghesi, Francesco Moschini, Giuseppe Bonaccorso, Elisabeth Kieven ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA Palazzo Carpegna piazza dell’Accademia di San Luca 77, Roma 22 - 24 ottobre 2014 Protagonista dell’architettura romana al crepuscolo del barocco, Carlo Fontana (Rancate 1638-Roma 1714), erede della celebre dinastia di architetti ticinesi, organizzò l’insegnamento e la pratica dell’architettura, fondata sull’esercizio del disegno e sulla geometria. La sua bottega prefigura i moderni atelier di progettazione. L’uso propagandistico delle incisioni e dei volumi a stampa, che illustravano e diffondevano nel mondo le opere e il pensiero di Carlo Fontana, costituisce un ulteriore fattore della sua modernità. In effetti Fontana ha saputo cogliere per primo la dimensione di libertà intellettuale e creativa della stampa, svincolandosi dalla soggezione dei committenti e dalle convenzioni morfologiche e tipologiche del suo tempo. I progetti di Carlo Fontana si dispiegano dai manufatti di uso domestico, agli interni, all’architettura civile, religiosa e militare, fino alle più impegnative infrastrutture urbane e territoriali (porti, acquedotti, granai ecc.). -

I U' H.) 11 2 Abstract
LAVINIA FONTANA; AN ARTIST AND HER SOCIETY IN LATE SIXTEENTH-CENTURY BOLOGNA by Caroline Patricia Murphy Submitted for a Phi) in the History of Art, University College, London, March, 1996 I u' H.) 11 2 Abstract This thesis is a study of the career of one of Europe's first truly successful female painters with the largest attributable oeuvre of any woman artist before the 18th century. It incorporates an analysis of the tastes and consumption patterns, lifestyles and mentalities of the patriciat clergy and scholars of Counter Reformation Bologna who were her patrons. The intent is to identify and categorise her patrons and to explore her artistic appeal to them and to explain the work opportunities created by Counter Reformation initiatives including church refurbishment and charity institutions. It breaks down into six chapters: the first concerns family background, how and why Fontana's painter father Prospero trained her as a painter, the circumstances surrounding her marriage and how it contributed to her career: The second is about her initial clientele of scholars and intellectuals connected with the University at Bologna whose portraits she painted and the Europe-wide cult of collections of images of uomini famosi which helped to give her an international reputation. The three middle chapters deal with the group of Bolognese noblewomen who were undoubtedly Fontana's most significant and high spending patrons, for whom she painted altarpieces, portraits and private devotional works and to whom she became personally connected through godparentage (she had eleven children). One of these chapters looks at these patrons in general terms, the next concerns Laudomia Gozzadini, for whom Fontana painted an enormous family portrait that had very special significance and resonance in the lives of both patron and painter. -

Le Fontane Di Roma La Bellezza Di Roma È Conosciuta in Tutto Il Mondo
Le Fontane di Roma fontana è ispirata alla stella ad otto punte dello La bellezza di Roma è conosciuta in tutto il mondo e stemma della famiglia Albani ed è stata realizzata sono molte le guide che suggeriscono itinerari e dall’architetto Francesco Carlo Bizzaccheri. Al centro segreti della città eterna ma la vera bellezza di di questa si eleva una scogliera scolpita da Filippo Bai questa città è che non finisce mai di stupire. su cui poggiano due tritoni inginocchiati con le code Sembrerà una frase fatta ma “A volte bisogna incrociate scolpiti da Francesco Moratti. Questi perdersi per ritrovarsi” e con Roma funziona in po' ultimi sorreggono una conchiglia. così bisogna perdersi per ritrovare nelle sue parti nascoste la sua vera bellezza. È il motivo per il quale è nata questa rubrica, per potervi guidare alla scoperta della Roma che piace consigliare a noi Concierge, quella che viviamo tutti i giorni, che non ci stanchiamo mai di scoprire e che non vediamo l’ora di poter condividere con voi il più presto possibile dopo questa pandemia. Durante il lockdown le strade si sono svuotate ed i suoni che sono rimasti della nostra città sono quello delle campane e quello dello scorrere dell’acqua delle fontane ed è per questo motivo che abbiamo deciso di iniziare con un itinerario per alcune delle Fontane di Roma. Cominciamo dal Rione Celio, “quartiere” che prende Raggiungendo il lato opposto del Tevere, attraverso il nome dal colle omonimo. Ci troviamo a Piazza della Trastevere raggiungiamo il Gianicolo, uno dei punti Navicella, davanti alla Chiesa di Santa Maria in panoramici della città. -

Pedonalizzazioni a Roma: Parole, Parole, Parole Tutti Gli Interventi Promessi, Approvati… E Mai Realizzati Nella Capitale Dossier Di Legambiente Lazio
Pedonalizzazioni a Roma: parole, parole, parole Tutti gli interventi promessi, approvati… e mai realizzati nella Capitale Dossier di Legambiente Lazio Introduzione Piazza delle Cinque Scole al Ghetto; piazza in Piscinula e piazza De Renzi a Trastevere; oppure piazza Cairoli, piazza S. Paolo alla Regola, piazza Trinità dei Pellegrini, piazza Monte di Pietà in zona Campo de' Fiori, ma anche Via dei Fori Imperiali, Via dei Cerchi o l'Appia Antica. Tutte strapiene di automobili. Per non parlare di piazze e strade nei quartieri meno centrali e della periferia. Di pedonalizzazioni a Roma si parla tanto, ma si fa proprio poco. E il Sindaco Alemanno, ha superato la metà del mandato senza sottrarsi alle chiacchiere. Ecco cosa emerge dal ricco dossier con il quale Legambiente festeggia a modo suo i trent'anni dalla parziale quanto fondamentale liberazione dalle auto dello spazio tra il Colosseo e l'Arco di Costantino, con il resoconto di numerosi sopralluoghi fotografici e soprattutto con tutti gli interventi promessi, approvati… e mai realizzati sulle pedonalizzazioni nella Capitale. Era il 30 dicembre 1980 quando, a due anni dall'avvertimento del Sindaco Argan («O i monumenti o le automobili»), il Colosseo svelò la prima pedonalizzazione italiana, seguita l’anno dopo da Piazza Navona e Piazza di Spagna. Oggi nella Capitale sono pedonali 396.195 metri quadri tra strade e piazze, e possono sembrare tanti ma in realtà sono solo lo 0,03% della superficie comunale. Roma con 14 metri quadri per abitante di aree pedonalizzate si piazza al 62° posto in Italia, nella parte bassa della classifica nazionale che vede una media nelle diverse realtà urbane di 34 metri quadrati di zone interdette al traffico motorizzato ogni 100 abitanti. -

The Work of Elsa Olivieri Sangiacomo Respighi in Fascist Italy
University of Connecticut OpenCommons@UConn Doctoral Dissertations University of Connecticut Graduate School 5-5-2017 A Marriage and its Music: The Work of Elsa Olivieri Sangiacomo Respighi in Fascist Italy Penny R. S. Brandt University of Connecticut - Storrs, [email protected] Follow this and additional works at: https://opencommons.uconn.edu/dissertations Recommended Citation Brandt, Penny R. S., "A Marriage and its Music: The Work of Elsa Olivieri Sangiacomo Respighi in Fascist Italy" (2017). Doctoral Dissertations. 1461. https://opencommons.uconn.edu/dissertations/1461 A Marriage and its Music: The Work of Elsa Olivieri Sangiacomo Respighi in Fascist Italy Penny Rae Sunshine-3 Brandt, PhD University of Connecticut, 2017 Elsa Olivieri Sangiacomo (1894–1996) was an Italian pianist, singer, and composer. She composed several works for voice and piano early in life that were published by Casa Ricordi in Milan, but she ultimately put her creative aspirations aside for the opportunity to become the housewife and assistant of her composition teacher, the celebrated composer Ottorino Respighi (1879–1936). The marriage provided Olivieri with connections and performance opportunities that continued to benefit her during the sixty years she lived as a widow. After Respighi’s death, she returned briefly to composition as a means of catharsis, composing both small and large-scale works—including two completed operas that remain unpublished and unperformed. Olivieri’s unique musical style was, in part, a product of her Mexican heritage and her position as a woman and wife living in fascist Italy. Important style traits in her music include nuanced exoticism, references to folk songs and Gregorian melodies, and complex realizations of female characters. -

Mirabilia Vrbis Romae. the Marvel of Rome, Or a Picture of the Golden City
MIRABILIA FRBIS ROMAE THE MARVELS OF ROME OR A PICTURE OF THE GOLDEN CITY AN ENGLISHVERSION OF THE MEDIEVAL GUIDE-BOOK WITH A SUPPLEMENT OF ILLUSTRATIVE MATTER AND NOTES BY FRANCIS MORGAN NICHOLS LONDON. ELLIS AND ELVEY ROME. SPITHOEVER 1889 PREFACE THE little book of which an Englilh verfion is here publifhed for the firft time was the ftandard guide-book of the more learned vifitors to Rome from the twelfth to the fifteenth century. Its ftatements were received with the refpect due to a work of authority, and their influence may be traced in the writin<Ts of many of the authors who flourifhed during that period. The moft ftriking example of the long-fuftained credit of the medieval Roman Topo- graphy is afforded by the Letters of Petrarch. In the defcriptions of Rome given by this great leader of the Revival of Learning, fcarcely any trace appears of the new critical fpirit, but the locali- ties are ftill prefented under the names, and alTociated with the legends, of the Mirah ilia. a _L v^ «_-' *_y w ^i _ • vi Preface. In the following century, when the wider ftudy of ancient authors and in- fcriptions had impaired its influence among the learned, the Mirabilia ftill maintained its place in popular eflima- tion; and, after the invention of printing, feveral editions of it ilTued from the prefs. In the prefent day this treatife is ufe- ful to the archseologift as fupplying fome fcanty evidence refpe6ling the hiftory of the (ites and buildings of ancient Rome. Under the perplexing veil of an often arbitrary or barbarous nomen- clature it exhibits a fhadowy pi6lure of the ruins which attracted notice in the medieval city, many of which have fmce difappeared, while it narrates with charming fnnplicity the legends with which the principal monuments, and the few works of art which were not buried beneath the furface, were aflb- ciated in the minds of the more educated people of the time.