Note D'archivio
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Keyboard Playing and the Mechanization of Polyphony in Italian Music, Circa 1600
Keyboard Playing and the Mechanization of Polyphony in Italian Music, Circa 1600 By Leon Chisholm A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Music in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Kate van Orden, Co-Chair Professor James Q. Davies, Co-Chair Professor Mary Ann Smart Professor Massimo Mazzotti Summer 2015 Keyboard Playing and the Mechanization of Polyphony in Italian Music, Circa 1600 Copyright 2015 by Leon Chisholm Abstract Keyboard Playing and the Mechanization of Polyphony in Italian Music, Circa 1600 by Leon Chisholm Doctor of Philosophy in Music University of California, Berkeley Professor Kate van Orden, Co-Chair Professor James Q. Davies, Co-Chair Keyboard instruments are ubiquitous in the history of European music. Despite the centrality of keyboards to everyday music making, their influence over the ways in which musicians have conceptualized music and, consequently, the music that they have created has received little attention. This dissertation explores how keyboard playing fits into revolutionary developments in music around 1600 – a period which roughly coincided with the emergence of the keyboard as the multipurpose instrument that has served musicians ever since. During the sixteenth century, keyboard playing became an increasingly common mode of experiencing polyphonic music, challenging the longstanding status of ensemble singing as the paradigmatic vehicle for the art of counterpoint – and ultimately replacing it in the eighteenth century. The competing paradigms differed radically: whereas ensemble singing comprised a group of musicians using their bodies as instruments, keyboard playing involved a lone musician operating a machine with her hands. -

Musica Strumentale E Committenza in Area Bresciana. Titoli E Dediche Delle Canzoni Strumentali Fra Cinque E Seicento
Philomusica on-line 15/1 (2016) Musica strumentale e committenza in area bresciana. Titoli e dediche delle canzoni strumentali fra Cinque e Seicento Marina Toffetti Università degli Studi di Padova [email protected] § Un aspetto rilevante della storia della § An important aspect of the history cultura bresciana è la presenza, nelle of culture in Brescia is the presence, raccolte di musica strumentale, di in the collections of instrumental titoli-dedica sostantivati al femminile music, of feminine title-dedications riferiti a esponenti della nobiltà, referring to members of the nobility, compositori, musicisti e personalità di musicians and personalities the local spicco del clero locale. clergy. In questo articolo sono stati presi in In this article all titles (172) that are considerazione tutti i titoli-dedica (172) in the collections of canzonas che si trovano nelle raccolte di canzoni published in Brescia or composed by pubblicate a Brescia o composte da authors from Brescia were taken into autori bresciani e, laddove possibile, ne consideration and, where possible, sono stati identificati i dedicatari their implicit dedicatees have been impliciti. identified. Il corpus delle canzoni prodotte a The corpus of canzonas produced in Brescia fra il 1582 e il 1626-29 include Brescia between 1582 and 1626-29 otto raccolte individuali di sette includes eight individual collections compositori, per un totale di 147 of seven composers (147 instrumental canzoni strumentali, alle quali dove- canzonas); to these we must add two vano aggiungersi due raccolte che sono collections that went lost. In addition, andate perdute; altre 72 canzoni sono another 72 canzonas were published state pubblicate all’interno di raccolte in collections of vocal sacred or di musica vocale sacra o profana o di secular music, or in collections of composizioni strumentali di genere instrumental compositions of diverso dalla canzone. -

Graduate-Dissertations-21
Ph.D. Dissertations in Musicology University of North Carolina at Chapel Hill Department of Music 1939 – 2021 Table of Contents Dissertations before 1950 1939 1949 Dissertations from 1950 - 1959 1950 1952 1953 1955 1956 1958 1959 Dissertations from 1960 - 1969 1960 1961 1962 1964 1965 1966 1967 1968 1969 Dissertations from 1970 - 1979 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Dissertations from 1980 - 1989 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Dissertations from 1990 - 1999 1990 1991 1992 1994 1995 1996 1998 1999 Dissertations from 2000 - 2009 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 Dissertations since 2010 2010 2013 2014 2015 2016 2018 2019 Dissertations since 2020 2020 2021 1939 Peter Sijer Hansen The Life and Works of Dominico Phinot (ca. 1510-ca. 1555) (under the direction of Glen Haydon) 1949 Willis Cowan Gates The Literature for Unaccompanied Solo Violin (under the direction of Glen Haydon) Gwynn Spencer McPeek The Windsor Manuscript, British Museum, Egerton 3307 (under the direction of Glen Haydon) Wilton Elman Mason The Lute Music of Sylvius Leopold Weiss (under the direction of Glen Haydon) 1950 Delbert Meacham Beswick The Problem of Tonality in Seventeenth-Century Music (under the direction of Glen Haydon) 1952 Allen McCain Garrett The Works of William Billings (under the direction of Glen Haydon) Herbert Stanton Livingston The Italian Overture from A. Scarlatti to Mozart (under the direction of Glen Haydon) 1953 Almonte Charles Howell, Jr. The French Organ Mass in the Sixteenth and Seventeenth Centuries (under the direction of Jan Philip Schinhan) 1955 George E. -

30Th Sunday in Ordinary Time
THE PARISH OF ST. VINCENT FERRER AND T ATHERINE OF IENA S . C S The Very Reverend Walter C. Wagner, O.P., Pastor James D. Wetzel, Director of Music and Organist THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME October 25, 2020 Take this leaflet with you after Mass or return it to the tray from which you took it, after which it will be destroyed. Covid guidelines prevent them from being reused. PRELUDE Johann Sebastian Bach Toccata and Fugue in F Major, BWV 540 (1685-1750) INTRODUCTORY RITES ENTRANCE ANTIPHON (OFFICIUM) Psalm 104 (105):3, 4, 1 Chant, mode ii Laetetur cor quaerentium Dominum: Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. quaerite Dominum, et confirmamini: Seek the Lord, and be strengthened; quaerite faciem ejus semper. seek his face always. V. Confitemini Domino, V. Give praise to the Lord, et invocate nomen ejus: and call upon his name; annuntiate inter gentes opera ejus. declare his works among the nations. SIGN OF THE CROSS AND GREETING PENITENTIAL ACT KYRIE Roman Missal Mass GLORIA Roman Missal Mass 2 COLLECT Almighty ever-living God, increase our faith, hope and charity, and make us love what you command, so that we may merit what you promise. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. LITURGY OF THE WORD FIRST READING Exodus 22:20-26 Thus says the Lord: “You shall not molest or oppress an alien, for you were once aliens yourselves in the land of Egypt. -

The Science and Art of Renaissance Music-Princeton University Press
CHAPTER ONE A Sixteenth-Century Attempt at Music Criticism A COMPLAINT SOMETIMES MADE about theorists, at least about those active be- fore the middle of the nineteenth century, is that their concerns are too exclusively prescriptive, that they rarely describe music, much less evaluate it. As musicians we can enjoy what we take to be timeless aspects of the music of the past, and we feel to a certain extent confident in our ability to distinguish level of quality and de- gree of attractiveness in it—in short to make it live as part of our own musical cul- ture. As scholars we can learn a good deal about the musical life of a period such as the Renaissance. As analysts we can take almost any music apart and reassemble it, using theoretical writings of the appropriate period as manuals wherever they are helpful. But as historians concerned not only with cultural artifacts but also with the intellectual and artistic outlook of the past we want to know not just how music was made but why it took the shapes it did, and especially how it was heard and crit- icized by those who first performed and listened to it. Not how everyone heard it, of course; if we look at the general reception of art music in our own time we can see that random sampling of opinion would not get us far, and there is no reason to sen- timentalize about a past when everyone understood and loved contemporary cul- ture. We do want to know what those critics have to say who are equipped by train- ing and temperament to give sympathetic judgment on modern music; and it is a group of this sort, comparatively large in some periods and very small in others, that we would like to have speak to us from the past. -

Christ the King
THE PARISH OF ST. VINCENT FERRER AND T ATHERINE OF IENA S . C S The Very Reverend Walter C. Wagner, O.P., Pastor James D. Wetzel, Director of Music and Organist SOLEMNITY OF OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE THE LAST SUNDAY BEFORE ADVENT November 22, 2020 The setting of the Mass Ordinary at the 12:00 Noon Mass is Missa In te Domine speravi by Giovanni Francesco Anerio (c. 1567-1630). Take this leaflet with you after Mass or return it to the tray from which you took it, after which it will be destroyed. Covid guidelines prevent them from being reused. PRELUDE César Franck TROIS CHORALS (1822-1890) Choral No. 1 in E Major INTRODUCTORY RITES ENTRANCE ANTIPHON (OFFICIUM) Revelation 5:12, 1:6; Psalm 71:1 Chant, mode iii Dignus est Agnus, qui occisus est, Worthy is the Lamb that was slain accipere virtutem, et divinitatem, to receive power, and divinity, et sapientiam, et fortitudinem, et honorem. and wisdom, and strength, and honor. Ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum. To him be glory and empire for ever and ever. V. Deus judicium tuum regi da: V. O God, with your judgement endow the king, et justitiam tuam filio regis. and with your justice, the king’s son. SIGN OF THE CROSS, GREETING, AND PENITENTIAL ACT KYRIE Roman Missal Mass GLORIA Roman Missal Mass 2 COLLECT Almighty ever-living God, whose will is to restore all things in your beloved Son, the King of the universe, grant, we pray, that the whole creation, set free from slavery, may render your majesty service and ceaselessly proclaim your praise. -

And Elbląg of the Renaissance Era
The Beginnings of Musical Italianità in Gdańsk and Elbląg of the Renaissance Era AGNIESZKA LESZCZYŃSKA University of Warsaw Institute of Musicology The Beginnings of Musical Italianità in Gdańsk and Elbląg of the Renaissance Era Musicology Today • Vol. 10 • 2013 DOI: 10.2478/muso-2014-0001 In the second half of the sixteenth century almost the with the Italian language and culture. A sizeable group of whole of Europe was gradually engulfed by the fashion for settlers from the Apennine Peninsula had lived in Cracow Italian music. The madrigal became the favourite genre, from the beginning of the century, and that community which entered the repertory in different countries both in expanded significantly in 1518, after the arrival in Poland its original version and as contrafactum, intabulation or of Bona Sforza, the newly wedded wife of King Sigismund as the basis for missa parodia1. The madrigal and related I.4 Those brought to Poland by Bona included musicians: genres, such as canzona alla villanesca, also became the Alessandro Pesenti from Verona, who had previously subject of imitations, often composed by musicians who served as organist at the court of Cardinal Ippolito d’Este, had no links to Italy at all. Other genres employed by and who was active at Bona’s Cracovian court during the Italian composers, above all masses and motets, were also years 1521-1550, and Lodovico Pocenin, a cantor from of great interest to musicians throughout the continent. Modena, whose name appears in the records in 15275. It Undoubtedly it was the activity of the numerous is not impossible that Pesenti, as an organist, was in some Italian, mainly Venetian, printing houses which played way and to some degree responsible for the fact that the a decisive role in promoting these works; in terms of two Polish sources of keyboard music created ca 1548 titles produced, they held the leading position in Europe2. -

The Parish of St. Vincent Ferrer and St. Catherine of Siena
THE PARISH OF ST. VINCENT FERRER AND T ATHERINE OF IENA S . C S The Very Reverend Walter C. Wagner, O.P., Pastor James D. Wetzel, Director of Music and Organist TWENTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME August 30, 2020 The 12:00 Noon Mass is preceded by the recitation of the Holy Rosary at 11:40 AM. Take this leaflet with you after Mass or return it to the tray from which you took it, after which it will be destroyed. INTRODUCTORY RITES ENTRANCE ANTIPHON (OFFICIUM) Miserere mihi, Domine Psalm 85 (86):3, 5 Chant, mode viii Have mercy on me, O Lord, for I have cried to you all the day, for you, O Lord, are sweet and mild, and plenteous in mercy to all who call upon you. SIGN OF THE CROSS AND GREETING PENITENTIAL ACT KYRIE AND GLORIA Roman Missal Mass COLLECT God of might, giver of every good gift, put into our hearts the love of your name, so that, by deepening our sense of reverence, you may nurture in us what is good and, by your watchful care, keep safe what you have nurtured. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. LITURGY OF THE WORD FIRST READING Jeremiah 20:7-9 You duped me, O Lord, and I let myself be duped; you were too strong for me, and you triumphed. All the day I am an object of laughter; everyone mocks me. Whenever I speak, I must cry out, violence and outrage is my message; the word of the Lord has brought me derision and reproach all the day. -

Ph.D. Dissertations in Musicology University of North Carolina At
Ph.D. Dissertations in Musicology University of North Carolina at Chapel Hill Department of Music 1939 – 2019 Table of Contents Dissertations before 1950 1939 1949 Dissertations from 1950 - 1959 1950 1952 1953 1955 1956 1958 1959 Dissertations from 1960 - 1969 1960 1961 1962 1964 1965 1966 1967 1968 1969 Dissertations from 1970 - 1979 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Dissertations from 1980 - 1989 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Dissertations from 1990 - 1999 1990 1991 1992 1994 1995 1996 1998 1999 Dissertations from 2000 - 2009 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 Dissertations since 2010 2010 2013 2014 2015 2016 2018 1939 Peter Sijer Hansen The Life and Works of Dominico Phinot (ca. 1510-ca. 1555) (under the direction of Glen Haydon) 1949 Willis Cowan Gates The Literature for Unaccompanied Solo Violin (under the direction of Glen Haydon) Gwynn Spencer McPeek The Windsor Manuscript, British Museum, Egerton 3307 (under the direction of Glen Haydon) Wilton Elman Mason The Lute Music of Sylvius Leopold Weiss (under the direction of Glen Haydon) 1950 Delbert Meacham Beswick The Problem of Tonality in Seventeenth-Century Music (under the direction of Glen Haydon) 1952 Allen McCain Garrett The Works of William Billings (under the direction of Glen Haydon) Herbert Stanton Livingston The Italian Overture from A. Scarlatti to Mozart (under the direction of Glen Haydon) 1953 Almonte Charles Howell, Jr. The French Organ Mass in the Sixteenth and Seventeenth Centuries (under the direction of Jan Philip Schinhan) 1955 George E. Muns, Jr. Climax in Music (under the direction of William S. -

A Study of Monteverdi's Three Genera from the Preface to Book Viii of Madrigals in Relation to Operatic Characters in Il
A STUDY OF MONTEVERDI’S THREE GENERA FROM THE PREFACE TO BOOK VIII OF MADRIGALS IN RELATION TO OPERATIC CHARACTERS IN IL RITORNO D’ULISSE IN PATRIA AND L’INCORONAZIONE DI POPPEA _______________________________________ A Thesis presented to the Faculty of the Graduate School at the University of Missouri-Columbia _______________________________________________________ In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts _____________________________________________________ by JÚLIA COELHO Dr. Judith Mabary, Thesis Advisor JULY 2018 © Copyright by Júlia Coelho 2018 All Rights Reserved The undersigned, appointed by the Dean of the Graduate School, have examined the thesis entitled A STUDY OF MONTEVERDI’S THREE GENERA FROM THE PREFACE TO BOOK VIII IN RELATION TO OPERATIC CHARACTERS IN IL RITORNO D’ULISSE IN PATRIA AND L’INCORONAZIONE DI POPPEA presented by Júlia Coelho, a candidate for the degree of Master of Arts, and hereby certify that, in their opinion, it is worthy of acceptance. ________________________________________ Professor Judith Mabary ________________________________________ Professor Michael J. Budds ________________________________________ Professor William Bondeson ________________________________________ Professor Jeffrey Kurtzman ACKNOWLEDGEMENTS Over the last years, I have been immensely fortunate to meet people who have helped me tremendously—and still do—in building my identity as an aspiring scholar / performer in the Early Music field. The journey of researching on Claudio Monteverdi that culminated in this final thesis was a long process that involved the extreme scrutiny, patience, attentive feedback, and endless hours of revisions from some of these people. To them, I am infinitely grateful for the time they dedicated to this project. I want to ex- press first my deep gratitude to my professors and mentors, Dr. -
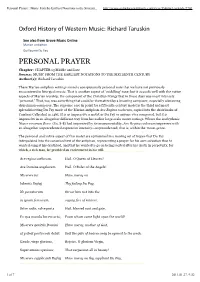
Josquin Des Prez in Fact and Legend
Personal Prayer : Music from the Earliest Notations to the Sixteent... http://www.oxfordwesternmusic.com/view/Volume1/actrade-9780... Oxford History of Western Music: Richard Taruskin See also from Grove Music Online Marian antiphon Guillaume Du Fay PERSONAL PRAYER Chapter: CHAPTER 13 Middle and Low Source: MUSIC FROM THE EARLIEST NOTATIONS TO THE SIXTEENTH CENTURY Author(s): Richard Taruskin These Marian antiphon settings sound a conspicuously personal note that we have not previously encountered in liturgical music. That is another aspect of “middling” tone; but it accords well with the votive aspects of Marian worship, the component of the Christian liturgy that in those days was most intensely “personal.” That, too, was something that could be thematized by a knowing composer, especially a knowing churchman-composer. The supreme case in point for a fifteenth-century motet is the third and most splendid setting Du Fay made of the Marian antiphon Ave Regina coelorum, copied into the choirbooks of Cambrai Cathedral in 1465. It is as impressive a motet as Du Fay or anyone ever composed, but it is impressive in an altogether different way from his earlier large-scale motet settings. Where the isorhythmic Nuper rosarum flores (Ex. 8-8) had impressed by its monumentality, Ave Regina coelorum impresses with an altogether unprecedented expressive intensity—unprecedented, that is, within the motet genre. The personal and votive aspect of this motet are epitomized in a moving set of tropes that Du Fay interpolated into the canonical text of the antiphon, representing a prayer for his own salvation that he wanted sung at his deathbed, and that he wanted to go on being recited after his death in perpetuity, for which, a rich man, he provided an endowment in his will: Ave regina coelorum, Hail, O Queen of Heaven! Ave Domina angelorum, Hail, O Ruler of the Angels! Miserere tui Have mercy on labentis Dufaÿ Thy failing Du Fay, Ne peccatorum throw him not into the in ignem fervorum. -

Cultura Musicale Bresciana Reperti E Testimonianze Di Una Civiltà
ANNALI DI STORIA BRESCIANA 5 Cultura musicale bresciana Reperti e testimonianze di una civiltà a cura di Maria Teresa Rosa Barezzani e Mariella Sala Ateneo di Brescia Accademia di Scienze Lettere ed Arti -0 Pagine di guardia.indd 3 03/01/18 12:19 © 2017 Editrice Morcelliana Via Gabriele Rosa 71 - 25121 Brescia Prima edizione: dicembre 2017 Redazione a cura di Enrico Valseriati Indice dei nomi a cura di Marcello Mazzetti e Livio Ticli Crediti fotografici: Bologna, Biblioteca Universitaria Brescia, Biblioteca Civica Queriniana Brescia, Musei Civici di Arte e Storia Brescia, Museo Diocesano Brescia, Pinacoteca Tosio-Martinengo Cremona, Biblioteca del Seminario Vescovile Londra, British Library Londra, British Museum Oxford, Bodleian Library Tolosa, Musée Paul-Dupuy Tunisi, Museo del Bardo Gli Annali di storia bresciana, promossi dall’Ateneo di Brescia, sono realizzati con il contributo della UBI Fondazione CAB www.morcelliana.com I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm), sono riservati per tutti i Paesi. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione