Ursula Jaitner-Hahner
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Cult of Saint Jerome in Dalmatia in The
Ines Ivić THE CULT OF SAINT JEROME IN DALMATIA IN THE FIFTEENTH AND THE SIXTEENTH CENTURIES MA Thesis in Medieval Studies Central European University CEU eTD Collection Budapest May 2016 THE CULT OF SAINT JEROME IN DALMATIA IN THE FIFTEENTH AND THE SIXTEENTH CENTURIES by Ines Ivić (Croatia) Thesis submitted to the Department of Medieval Studies, Central European University, Budapest, in partial fulfillment of the requirements of the Master of Arts degree in Medieval Studies. Accepted in conformance with the standards of the CEU. ____________________________________________ Chair, Examination Committee ____________________________________________ Thesis Supervisor ____________________________________________ Examiner CEU eTD Collection ____________________________________________ Examiner Budapest May 2016 THE CULT OF SAINT JEROME IN DALMATIA IN THE FIFTEENTH AND THE SIXTEENTH CENTURIES by Ines Ivić (Croatia) Thesis submitted to the Department of Medieval Studies, Central European University, Budapest, in partial fulfillment of the requirements of the Master of Arts degree in Medieval Studies. Accepted in conformance with the standards of the CEU. ____________________________________________ External Reader CEU eTD Collection Budapest May 2016 THE CULT OF SAINT JEROME IN DALMATIA IN THE FIFTEENTH AND THE SIXTEENTH CENTURIES by Ines Ivić (Croatia) Thesis submitted to the Department of Medieval Studies, Central European University, Budapest, in partial fulfillment of the requirements of the Master of Arts degree in Medieval Studies. Accepted in conformance with the standards of the CEU. ____________________________________________ External Supervisor CEU eTD Collection Budapest May 2016 I, the undersigned, Ines Ivić, candidate for the MA degree in Medieval Studies, declare herewith that the present thesis is exclusively my own work, based on my research and only such external information as properly credited in notes and bibliography. -

Thomas Haye: Giovanni Manzini Della Motta (Ca
Thomas Haye: Giovanni Manzini della Motta (ca. 1362–vor 1422). Metamorphosen spätmittelalterlich-humanistischer Geschichtsschreibung (mit Edition) Zeitschrift Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken Band 95 (2015) Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. Thomas Haye Giovanni Manzini della Motta (ca. 1362–vor 1422) Metamorphosen spätmittelalterlich-humanistischer Geschichtsschreibung (mit Edition) 1. Der Autor 3. Manzinis Chronik: Inhalt und 2 Die Handschrift Vatikanstadt, BAV, Zeitrahmen Vat. Lat. 14162 4. Texttyp und Zielsetzung Riassunto: Giovanni Manzini della Motta (ca. 1362–prima del 1422) è considerato oggi un importante rappresentante del primo umanesimo italiano. Tale giudizio si basa su tre considerazioni: in primo luogo nutriva una profonda venerazione per Petrarca, in secondo luogo era in contatto con famosi studiosi come Antonio Loschi e Coluccio Salutati, e infine compose una tragedia seguendo i modelli antichi. La sua attività di storiografo, invece, è a tutt’oggi poco indagata. Un codice della Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV, Vat. Lat. 14162), sostanzialmente autografo, permette di seguire l’evo- luzione di Manzini da segretario ad autore di esposizioni storiografiche e di tracciare la sua idea di storiografia tragica, influenzata non ultimo da Boccaccio. -

Million on Bornstein and Gaffuri and Maxson, 'Languages of Power in Italy (1300-1600)'
H-Italy Million on Bornstein and Gaffuri and Maxson, 'Languages of Power in Italy (1300-1600)' Review published on Thursday, January 30, 2020 Daniel Bornstein, Laura Gaffuri, Brian Jeffrey Maxson, eds. Languages of Power in Italy (1300-1600). Early European Research Series. Turnhout: Brepols Publishers, 2017. 245 pp. $94.00 (cloth), ISBN 978-2-503-54038-2. Reviewed by Tucker Million (University of Rochester)Published on H-Italy (January, 2020) Commissioned by Peter Sposato (Indiana University Kokomo) Printable Version: http://www.h-net.org/reviews/showpdf.php?id=54557 Originally gathered at the 2010 Renaissance Society of America conference in Venice, Italy, the contributors to Languages of Power in Italy (1300-1600) have created an excellent introduction to the myriad ways northern Italians acquired and maintained social, political, religious, and economic power during the Renaissance. With fifteen chapters divided into three parts and covering only 243 pages, bibliographies included, this collection will prove a concise but useful text for early modern Italianists interested in the premodern state and/or the exercise (but not experience) of power. The chapters all have strong and clear arguments, which are reinforced by lucid prose, surely testaments to the effective editorship of Daniel Bornstein, Laura Gaffuri, and Brian Jeffrey Maxson. Due to the wide temporal and topical approach of the authors, this volume will prove useful to experts in the field and graduate students alike for many years to come. “Words of Power,” the first part of the volume, opens with Blythe Alice Raviola who demonstrates the importance of maps in the development of Italian states. -
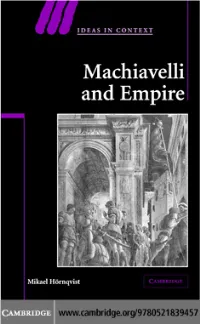
On the Use of Machiavelli's Texts
This page intentionally left blank MACHIAVELLI AND EMPIRE Mikael Hornqvist¨ challenges us to rethink the overall meaning and importance of Machiavelli’s political thinking. Machiavelli and Empire combines close textual analysis of The Prince and The Discourses with a broad historical approach, to establish the importance of empire- building and imperial strategy in Machiavelli’s thought. The primary context of Machiavelli’s work, Hornqvist¨ argues, is not the mirror-for- princes genre or medieval and Renaissance republicanism in general, but a tradition of Florentine imperialist republicanism dating back to the late thirteenth century, based on the twin notions of liberty at home and empire abroad. Weaving together themes and topics drawn from contemporary Florentine political debate, Medicean ritual, and Renaissance triumphalism, this study explores how Machiavelli in his chancery writings and theoretical works promoted the longstand- ing aspirations of Florence to become a great and expanding empire, modeled on the example of the ancient Roman republic. Original and thought-provoking, this book makes a major contribution to our understanding of the Renaissance, and of the history of European ideas. mikael hornqvist¨ teaches at the Department of the History of Science and Ideas at Uppsala University in Sweden. ideas in context 71 Machiavelli and Empire ideas in context Edited by Quentin Skinner (General Editor) Lorraine Daston, Dorothy Ross and James Tully The books in this series will discuss the emergence of intellectual traditions and of related new disciplines. The procedures, aims and vocabularies that were generated will be set in the context of the alternatives available within the contemporary frameworks of ideas and institutions. -

Dominican History Newsletter 1
ASSOCIATION POUR L'J·JISTOIRE DE L'ORDRE DE SAINT DOMINIOUE E FRANCE ET E EUROPE DOMINICAN HISTORY NEWSLETTER BULLETIN D'HISTOIRE DOMINICAINE BOLLETTINO DI STORIA DOMENICANA A. REPERTORIUM PERITORUM ET NOTITIAE DIVERSAE I 1992 apud CE TRUM HISTORICUM DOMINICA UM OXONII 1992 ABBREVIA TURAE Ad perspicuitatem bibliographiarum servandam abbreviaturas quam maxime vitandas censuit redactor. His tamen uti quae sequuntur visum est, ne eadem saepius piene citata paginam inutiliter gravent: AFP Archivum Fratrum Praedicatorum AGOP Archivum Generale OP (Convento di S.Sabina, Piazza P. d'Il liria 1, 00153 Roma, Italia) ASOP Analecta Sacri Ordinis Fratrum Praedicatorum BG Bibliographia generalis in hoc fasciculo edita CP R.Coulon & A.Papillon OP, Scriptores Ordinis Praedicatorum 1701-1750 (Paris in pluribus fasciculis 1910-1934, denuo in duobus voluminibus apud Bibl. SJ, Leuven 1961 ). Diss. Tabula dissertationum in altero fasciculo edita Documents Documents pour servir à l'Histoire de l'Ordre de Saint-Domi nique en France K Thomas Kaeppeli OP, Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi (S.Sabina, Roma 1970-) [tria volumina iam edita sunt, quartum expectatur curante Emilio Panella OP]. MOPH Monumenta Ordinis Praedicatorum Historica QE J.Quétif & J.Échard OP, Scriptores Ordinis Praedicatorwn (Paris 1719-1721) 2 voli. RP Repertorium peritorum in altero fasciculo editum In omnibus bibliographiis scripta recentius edita (I 987-1992) asterisco (*) notantur. 2 INTRODUCTION .. PRÉSENTATION * PRESENTAZIONE Welcome to our Newsletter. You will see that it comes in two sections. In the first section I provide a repertory of those who have said that they are willing to be listed as having some kind of expertise in Dominican history, with their addresses, interests, projects and relevant publications. -

Una Delle Questioni Fondamentali Che Attraversano Il Nome Della Rosa È Il Dibattito Sulla “Liceità Del Riso”. I Monaci
ARTICLES / SAGGI RICERCHE ICONOGRAFICHE TRA AGIOGRAFIA E DEVOZIONE POPOLARE: IL “MIRACOLO DEL PANE DI SANT’ONOFRIO BAMBINO” LUIGI ROBUSCHI (University of the Witwatersrand) Abstract The iconographic analysis of a recently discovered painting, representing a variation in the traditional hagiography of St. Onuphrius, offers the chance for a historical and artistic excursus into the society and the religious life of the XVI century. This article focuses on the existence of devotional practices which were so widespread and influential that even the most authoritative hagiographic publications had to take them into account. What emerges in particular is the role played by the Congregation of Hermits of St. Jerome which organized an efficient and well-planned devotional strategy during the XVI century in order to associate St. Onuphrius with their founder, Blessed Pietro Gambacorta from Pisa. Keywords: Iconography – Baroque – Catholic Devotion La recente scoperta in area lombarda di un olio su tavola del secolo XVII (Figura 1), riproducente un’iconografia piuttosto inusuale, ha suggerito uno studio approfondito del documento pittorico in 1 questione. Partendo da un’analisi stilistica, il dipinto rimanda all’ambito di Luigi Miradori1. Figura 1: Miracolo del pane di sant’Onofrio bambino, olio su tavola, collezione privata 1 Biffi, G., Memorie per servire alla storia degli artisti cremonesi (sec. XVIII), ed. critica a cura di Bandera Gregori, L., Cremona, Annali della Biblioteca Statale e Libreria di Cremona, 1989:262-270; Panni, A.M., Notizie Istoriche de’ pittori, scultori ed architetti cremonesi opera postuma di Giambattista Zaist, pittore ed architetto cremonese, II, Cremona, nella stamperia di Pietro Ricchini, 1774:98-101; Farquhar, M., Biographical Catalogue of the principal Italian Painters […], a cura di Wornum, R.N., London, Woodfall & Kinder:106; Bellingeri, L., Genovesino, Lecce, Galatina, 2007. -

Law and War in Late Medieval Italy: the Jus Commune on War and Its Application in Florence, C
Law and War in Late Medieval Italy: the Jus Commune on War and its Application in Florence, c. 1150-1450 by Ryan Martin Greenwood A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Centre for Medieval Studies University of Toronto © Copyright by Ryan Martin Greenwood (2011) Law and War in Late Medieval Italy: the Jus Commune on War and its Application in Florence, c. 1150-1450 Ryan Martin Greenwood Doctor of Philosophy Centre for Medieval Studies University of Toronto 2011 Abstract This study, on law and war in late medieval Italy, has two primary aims. One is to review the legal tradition on war as it developed in the medieval jus commune, or common law, from approximately 1150-1300, and then to consider how that tradition evolved from roughly 1300-1450. In general the latter period still represents a lacuna in scholarship on the legal theory of war, and can be addressed as a distinct period because the fourteenth century was a time when theory moved in important new directions. It will be suggested in turn that those new directions were related to changing politics and institutions in Italy. The second aim continues and reflects the first, as it seeks to better understand how legal arguments about war and peace were employed in practice, using Florence as an example. The study finds that these legal arguments found their most important role in diplomacy. Florentine diplomatic records, as well as legal opinions (or consilia) on inter-city disputes, will help to examine the complex nature of that role. -

In Italy (1300–1600)
LANGUAGES OF POWER IN ITALY (1300–1600) EARLY EUROPEAN RESEARCH Series founded by the Australian Research Council Network for Early European Research, and now directed by The University of Western Australia Centre for Medieval and Early Modern Studies. General Editors Andrew Lynch, University of Western Australia Claire McIlroy, University of Western Australia Editorial Board Tracy Adams, University of Auckland Emilia Jamroziak, University of Leeds Matthias Meyer, Universität Wien Fabrizio Ricciardelli, Kent State University Florence Center Juanita Feros Ruys, University of Sydney Jón Viðar Sigurðsson, Universitetet i Oslo Nicholas Terpstra, University of Toronto Previously published volumes in this series are listed at the back of the book Volume 10 © BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER. LANGUAGES OF POWER IN ITALY (1300–1600) Edited by Daniel Bornstein, Laura Gaffuri, and Brian Jeffrey Maxson British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library. © 2017, Brepols Publishers n.v., Turnhout, Belgium All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of the publisher. D/2017/0095/39 ISBN: 978-2-503-54038-2 e-ISBN: 978-2-503-54324-6 DOI: 10.1484/M.EER-EB.5.112775 Printed on acid-free paper © BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER. -

La Beata Chiara Conduttrice»
Zitierhinweis Nirit Ben-Aryeh Debby: Rezension von: Sylvie Duval: «La beata Chiara conduttrice». Le vite di Chiara Gambacorta e Maria Mancini e i testi dellOsservanza domenicana pisana, Rom: Edizioni di Storia e Letteratura 2016, in sehepunkte 18 (2018), Nr. 3 [15.03.2018], URL:http://www.sehepunkte.de/2018/03/30875.html First published: http://www.sehepunkte.de/2018/03/30875.html copyright Dieser Beitrag kann vom Nutzer zu eigenen nicht-kommerziellen Zwecken heruntergeladen und/oder ausgedruckt werden. Darüber hinaus gehende Nutzungen sind ohne weitere Genehmigung der Rechteinhaber nur im Rahmen der gesetzlichen Schrankenbestimmungen (§§ 44a-63a UrhG) zulässig. sehepunkte 18 (2018), Nr. 3 Sylvie Duval: «La beata Chiara conduttrice» Sylvie Duval's book offers a critical edition of three important texts associated with the Dominican Observant Reform Movement and the San Domenico Convent in Pisa: the Necrologio of the San Domenico Convent; the Vita of the blessed Chiara Gambacorta, the celebrated abbess of the convent; and the Vita of another Dominican nun from San Domenico and its third abbess, Maria Mancini. The edition appears in the prestigious series "Scritture nel chiostro" edited by the celebrated Florentine historian of female saints and spirituality Gabriella Zarri from the University of Florence. The book, which was developed from a PhD dissertation, is a very fine example of a philological and paleographical approach to medieval sources. Chiara Gambacorta is venerated as a beata by the Catholic Church, as a local saint by Pisans, and as a key figure in the history of the Dominican Order's Observant Movement. Born in 1362, she was the daughter of Pietro Gambacorta, who became the ruler of Pisa shortly after her birth. -

Washington, DC 22–24 March 2012 Leonardo Da Vinci, Ginevra De’ Benci, Ca
The Renaissance Society of America Annual Meeting Program and Abstract Book Washington, DC 22–24 March 2012 Leonardo da Vinci, Ginevra de’ Benci, ca. 1474/78. Alisa Mellon Bruce Fund. Image courtesy of the National Gallery of Art, Washington. Contents The indexes in this book refer to five-digit panel numbers, not page numbers. Panels on Thursday have panel numbers that begin with the number 1; panels on Friday begin with the number 2; and pan- els on Saturday begin with the number 3. The black tabs on each page of the full program are an additional navigational aid: they pro- vide the date and time of the panels. RSA Executive Board.......................................................................5 Acknowledgments.............................................................................6 Book Exhibition and Registration ...................................................10 Business Meetings...........................................................................11 Plenaries, Awards, and Special Events.............................................12 Program Summary Thursday.................................................................................16 Friday.....................................................................................25 Saturday..................................................................................32 Full program with abstracts Thursday 8:30–10:00.......................................................................41 10:15–11:45.....................................................................74 -

Bollettino Storico Pisano
Anno III - N. 1 1934-XII Periodico Quadrimestrale C. C. Postale BOLLETTINO STORICO PISANO PISA TIPOGRAFIA EDITRICE U. GIARDINI Comitato di Redazione MANCINI Prof. AUGUSTO della R. Università di Pisa MANGHI Mons. Prof. ARISTO PICOTTI Prof. G. B. della R. Università di Pisa MASS ART Prof. EUGENIO della R. Università di Pisa, Segretario SOMMARIO: Articoli. P. L. Consor tini. - Le mura di Volterra . Pag. 7 A . S a v e 11 i. - Due rapporti politici del Provvedie tore dell' /. e R. Università di Pisa, (16 agosto e 10 settembre 1841} al 1 Soprintendente degli studi del Granducato '..................................................... 29 Fonti, Documenti, Indici. E. Schiaffino. - Elenco dei Dottorati di stranieri e di non toscani nell’ Università di Pisa . „ 49 Varietà. M . Luzzatto. - 'Notizie di storia Pisana in docu» menti pratesi................................................................ », 59 Notiziario bibliografico................................................„ 63 Per il Centenario della nascita di Antonio Pacino Iti . „ 69 Necrologie......................................................................... ,, 71 Riassunto degli articoli e delle note . „ 75 Direzione e Amminiitraxione, Via Roma, 19, P. I LE MURA DI VOLTERRA È ormai pacifico che le nostre vetustissime città nei secoli precedenti il VI a. C. non erano difese da cinte murali in pietra, ma solo dall'asprezza delle rocce native o da terrapieni od aggeri rafforzati da opere in legname (’). Così Volterra: ma le prime sue mura non sono tanto tarde, quanto da taluno si afferma (21 ). Quando tutta la gran cerchia mu rale abbia avuto inizio e compimento, è vano ricercare nelle fonti letterarie, che sono tutte relativamente tarde. Sembra che alluda alla loro esistenza lo Pseudo-Aristotile (De mir. ause., 94) che la dice città singolarmente difesa e potente, la (1) Gustav Horte, Gli Etruschi, Trad. -

Prolegomena to the New Edition of Francesco Da Buti's Commentary On
Prolegomena to the new edition of Francesco da Buti’s commentary on Dante’s Commedia. Purgatorio Article Accepted Version Tardelli, C. (2019) Prolegomena to the new edition of Francesco da Buti’s commentary on Dante’s Commedia. Purgatorio. Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarship (14). pp. 95-116. ISSN 1573-3084 (Unpublished) Available at http://centaur.reading.ac.uk/79241/ It is advisable to refer to the publisher’s version if you intend to cite from the work. See Guidance on citing . Published version at: https://journals.openedition.org/variants/964 Publisher: Rodopi All outputs in CentAUR are protected by Intellectual Property Rights law, including copyright law. Copyright and IPR is retained by the creators or other copyright holders. Terms and conditions for use of this material are defined in the End User Agreement . www.reading.ac.uk/centaur CentAUR Central Archive at the University of Reading Reading’s research outputs online CLAUDIA TARDELLI TERRY (University of Cambridge) Prolegomena to the new edition of Francesco da Buti’s Commentary on Dante’s Commedia. Purgatorio1 “Gegen die Kontamination ist kein Kraut gewachsen” (Maas 19573, 34) MANUSCRIPTS2 Commedia N NAPLES, Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III”, XIII C 1; parch.; XV (first two decades); cc. IV + 313 + III’; mm. 365 x 260 B FLORENCE, Biblioteca Medicea Laurenziana, Conventi Soppressi 204 (olim Badia Fiorentina L– IX); parch.; XIV ex./XV in. (1405 f. 265ra); cc. IV + 281 + III’; mm. 398 x 277 M FLORENCE, Biblioteca Nazionale Centrale, Banco Rari 39 (olim Fondo nazionale II I 29; Magl. VII 1232); parch.; XV in.; cc.