Assemblea Generale Ordinaria Dei Partecipanti
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
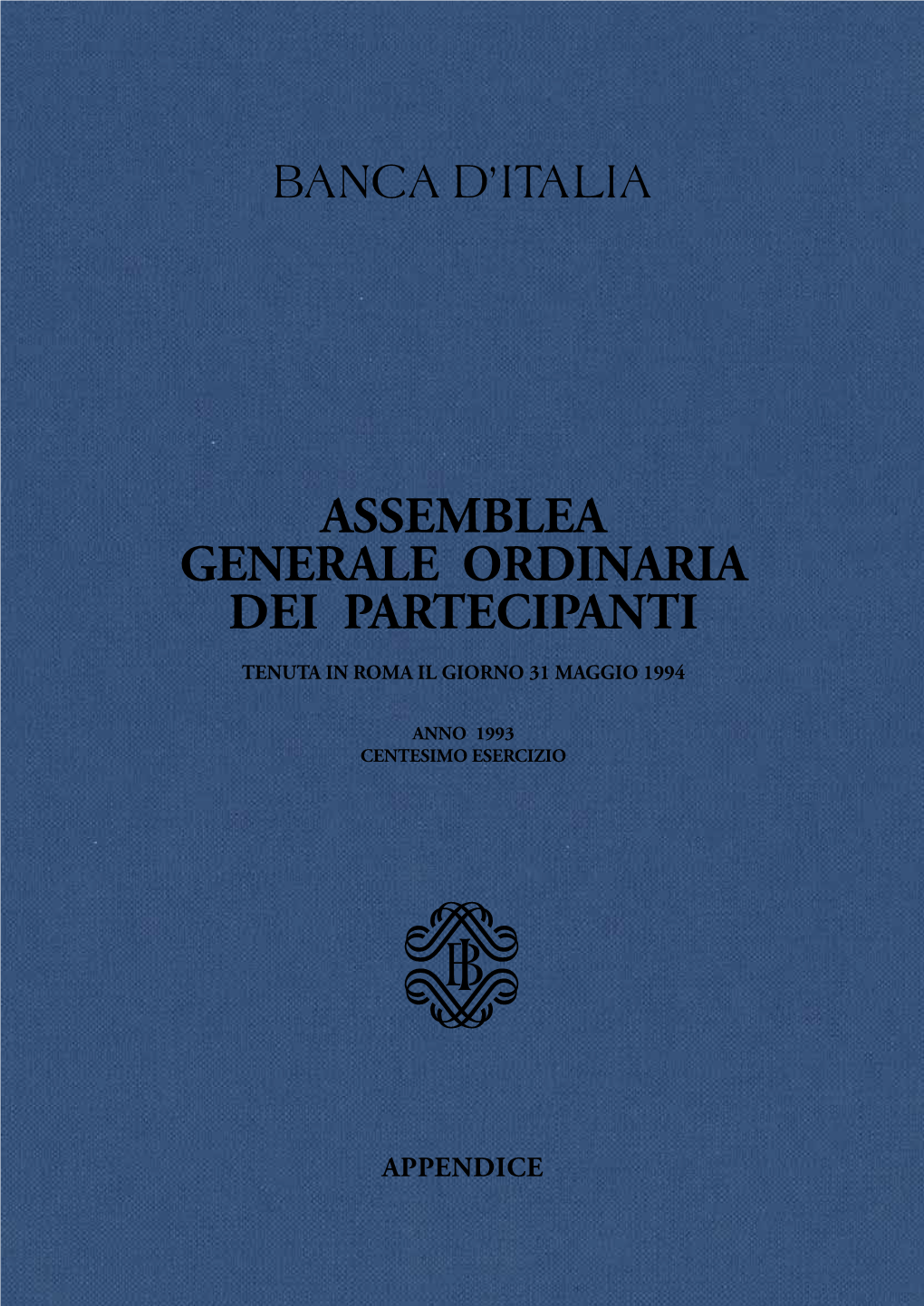
Load more
Recommended publications
-

8883 Banca Di Bologna Credito Cooperativo Scrl 2027373 2028149 3007 Abbey National Plc 652569 653652 3003 Abn Amro Bank N.V
8883 BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVO SCRL 2027373 2028149 3007 ABBEY NATIONAL PLC 652569 653652 3003 ABN AMRO BANK N.V. - MILANO 652128 652272 3005 AMERICAN EXPRESS BANK LTD 652272 652496 3004 AMERICAN SERVICE BANK 0 0 7600 AMMINISTRAZIONE POSTALE 0 0 3006 ARAB BANK - ROMA 652496 652569 3561 ARAB BANKING CORPORATION - MILANO 934479 934532 3027 AREA BANCA S.P.A. 656200 656281 10 ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA 0 69 8640 B.C.C. DEI CASTELLI DI MAZZARI NO E BUTERA S.C.R.L." 1985046 1985204 8989 B.C.C. SS. IMMACOLATA DI BELPASSO 2050596 2050959 8191 B.C.C. DEL MOLISE - SAN MARTINO IN PENSILIS E BAGNOLI DEL TRIGNO 1896990 1897140 8985 B.C.C. DEL NISSENO DI SOMMATINO E SERRADIFALCO S.C.R.L. 2049085 2049325 8633 B.C.C. DELLA MONTAGNA PISTOIESE - MARESCA - S.C.R.L. 1982832 1983090 7018 B.C.C. DI BONIFATI, CITTADELLA DEL CAPO E TORREVECCHIA S.C.R.L. 1865179 1865265 8473 B.C.C. DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. 1952431 1952905 8587 B.C.C. DI GRESSAN E SAINT CHRIST OPHE S.C.P.A.R.L. 1974073 1974365 8662 B.C.C. DI MONTECORVINO ROVELLA S.C.R.L. 1987561 1987760 8962 B.C.C. DI MONTEMAGGIORE BELSITO 2044128 2044246 8765 B.C.C. DI RECANATI E COLMURANO - RECANATI (MC) SCRL 2006955 2007426 8309 B.C.C. DI ROMANO D'EZZELINO E S. CATERINA DI LUSIANA SCRL 1911842 1912310 8965 B.C.C. S. BIAGIO DI CESAROLO E FOSSALTA DI PORTOGRUARO SCRL 2044341 2044911 3481 B.R.E.D. -

Accordo Usi-Upa 13-01-2001
VERBALE DI ACCORDO Il giorno 13 Gennaio 2001, in Milano, UniCredito Italiano S.p.A., nelle persone dei Sigg. Matteo Montagna e Gianluigi Robaldo, ed i Sigg. Alessandro Rasino, Silvio Lops (Banca CRT S.p.A.) il Sig. Emilio Sorio (Cariverona Banca S.p.A.) il Sig. Paolo Curione (Cassamarca S.p.A.) il Sig. Claudio Zanfabro (CRTrieste Banca S.p.A.) il Sig. Massimo Giovannelli (Rolo Banca 1473 S.p.A.) il Sig. Carlo Del Vecchio (Upa) il Sig. Massimo Schiattarella (Usi) e la Delegazione Sindacale di Gruppo FABI, FALCRI, FEDERDIRIGENTICREDITO, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB e UIL C.A., nelle persone dei Sigg.: Giancarla Zemiti, Pietro Mosca, Maurizio Mattioli, Silvano Terelle, Luciano Piccoli, Angelo Di Cristo, Leopoldo Segat, Gianfranco Sartori (FABI); Francesca Furfaro, Sivio Asto, Mauro Savant, Giovanni Antolini, Flavia Ranghetti, Giuseppe Nicoli, Bruno Cavicchioli (FALCRI); Antonio Capuano, Maurizio Beccari, Fabrizio Bernardini, Filadelfo Neri, Carlo Valeriani, Claudio Gallini, Giulio Buonvino (FEDERDIRIGENTICREDITO); Mario Mocci, Giorgio Branduardi, Eugenio Lera, Cosimo Camilleri, Ezio Massoglio, Antonio Rigon, Gilberto Crociani, Franco Villanova, Mario Marchione (FIBA/Cisl); Ezio Dardanelli, Piero Tarantino, Roberto Ballini, Davide Pignat, Antonio Rizzuto, Doriano Civardi, Gaetana Sicolo, Perantonio Framba, Dario Benendo (FISAC/Cgil); Antonio Raccuglia, Diego Fasoli, Roberto Della Rocca (SINFUB); Marco Gaudiomonti, Sergio Uliano, Ado Dalla Villa, Michele Iantomasi, Giuseppe Miraglia, Attilio Scolari, Eliseo Tassan, Tiziano Tugnoli (UIL C.A.); premesso che § da parte aziendale si è deciso di procedere al trasferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ.: § dei rami di azienda relativi alle lavorazioni accentrate di back office da parte della Capogruppo UniCredito Italiano S.p.A., di Banca CRT S.p.A. -
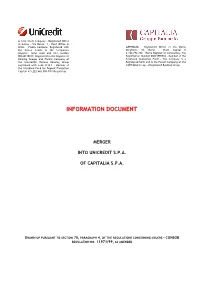
Information Document (Documento Informativo) Relating to the Merger Pursuant to Art
A Joint Stock Company - Registered Office in Genoa - Via Dante, 1 - Head Office in Milan – Piazza Cordusio; Registered with CAPITALIA - Registered Office in Via Marco the Genoa Courts in the Companies Minghetti, 17, Rome – Share Capital € Register, fiscal code and VAT number 3,123,792,732 – Rome Register of Companies, Tax 00348170101; Registered in the Register of Registration Number 00644990582 – Member of the Banking Groups and Parent Company of Interbank Guarantee Fund – The Company is a the UniCredito Italiano Banking Group Registered Bank and is the Parent Company of the registered with code 3135.1 - Member of CAPITALIA Group, a Registered Banking Group the Interbank Fund for Deposit Protection Capital: € 5,222,465,096.50 fully paid up. IINNFFOORRMMAATTIIOONN DDOOCCUUMMEENNTT MERGER INTO UNICREDIT S.P.A. OF CAPITALIA S.P.A. DRAWN UP PURSUANT TO SECTION 70, PARAGRAPH 4, OF THE REGULATIONS CONCERNING ISSUERS - CONSOB REGULATION NO. 11971/99, AS AMENDED This is an English translation of the original Italian document. This translation has been prepared solely for the convenience of the reader. The original version in Italian takes precedence. - 2 - NOTICE OF CALL OF A SHAREHOLDERS’ MEETING PUBBLISHED ON GAZZETTA UFFICIALE – II part - n. 64 DATED JUNE 5, 2007 UNICREDITO ITALIANO A Joint Stock Company Registered in the Register of Banking Groups and Parent Company of the UniCredito Italiano Banking Group registered with code 3135.1 Member of the Interbank for Deposit Protection Fund Registered Office in Genoa - Via Dante, 1 Head Office in Milan – Piazza Cordusio Capital: € 5,222,465,096.50 fully paid up Registered with the Genoa Courts in the Companies Register fiscal code and VAT number 00348170101 NOTICE OF CALL The Shareholders of UniCredito Italiano are hereby convened to an Ordinary and Extraordinary Shareholders’ Meeting to be held in Genoa, Via Dante 1, on 28th July 2007 at 9:00 am, and, if necessary, with regard to the extraordinary session, in second call, on 29th July 2007 at 18:30 pm in the same location. -

Unicredito Italiano Bank (Ireland) P.L.C
INFORMATION MEMORANDUM UniCredito Italiano Bank (Ireland) p.l.c. (incorporated with limited liability in Ireland under registered number 240551) UNLIMITED CERTIFICATE OF DEPOSIT PROGRAMME Guaranteed by UniCredito Italiano S.p.A. (incorporated with limited liability in the Republic of Italy) Dealer UniCredito Italiano Bank (Ireland) p.l.c. Issuing and Paying Agent JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch The date of this Information Memorandum is 22nd August, 2005. TABLE OF CONTENTS Page 1. Summary of the Programme ..........................................................................................3 2. Details of the Issuer .......................................................................................................7 3. Details of the Guarantor...............................................................................................11 4. Form of the Notes ........................................................................................................20 5. Selling Restrictions......................................................................................................28 6. General Information.....................................................................................................31 7. Directory ......................................................................................................................32 Important Notice UniCredito Italiano Bank (Ireland) p.l.c. (the “Issuer”) has established a Certificate of Deposit Programme (the “Programme”) under which short term debt obligations -

Unicredito Italiano
Commitment andsharedvalues UNICREDITO ITALIANO - CREDITO ITALIANO SOCIAL AND ENVIRONMENTAL REPORT 2000 UniCredito Italiano – Italian Stock Company – Registered Office: Genoa, Via Dante, 1 – General Management: Milan, Piazza Cordusio Capital: Lit. 2,512,102,903,000 Fully Paid In – Bank Entered in the Register of Banks and Parent Company of the UniCredito Italiano Banking Group Banking Group Register No. 3135.1 - Genoa Trade and Companies Register: No. 22 – Tax Code and VAT Reg. No.: 00348170101 Member of the Interbank Deposit Protection Fund Credito Italiano – Italian Stock Company – Registered Office: Genoa, Via Dante, 1 – General Management: Milan, Via Broletto, 16 Capital: e 1,550,000,000 Fully Paid In – ABI Code: 02008.1 – Member Bank of the UniCredito Italiano Banking Group, Code 3135.1 Genoa Trade and Companies Register No. 37889 and No. 384022 of the Economic and Administrative Information File of the Genoa Chamber of Commerce Tax Code: 12931320159 – VAT Reg. No.: 01144620992. SOCIAL AND ENVIRONMENTAL REPORT 2000 Whatever does not exist in the spirit cannot exist in reality either... 1 Contents 2 SOCIAL AND ENVIRONMENTAL REPORT 2000 CONTENTS Letter from the Chairman Francesco Cesarini 4 Introduction 9 Part One 12 The UniCredito Italiano Group The Group’s identity 14 Summary description of Group 18 Towards the future 26 Part Two 32 The Parent Company: UniCredito Italiano S.p.A. Role and functions 34 Environmental, social and safety policies 36 Teamwork: Partners in sustainable development 42 Human resources 43 Other partners 60 3 Calculation and breakdown of value added 72 The path towards sustainable development: The Integrated Management System 79 Part Three 92 Credito Italiano S.p.A. -

Il Sistema Bancario Italiano Tra Il 1990 E Il 2008. Evoluzioni E Problemi Aperti
Dipartimento di Scienze giuridiche CERADI – Centro di ricerca per il diritto d’impresa Il sistema bancario italiano tra il 1990 e il 2008. Evoluzioni e problemi aperti Sara Battaglia dicembre 2008 © Luiss Guido Carli. La riproduzione è autorizzata con indicazione della fonte o come altrimenti specificato. Qualora sia richiesta un’autorizzazione preliminare per la riproduzione o l’impiego di informazioni testuali e multimediali, tale autorizzazione annulla e sostituisce quella generale di cui sopra, indicando esplicitamente ogni altra restrizione 1 2 Le trasformazioni che il sistema bancario italiano ha visto imporsi negli ultimi vent’anni sono state profonde e la sua riorganizzazione ha reso possibile alle banche italiane di cominciare a reggere il passo con le grandi “concorrenti” del mercato europeo e internazionale, che con i processi di globalizzazione ormai avanzati sono il vero campo d’azione su cui confrontarsi. Il sistema bancario italiano era basato, sin dalla Legge Bancaria del 19361, sui principi della specializzazione temporale del credito, della separazione tra banche e imprese, e della banca intesa come portatrice di un prevalente “interesse pubblico”, piuttosto che di carattere imprenditoriale. Questa sistemazione legislativa divenne incompatibile negli anni ’80 con la visione prevalente a livello europeo. In effetti, con la Legge Amato2 venne nel 1990 introdotta una nuova disciplina per enti pubblici e gruppi creditizi, che cominciava ad aprire il sistema alle Direttive europee in materia. L’equiparazione tra istituti pubblici e provati rispetto a finalità e autonomia gestionale rendeva necessaria una uniformità di forme societarie, così da favorire l’adozione, per le imprese sotto controllo pubblico, di forme societarie privatistiche. -

Italia Svegliati! La Più Grande Truffa Del Secolo
Marco Marsili ITALIA SVEGLIATI! La più grande truffa del secolo TERMIDORO EDIZIONI © Termidoro Edizioni via Mario Pichi, 3 - 20143 Milano [email protected] Commerciale: 0289403935 Promozione: tel. 0239620017 / 0287156229 - fax 0270030075 www.termidoro.it / [email protected] Indice Introduzione p. 9 Italia svegliati! La grande truffa p. 15 Unione senza democrazia p. 21 L’estrema difesa referendaria p. 24 C’era una volta la lira... p. 28 L’euro-catastrofe e la precarizzazione del lavoro p. 32 L’attacco alle pensioni p. 43 Liberismo per i lavoratori, socialismo per gli industriali... Il caso Fiat p. 49 Lo stratega della catastrofe p. 53 L’impotenza dei governi e i primi dubbi dei governanti p. 58 Lo strapotere delle banche p. 61 Dai templari al capitale finanziario moderno. Cenni storici p. 62 L’egemonia del capitale finanziario p. 70 La crisi attraversa l’Oceano dagli Usa all’Europa: il debito pubblico aumenta e le banche si arricchiscono p. 74 Il capitale finanziario e la crisi: l’Italia piange ... p. 82 ... ma l’Europa non ride p. 84 Il ricatto dei tassi p. 90 La rapina dei tassi p. 92 Effetto domino p. 99 Unione nell’euro: una strada senza uscita p. 104 Una cambiale impagabile p. 106 A picco con le banche? p. 112 Che cos’è il denaro? p. 115 Le banche in Italia p. 141 Il reddito da signoraggio p. 151 Salvare le banche o le popolazioni? p. 161 Se lo Stato non paga... p. 176 Il debito americano... p. 182 ...e quello del Sol levante p. 184 Controllare il debito.. -

UCI UK04 001 092.Indd
UniCredito Italiano SpA Report and Accounts 2 0 0 4 UniCredito Italiano Italian Joint Stock Company Registered office: Genoa, Via Dante, 1 General management: Milan, Piazza Cordusio Registered in Genoa Trade and Companies Register (Court of Genoa) Tax Code and VAT Reg. No. 00348170101 Entered in the Register of Banks and Parent Company of the UniCredito Italiano Banking Group Banking Group Register No. 3135.1 Member of the Interbank Deposit Protection Fund Capital stock: €3,168,354,641.50 fully paid in Introduction 305 Reclassified Accounts 306 Balance Sheet 306 Profit and Loss Account 306 The Company’s Operations 308 Human Resources 308 Main Business Areas 309 Loans to Customers 312 Bad and Doubtful Debts 312 Customer Deposits 313 REPORT ON OPERATIONS Securities Portfolio and Interbank Position 314 Equity Investments 316 Shareholders’ Equity, Subordinated Debt and Capital Ratios 317 Profit and Loss Account 319 Operating Profit 319 Net Profit 322 Other Information 324 Powers Delegated to Directors 324 Related-party Transactions 325 Directors', Auditors' and General Managers' Shareholdings 327 Subsequent Events and Outlook 328 Equity Investments 328 Board of Directors 328 Outlook 328 Note to the Report on Operations The following conventional symbols have been used in the tables: • A dash (-) indicates that the item/figure is inexistent. • Two stops (..) or (n.s.) when the figures do not reach the minimum considered significant or are not in any case considered significant. • “N/A” indicates that the figure is not available. • "XXX" figures note to be indicated. Unless otherwise indicated, all amounts are in millions of euros. 303 304 CONSOLIDATED ACCOUNTS AS AT 31 DECEMBER 2004 REPORT ON OPERATIONS Introduction To the Shareholders, Net profit for the year was €1,750 million, slightly lower (by 2.4%) than the €1,793 million for the previous year. -

UCI INDIV 2005UK 001 143.Indd
UniCredit SpA Report and Accounts as at 31 December 2005 Values creating Value UniCredito Italiano Italian Joint Stock Company Registered office: Genoa, via Dante, 1 General management: Milan, Piazza Cordusio Registered in the Genoa Trade and Companies Register (Courts of Genoa) Tax Code and VAT No. 00348170101 Entered in the Register of Banks Parent Company of the UniCredito Italiano Banking Group Banking Group Register No. 3135.1 Member of the Interbank Deposit Protection Fund Capital Stock: € 5,213,388,513 fully paid in RelazioneUniCredit SpATrimestrale Report andConsolidata Accounts al as 31 at marzo 31 December 2005 2005 Board of Directors BOARD OF DIRECTORS, Dieter Rampl * Chairman Gianfranco Gutty * Deputy Chairmen BOARD OF AUDITORS (First Deputy Chairman) Franco Bellei * AND EXTERNAL Fabrizio Palenzona * AUDITORS Carlo Salvatori * Alessandro Profumo ** Managing Director/CEO as at 22 March 2006 Roberto Bertazzoni ** Directors Manfred Bischoff Vincenzo Calandra Buonaura Giovanni Desiderio Volker Doppelfeld Giancarlo Garino Francesco Giacomin ** Piero Gnudi Friedrich Kadrnoska ** Max Dietrich Kley Luigi Maramotti Diether Münich ** Carlo Pesenti Hans Jürgen Schinzler Giovanni Vaccarino Paolo Vagnone ** Nikolaus von Bomhard ** Anthony Wyand Marco Fantazzini Company Secretary Board of Auditors Gian Luigi Francardo Chairman Giorgio Loli Statutory Auditors Aldo Milanese Vincenzo Nicastro Roberto Timo Giuseppe Armenise Alternate Auditors Marcello Ferrari KPMG S.p.A. External Auditors * Member of the Chairman’s Committee and of the Executive -

UNICREDIT S.P.A. SECONDO SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO
UNICREDIT S.p.A. Società per azioni — Sede Sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 — Tower A; iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale e partita IVA n. 00348170101; iscritta all’Albo delle Banche Capogruppo del Gruppo bancario UniCredit, Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 Capitale sociale Euro 21.059.536.950,48 interamente versato Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007 SECONDO SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE UniCredit S.p.A. (UniCredit, l’Emittente o la Banca) ha predisposto il presente supplemento (il Secondo Supplemento) che deve essere letto congiuntamente al, e costituisce parte integrante del, documento di registrazione depositato presso la CONSOB in data 3 luglio 2020, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0638145/20 del 3 luglio 2020 come successivamente modificato ed integrato dal Primo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 25 settembre 2020, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0954332/20 del 24 settembre 2020 (il Primo Supplemento e, congiuntamente, il Documento di Registrazione). Il Secondo Supplemento al Documento di Registrazione è stato depositato presso la CONSOB in data 11 dicembre 2020, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 1255034/20 del 10 dicembre 2020 ed è stato predisposto da UniCredit S.p.A. ai sensi dell’art. 10, par. 1, del Regolamento (UE) 2017/1129 e successive modifiche e integrazioni (il Regolamento Prospetto) come integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2019/980 (il Regolamento Delegato) e ai sensi del Regolamento CONSOB n. -

Unicredito Italiano
Commitment andsharedvalues UNICREDITO ITALIANO - CREDITO ITALIANO SOCIAL AND ENVIRONMENTAL REPORT 2000 UniCredito Italiano – Italian Stock Company – Registered Office: Genoa, Via Dante, 1 – General Management: Milan, Piazza Cordusio Capital: Lit. 2,512,102,903,000 Fully Paid In – Bank Entered in the Register of Banks and Parent Company of the UniCredito Italiano Banking Group Banking Group Register No. 3135.1 - Genoa Trade and Companies Register: No. 22 – Tax Code and VAT Reg. No.: 00348170101 Member of the Interbank Deposit Protection Fund Credito Italiano – Italian Stock Company – Registered Office: Genoa, Via Dante, 1 – General Management: Milan, Via Broletto, 16 Capital: e 1,550,000,000 Fully Paid In – ABI Code: 02008.1 – Member Bank of the UniCredito Italiano Banking Group, Code 3135.1 Genoa Trade and Companies Register No. 37889 and No. 384022 of the Economic and Administrative Information File of the Genoa Chamber of Commerce Tax Code: 12931320159 – VAT Reg. No.: 01144620992. SOCIAL AND ENVIRONMENTAL REPORT 2000 Whatever does not exist in the spirit cannot exist in reality either... 1 Contents 2 SOCIAL AND ENVIRONMENTAL REPORT 2000 CONTENTS Letter from the Chairman Francesco Cesarini 4 Introduction 9 Part One 12 The UniCredito Italiano Group The Group’s identity 14 Summary description of Group 18 Towards the future 26 Part Two 32 The Parent Company: UniCredito Italiano S.p.A. Role and functions 34 Environmental, social and safety policies 36 Teamwork: Partners in sustainable development 42 Human resources 43 Other partners 60 3 Calculation and breakdown of value added 72 The path towards sustainable development: The Integrated Management System 79 Part Three 92 Credito Italiano S.p.A. -
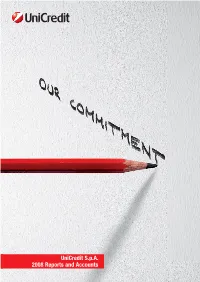
Unicredit S.P.A. 2008 Reports and Accounts and Reports 2008 S.P.A
UniCredit S.p.A. 2008 Reports and Accounts UniCredit S.p.A. 2008 Reports and Accounts www.unicreditgroup.eu At UniCredit Group we are aware that our business activities have an impact on the environment, and always factor environmental sustainability into our strategic decisions. In 2009 the greenhouse gas emissions associated with the paper used for the publication of 2008 Consolidated Reports and Accounts and Sustainability Report have been offset by a contribution to a biomass-fueled district heating plant in Italy (Valtellina). The offsets for the 2008 Consolidated Reports and Accounts and Sustainability Report were executed in association with AzzeroCO2 UniCredit Italian Joint Stock Company Registered Office: Rome, Via A. Specchi, 16 Pictures General Management: Milan, Piazza Cordusio Registration number in the Rome Trade and Companies Register, Cover, sorter pages and Top Manager Tax Code and VAT No. 00348170101 Entered in the Register of Banks Courtesy Ferruccio Torboli (UniCredit Group) Parent Company of the UniCredit Banking Group Banking Group Register No. 3135.1 Member of the Interbank Deposit Protection Fund Capital Stock: e 7,170,400,150.00 fully paid in Printed on certified recycled chlorine-free paper. Our Commitment is Our Strength 2008 was a year that posed significant challenges to the global economy, to the financial services industry and to our business. To date, our business model remains sound, and our outlook is positive for our future operations. We remain positive because we know that we can count on our greatest strength. It is our solid and rigorous commitment - to our customers, to our people, to our investors, to the communities we serve, to our core values, to culture, to quality in everything we do, and to the sustainable success of our enterprise.