Rivista Del Centro Studi Giuseppe Gioachino Belli
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Diversi, Ma Uguali! Febbraio 2019 Per Conoscere E Amare Il Nostro Pianeta
RIVISTA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 6 DIVERSI, MA UGUALI! FEBBRAIO 2019 PER CONOSCERE E AMARE IL NOSTRO PIANETA BellaGeo! ha un grande obiettivo: far apprezzare a tutti la geografi a, e attraverso di essa, la Terra su cui vivia- mo perché ogni studente possa diventare un cittadino del mondo motivato e consapevole. OBIETTIVO SOSTENIBILITÀ L’ attenzione alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica e alla tutela del territorio è il fi lo rosso che attraversa le pagine del corso e dà valore civico alla pro- posta didattica. TUTTI INCLUSI! Una proposta inclusiva, dal taglio agile e di semplice im- postazione che incontra sia le esigenze di chi ha bisogno di un aiuto in più, sia le aspettative di chi continua a porre domande. APP smart content LA FORZA DEI DATI REALTÀ AUMENTATA Il costante ricorso alla visualizzazione, a "record geografi ci" curiosi e signifi cativi, alla localizzazione e ai confronti mi- Un’app gratuita per tutti gli studenti che consente di accedere rapidamente con rano a incuriosire e facilitare la comprensione. Gli apparati smartphone o tablet ai contenuti digitali didattici presenti in ogni doppia pagina guidano all’appro- del testo. priazione di un metodo di studio; sintesi e videosintesi di fi ne unità corredate da mappe attive supportano il ripasso. Il lavoro su dati, carte e grafi ci aiuta invece a ccostruireostruire le competenze. IL CORSO È DISPONIBILE NELLE EDIZIONI: • PLUS (LIBRO + E-BOOK INTERATTIVO SCARICABILE) • DIGITALE (SOLO E-BOOK INTERATTIVO SCARICABILE) Per maggiori informazioni, rivolgiti al tuo Agente di zona (elenco in www.lascuola.it alla voce CONTATTI - RETE COMMERCIALE) editorialeeditoriale Diversi ma uguali! Caterina Lazzarini Febbraio: scavalcata la prima parte dell’anno scolastico, tra scrutini e fatiche fi nali, guardiamo avanti. -

03 Duval Guida5bis
POPE JOHN PAUL I’S CRITIQUE OF TRILUSSA’S FAITH A TRANSLATOR’S DEFENSE JOHN DUVAL On August 26, 1978, Cardinal Albino Luciani was elected Pope at Rome and chose as his papal, public name John Paul I. Almost immediately Edizioni Messaggero published a volume of the new Pope’s essays as they had appeared earlier in the Messagero di Sant'Antonio magazine. The title was Illustrissimi, for the illustrious saints and scholars, fictional characters and writers (such as Mark Twain, Francesco Petrarca, and Gioachino Belli) whom Cardinal Luciani had addressed and imaginatively conversed with in each of these essays. On the night of September 28, 1978, most unexpectedly, Pope John Paul I died. Before the year was out, William Weaver in the United States completed his English translation of Illustrissimi and published it with Little Brown. In February of 1982, Bill Quinn, my friend and fellow medievalist at the University of Arkansas, learning that I was beginning to translate the poetry of Trilussa, a Roman dialect poet of the first half of the twentieth century, introduced me to Illustrissimi by giving me a copy of the book in English. I was delighted and felt vicariously honored that Trilussa, my poet, was one of only three Italian poets whom the Pope, that is, Albino Luciani, addressed in his book. The other two were Petrarca and Gioachino Belli, a poet who, like Trilussa, wrote not in standard Italian, but in Romanesco, the modern dialect of Rome. But Luciani’s essay, “To Trilussa: In the Heart of the Mystery,” bothered me, too. -
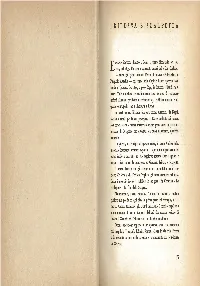
Trilussa E Scarpetta
TRILUSSA E SCARPETTA doardo Scarpetta debuttò a Roma al teatro Metastasio, ora spa E rito, nel 1877. Poi con i superstiti comici del e< San Carlino » - erano già spenti Antonio Petito, il famoso « Pulcinella », e Pasquale Altavilla - egli tornò nella Capitale l'anno appresso reci tando al Quirino. Dal 1890, o poco dopo, lo Scarpetta s'insediava al teatro Valle e d'allora sistematicamente dava tre mesi di rappresen tazioni all'anno, prediletto e acclamato dal pubblico romano e da quello cosmopolita che si riversava a Roma. In questi periodi Edoardo Scarpetta faceva trasportar da Napoli cocchio e cavalli per la sua passeggiata al Corso, additato dai romani con compiacenza, e faceva trasportare anche grosse casse di pasta ali mentare di Gragnano che divorava, da buon napolitano, quotidia namente. Un giorno, al principio di questo secolo, il conte Andrea Sola, mecenate lombardo, scrittore, deputato e soprattutto appassionato del teatro invitò a colazione nel suo soggiorno romano alcune signore e alcuni artisti, fra cui la principessa di Gravina, Trilussa e Scarpetta. Il nostro Trilussa era già celebre allora, soprattutto per il poe metto Er Serrajo che l'editore Voghera gli aveva stampato nel 1903. Come è noto Er Serrajo è suddiviso in tre parti: Er Comizzio - La Ribbejione - La fine dello Sciopero. Naturalmente, a cena compiuta, Trilussa fu invitato a recitare qualche sua poesia ed egli disse la prima parte del Serraglio, il Co mizio. Appena terminato, gli astanti invitarono il comico napolitano a dir qualcosa di suo e Scarpetta dichiarò che avrebbe recitato di nuovo il Comizio di Trilussa ma .. -

The Original Documents Are Located in Box 16, Folder “6/3/75 - Rome” of the Sheila Weidenfeld Files at the Gerald R
The original documents are located in Box 16, folder “6/3/75 - Rome” of the Sheila Weidenfeld Files at the Gerald R. Ford Presidential Library. Copyright Notice The copyright law of the United States (Title 17, United States Code) governs the making of photocopies or other reproductions of copyrighted material. Gerald R. Ford donated to the United States of America his copyrights in all of his unpublished writings in National Archives collections. Works prepared by U.S. Government employees as part of their official duties are in the public domain. The copyrights to materials written by other individuals or organizations are presumed to remain with them. If you think any of the information displayed in the PDF is subject to a valid copyright claim, please contact the Gerald R. Ford Presidential Library. Digitized from Box 16 of the Sheila Weidenfeld Files at the Gerald R. Ford Presidential Library 792 F TO C TATE WA HOC 1233 1 °"'I:::: N ,, I 0 II N ' I . ... ROME 7 480 PA S Ml TE HOUSE l'O, MS • · !? ENFELD E. • lt6~2: AO • E ~4SSIFY 11111~ TA, : ~ IP CFO D, GERALD R~) SJ 1 C I P E 10 NTIA~ VISIT REF& BRU SE 4532 UI INAl.E PAL.ACE U I A PA' ACE, TME FFtCIA~ RESIDENCE OF THE PR!S%D~NT !TA y, T ND 0 1 TH HIGHEST OF THE SEVEN HtL.~S OF ~OME, A CTENT OMA TtM , TH TEMPLES OF QUIRl US AND TME s E E ~oc T 0 ON THIS SITE. I THE CE TER OF THE PR!SENT QU?RINA~ IAZZA OR QUARE A~E ROMAN STATUES OF C~STOR .... -

Censorship and Literature in Fascist Italy'
H-Italy Valisa on Bonsaver, 'Censorship and Literature in Fascist Italy' Review published on Saturday, March 1, 2008 Guido Bonsaver. Censorship and Literature in Fascist Italy. Toronto: University of Toronto Press, 2007. 405 pp. $80.00 (cloth), ISBN 978-0-8020-9301-1; $35.00 (paper), ISBN 978-0-8020-9496-4. Reviewed by Silvia Valisa (Department of Foreign Languages and Literatures, San Francisco State University) Published on H-Italy (March, 2008) A Passion for Detail: Mussolini, Fascism, and Censorship The interest in Fascist editorial and ideological politics has produced some excellent work in the last decade, including Giorgio Fabre's L'elenco: censura fascista, editoria e autori ebrei (1998), devoted to the regime's racial politics; as well as Ruth Ben-Ghiat'sFascist Modernities: Italy, 1922-1945 (2001) and Marla S. Stone's The Patron State: Culture and Politics in Fascist Italy (1998), both of which address state-culture relations during the Fascist regime. Guido Bonsaver's new volume, Censorship and Literature in Fascist Italy, adds to these an idiosyncratic, thoroughly researched, and very readable portrait of what it meant to be a writer and/or a cultural operator during the ventennio. (In 2005, Bonsaver also edited, together with Robert Gordon, the proceedings of a conference, Culture, Censorship and the State in Twentieth Century Italy.) As this new monograph cogently confirms, "Fascist censorship was not a monolithic and tightly coordinated machine of repression" (p. 5). Bonsaver illustrates the extent to which censorship needs to be contextualized, historicized, and examined from multiple standpoints to call into question the notion of absolute consistency that is often ascribed to "censorship" as a phenomenon. -

Fans, Romans, Countrymen: Soccer Fandom and Civic Identity in Contemporary Rome
International Journal of Communication 5 (2011), 1990–2013 1932–8036/20111990 Fans, Romans, Countrymen: Soccer Fandom and Civic Identity in Contemporary Rome MATTHEW GUSCHWAN Indiana University In Italy, football (soccer) fandom is an important site on which to construct and perform civic identity. Based on a constructivist, communication-oriented understanding of identity, this article uses ethnographic data to illustrate how Roman soccer fans construct civic identity through various communicative forms, such as verbal performance and visual display. The essay draws from museum studies scholarship to highlight the role of fan-created displays in the construction of fan identities. Ultimately, the fans’ notions of place and local identity emerge through these discursive practices. In mass media fan cultures, geographic boundaries tend to recede as nationally or globally dispersed fans have virtually simultaneous access to media texts and spatially transcendent online forums in which to socialize. In most cases, the physical proximity of the viewer to the setting of a text seems trivial, if not irrelevant. Conversely, sports fan culture remains firmly rooted in notions of locality. Despite global trends of deterritorialization that weaken the “spatial connections of cultural practices, identities, products, and communities” (Giulianotti & Robertson, 2009, p. 34), the local team, be it at the high school, college, or professional level, always plays against the team from over there—down the street, in the next city, across state lines, or from another continent (Dunning, 1999, p. 5; Giulianotti & Robertson, 2009). As various scholars (including Kraszewski, 2008; Maguire, 2005; Williams, 1994) have argued, sports can symbolize local identity. Teams at all levels claim to represent local community as they compete for pride and glory at the expense of their geographically othered adversaries. -

From the Mediterranean to Southeast Florida, 1896-1939 Antonietta Di Pietro Florida International University, [email protected]
Florida International University FIU Digital Commons FIU Electronic Theses and Dissertations University Graduate School 11-8-2013 Italianità on Tour: From the Mediterranean to Southeast Florida, 1896-1939 Antonietta Di Pietro Florida International University, [email protected] DOI: 10.25148/etd.FI13120902 Follow this and additional works at: https://digitalcommons.fiu.edu/etd Part of the Cultural History Commons, and the European History Commons Recommended Citation Di Pietro, Antonietta, "Italianità on Tour: From the Mediterranean to Southeast Florida, 1896-1939" (2013). FIU Electronic Theses and Dissertations. 1003. https://digitalcommons.fiu.edu/etd/1003 This work is brought to you for free and open access by the University Graduate School at FIU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in FIU Electronic Theses and Dissertations by an authorized administrator of FIU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY Miami, Florida ITALIANITÀ ON TOUR: FROM THE MEDITERRANEAN TO SOUTHEAST FLORIDA, 1896-1939 A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in HISTORY by Antonietta Di Pietro 2013 To: Dean Kenneth G. Furton College of Arts and Sciences This dissertation, written by Antonietta Di Pietro, and entitled Italianità on Tour: From the Mediterranean to Southeast Florida, 1896-1939, having been approved in respect to style and intellectual content, is referred to you for judgment. We have read this dissertation and recommend that it be approved. _______________________________________ Pascale Becel _______________________________________ Gwyn Davies _______________________________________ Maria del Mar Logrono Narbona _______________________________________ Aurora Morcillo, Major Professor Date of Defense: November 8, 2013 The dissertation of Antonietta Di Pietro is approved. -
A Citizen Sociolinguistic Case Study of the Roman Dialect
Ideologies of Personhood: A Citizen Sociolinguistic Case Study of the Roman Dialect Andrea R. Leone University of Pennsylvania The status and role of Italy’s dialetti (dialects) in contemporary Italian society are contested among both citizens and sociolinguists, and their nuanced uses have begun to circulate (with commentary) around social media. This report adopts a citizen sociolinguistic approach (Rymes & Leone, this volume) to analyze a single controversial case about the Roman dialect via YouTube and Facebook, drawing on social media users’ metacommentary and recontextualizations (Rymes, 2012) of an interview with two young women at the beach. Rather than attempting to identify static and isolated characteristics of the Roman dialect based on this interview, this report analyzes the social values and linguistic characteristics that citizen sociolinguists attribute to these young women’s particular ways of speaking, acting, and being. uring one of the hottest weeks of the year in July of 2010, an Italian journalist and a camera crew at Ostia beach (near Rome, Italy) approached a bikini-clad teenage girl for an interview, asking “Fa caldo?” (“Is it hot?”), and proceeded Dto do a 52-second interview with the girl (Debora, right, Figure 1) and her friend (Romina, left, Figure 1) about how one tolerates the heat at the beach (nicves1992, 2010). They told him that they keep cool and comfortable with beer and push-pops, as well as the occasional shower in order to keep from getting itchy from the salt water. The video of the interview was broadcast on the station’s news channel and quickly went viral on YouTube after having been subtitled with exaggeratedly “correct” Italian (see Figure 3). -

Documentazione Trilussiana
Accademia Nazionale dei Lincei DOCUMENTAZIONE TRILUSSIANA Elenco a cura di Paola Cagiano de Azevedo Roma 2015 Trilussa (Roma 1871-1950) Pseudonimo anagrammatico del poeta Carlo Alberto Salustri. Poeta dialettale romano, autore di favole e di sonetti, nei quali raffigurò la Roma borghese e piccolo borghese. Collaborò al «Don Chisciotte» e al «Rugantino». Nel 1950, poco prima della morte fu nominato dal presidente Einaudi senatore a vita. Opere Stelle di Roma. Versi romaneschi, 1889 . Er Mago de Bborgo. Lunario pe’r 1890, 1890. Er Mago de Bborgo. Lunario pe’r 1891, 1891 . Quaranta sonetti romaneschi, 1894 . Altri sonetti. Preceduti da una lettera di isacco di David Spizzichino, strozzino , 1898 Favole romanesche , Roma, Enrico Voghera, 1901. Caffè-concerto , Roma, Enrico Voghera, 1901. Er serrajo , Roma, Enrico Voghera, 1903. Sonetti romaneschi , Roma, Enrico Voghera, 1909. Nove poesie , Roma, Enrico Voghera, 1910. Roma nel 1911: l'Esposizione vista a volo di cornacchia: sestine umoristiche , Roma, Tip. V. Ferri e C., 1911. Le storie , Roma, Enrico Voghera, 1913. Ommini e bestie , Roma, Enrico Voghera, 1914. La vispa Teresa , Roma, Casa editrice M. Carra e C., di L. Bellini, 1917. ... A tozzi e bocconi: Poesie giovanili e disperse , Roma, Carra, 1918. Lupi e agnelli , Roma, Enrico Voghera, 1919. Le cose , Roma-Milano, A. Mondadori, 1922. I sonetti , Milano, A. Mondadori, 1922. La Gente , Milano, A. Mondadori, 1927. Picchiabbò, ossia La moje der ciambellano: spupazzata dall'autore stesso , Roma, Edizioni d'arte Fauno, 1927. Libro n. 9 , Milano, A. Mondadori, 1930. Evviva Trastevere: poesie, bozzetti, storia della festa de nojantri, varietà , Trilussa ed altri, Roma, Casa edit. -

Corriere Della Sera”
Grazia Deledda Fabulist on Newspapers: The Experience with “Corriere della Sera” Giambernardo Piroddi University of Sassari Proceeding of the AATI Conference in Cagliari [Italy], June 20-25, 2018. Section Literature. AATI Online Working Papers. ISSN: 2475-5427. All rights reserved by AATI. ABSTRACT: The aim of this article is to contextualize the journalistic apprenticeship of Grazia Deledda inside the polarity represented on the one hand by ethnographic writings published in the magazine «Rivista delle tradizioni popolari», and on the other hand by her novelistic production intended for publication in the Italian newspaper «Corriere della Sera»: a perfect parabola that – almost paradoxically – shows us how the author moves from writing about popular traditions in a magazine (the place of literary productions for leisure and entertainment) to inventing fantasy tales within the pages of a newspaper (the place par excellence of chronicles). This writing activity is bound to the request from newspaper’s management of any type of short stories or tales: it was the rule, rather than the exception, from the starting in the second half of 1800s, when Italian publishing market is ever-expanding. All these aspects are well documented in Deledda - «Corriere della Sera» correspondence (1909-1936), kept at the Historical Archive of the newspaper in Milan. The archive consists of one hundred sixty-six epistolary communications, some of which are analyzed in this article to document better nature and purposes of Deledda’s journalistic production. Keywords: Elzeviro, ethnographic, journalism, newspaper, epistolary, faire-tales bestiary, chronicle, fiction Grazia Deledda’s writing activity in the greatest Italian daily newspaper, «Corriere della Sera», covers a time-frame extending from 1909 to 1936. -

Curses and Laughter: the Ethics of Political Invective in The
CURSES AND LAUGHTER: THE ETHICS OF POLITICAL INVECTIVE IN THE COMIC POETRY OF HIGH AND LATE MEDIEVAL ITALY by NICOLINO APPLAUSO A DISSERTATION Presented to the Department ofRomance Languages and the Graduate School ofthe University ofOregon in partial fulfillment ofthe requirements for the degree of Doctor ofPhilosophy June 2010 11 University of Oregon Graduate School Confirmation of Approval and Acceptance of Dissertation prepared by: Nicolino Applauso Title: "Curses and Laughter: The Ethics ofPolitical Invective in the Comic Poetry ofHigh and Late Medieval Italy" This dissertation has been accepted and approved in partial fulfillment ofthe requirements for the Doctor ofPhilosophy degree in the Department ofRomance Languages by: Regina Psaki, Chairperson, Romance Languages Massimo Lollini, Member, Romance Languages David Wacks, Member, Romance Languages Steven Shankman, Outside Member, English and Richard Linton, Vice President for Research and Graduate StudieslDean ofthe Graduate School for the University ofOregon. June 14,2010 Original approval signatures are on file with the Graduate School and the University ofOregon Libraries. III © 2010 Nicolino Applauso iv An Abstract ofthe Dissertation of Nicolino Applauso for the degree of Doctor ofPhilosophy in the Department ofRomance Languages to be taken June 2010 Title: CURSES AND LAUGHTER: THE ETHICS OF POLITICAL INVECTIVE IN THE COMIC POETRY OF HIGH AND LATE MEDIEVAL ITALY Approved: _ Dr. F. Regina Psaki My dissertation examines the ethical engagement ofpolitical invective poetry in thirteenth- and fourteenth-century Italy. Modem criticism tends to treat medieval invective as a playfully subversive but marginal poetic game with minimal ethical weight. Instead, I aim to restore these poetic productions to their original context: the history, law, and custom ofTuscan cities. -

Research Frontiers, Spring 2007
University of Arkansas, Fayetteville ScholarWorks@UARK Research Frontiers Research Frontiers Spring 2007 Research Frontiers, Spring 2007 University of Arkansas Fayetteville. Office of University Relations Follow this and additional works at: https://scholarworks.uark.edu/research-frontiers-magazine Citation University of Arkansas Fayetteville. Office of University Relations. (2007). Research Frontiers, Spring 2007. Research Frontiers. Retrieved from https://scholarworks.uark.edu/research-frontiers-magazine/10 This Periodical is brought to you for free and open access by the Research Frontiers at ScholarWorks@UARK. It has been accepted for inclusion in Research Frontiers by an authorized administrator of ScholarWorks@UARK. For more information, please contact [email protected]. Famous Fish or Fowl? When outstanding quality assurance is important in cold storage product integrity and logistics, depend on the people of Zero Mountain. No matter whether it’s fish, fowl, fruit, or any variety of foodstuff, we care for our customers’ products like they are destined for fame. Depend on us to Zero-in on Performance for: • Effective Energy Management • More Efficient Cold Logistics • Improving Food Chain Safety ™ Learn more about Zero Mountain at our website or call us. 4 Central USA Locations - 800-691-1010 - www.zeromtn.com Zero18403.indd 1 3/9/07 1:47:57 PM SPRING 2007 SPRING 2007 A MESSAGE FROM THE CHANCELLOR Arts & LETTERS Fayetteville, Arkansas 72701 Office of the Chancellor http://chancellor.uark.edu A Message from the Chancellor: Sustainability is one of today’s “buzzwords” in business and education. While there’s no agreed upon definition for sustainability, one might loosely translate it as how we impact our surroundings.