Immigrazione E Processi Di Interazione Culturale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rete Locale Giurisdizione
RIEPILOGO RIEPILOGO Assetto attuale Nuovo assetto giurisdizioni giurisdizioni aggiornato km km Giurisdizione "A" RETE PRIMARIA 41,472 41,472 RETE PRINCIPALE 36,171 36,171 RETE SECONDARIA 21,706 21,706 RETE LOCALE 3,115 3,115 102,464 102,464 Giurisdizione "B" RETE PRIMARIA 43,432 27,657 RETE PRINCIPALE 29,652 11,805 RETE SECONDARIA 95,538 55,481 RETE LOCALE 13,786 12,863 182,408 107,806 Giurisdizione "C" RETE PRIMARIA 64,397 72,472 RETE PRINCIPALE 17,350 31,352 RETE SECONDARIA 138,291 131,286 RETE LOCALE 43,832 33,477 263,870 268,587 Giurisdizione "D" RETE PRIMARIA 50,563 45,348 RETE PRINCIPALE 44,262 48,107 RETE SECONDARIA 92,165 139,227 RETE LOCALE 13,960 25,238 200,950 257,920 Giurisdizione "E" RETE PRIMARIA 61,261 74,176 RETE PRINCIPALE 11,545 11,545 RETE SECONDARIA 122,464 122,464 RETE LOCALE 23,669 23,669 218,939 231,854 Totale estesa chilometrica strade provinciali 968,631 968,631 Totale estesa chilometrica suddivisa per tipologia di rete - RETE PRIMARIA 261,125 - RETE PRINCIPALE 138,980 - RETE SECONDARIA 470,164 - RETE LOCALE 98,362 968,631 Aggiornamento: Marzo 2017 1/1 Giurisdizione "A" GIURISDIZIONE "A" S.P. DENOMINAZIONE km RETE PRIMARIA Di Alagna 299 41,472 tratto: Roccapietra (km 51+300) - Alagna Valsesia totale rete primaria 41,472 RETE PRINCIPALE 9 Di Valle Mastallone - "V. Lancia" 18,758 10 Di Valle Sermenza 17,413 totale rete principale 36,171 RETE SECONDARIA 79 S.P. 9 - Sabbia 2,053 80 S.P. -
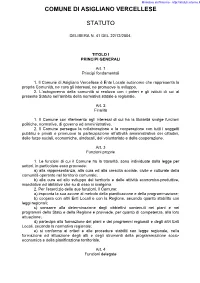
Statuto Comune Di Asigliano Vercellese
Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it COMUNE DI ASIGLIANO VERCELLESE STATUTO DELIBERA N. 41 DEL 22/12/2004. TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Principi fondamentali 1. Il Comune di Asigliano Vercellese è Ente Locale autonomo che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo. 2. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto nell’ambito della normativa statale e regionale. Art. 2 Finalità 1. Il Comune con riferimento agli interessi di cui ha la titolarità svolge funzioni politiche, normative, di governo ed amministrative. 2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione all’attività amministrativa dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali, del volontariato e della cooperazione. Art. 3 Funzioni proprie 1. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge per settori, in particolare esso provvede: a) alla rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale; b) alla cura ed allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive, insediative ed abitative che su di esso si svolgono. 2. Per l’esercizio delle sue funzioni, il Comune: a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione; b) coopera con altri Enti Locali e con la Regione, secondo quanto stabilito con leggi regionali; c) concorre alla determinazione degli obbiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione; d) partecipa alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli altri Enti Locali, secondo la normativa regionale; e) si conforma ai criteri e alle procedure stabiliti con legge regionale, nella formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio- economica e della pianificazione territoriale. -

Medici Per Titolo/Specialità
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI VC C.so MAGENTA, 1 - 13100 VERCELLI Tel. 0161256256 - Fax 0161256156 Medici per Titolo/Specialità Solo Specialità dei Medici Chirurghi Filtro memorizzato: Solo Specialità dei Medici Chirurghi Filtro in maschera: Ordinamento: Per Nominativo Nominativo CodMed CodOdo Indirizzo di residenza CAP Comune Prov. 1 ALLERGOLOGIA Cod. Titolo Fed.: 0301 CORRADINO PIER GIUSEPPE 01343 VIA DERNA 29 13100 VERCELLI VERCELLI GRANATA ANTONINO 01749 VIA F. TURATI 37 F 13060 ROASIO VERCELLI RANGHINO EMANUELA 01564 VIA CIRENE 16 13100 VERCELLI VERCELLI 98 ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA Cod. Titolo Fed.: 0300 D'ANTONIO CRISTIAN DAVID 02524 VIA RIGHI 18 13100 VERCELLI VERCELLI 2 ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA Cod. Titolo Fed.: 3701 CASTRI MASSIMO 01265 VIA ROMA 37 13032 ASIGLIANO VERCELLESE VERCELLI OTTINETTI ANTONIO 02029 C.SO ROLANDI 57 13017 QUARONA VERCELLI RAVARINO NICOLETTA 01480 VIA L DA VINCI 3 13044 CRESCENTINO VERCELLI 665 ANATOMIA PATOLOGICA Cod. Titolo Fed.: 3700 NUNZIATA RAFFAELE 02498 VIA S.G.BOSCO 9 13100 VERCELLI VERCELLI 77 ANDROLOGIA Cod. Titolo Fed.: 0701 SALAMANO GIOVANNI 01965 PIAZZA SOLFERINO 3 13100 VERCELLI VERCELLI 3 ANESTESIA E RIANIMAZIONE Cod. Titolo Fed.: 4400 BARZE' FRANCO 02368 00004 VIA NIGRA 10 13100 VERCELLI VERCELLI BAUSARDO MARIA GRAZIA 01858 VIA FRANCHI 17 27100 PAVIA PAVIA BELLINI ROBERTO 01243 VIA MAGGIO 1906 4 13100 VERCELLI VERCELLI BONGIANINO FRANCO 01654 VIALE CONSOLATA 79 13040 BORGO D'ALE VERCELLI CAVAGNINO MARIA TERESA 01042 VIALE BATTISTI 22/A 13019 -

Piemonte Vercelli
DISPONIBILITÀ comunali di SPAZI per AFFISSIONI PROVINCIA COMUNE ABITANTI POSTER 6X3 100X140 70X100 VERCELLI Alagna Valsesia 434 --- 5 5 VERCELLI Albano Vercellese 342 --- 5 5 VERCELLI Alice Castello 2'716 --- 10 10 VERCELLI Arborio 939 --- 5 5 VERCELLI Asigliano Vercellese 1'390 --- 10 10 VERCELLI Balmuccia 92 --- 5 5 VERCELLI Balocco 250 --- 5 5 VERCELLI Bianzè 2'060 --- 10 10 VERCELLI Boccioleto 221 --- 5 5 VERCELLI Borgo d'Ale 2'644 --- 10 10 VERCELLI Borgo Vercelli 2'372 --- 10 10 VERCELLI Borgosesia 13'336 1 30 30 VERCELLI Breia 188 --- 5 5 VERCELLI Buronzo 922 --- 5 5 VERCELLI Campertogno 246 --- 5 5 VERCELLI Carcoforo 79 --- 5 5 VERCELLI Caresana 1'051 --- 10 10 VERCELLI Caresanablot 1'145 --- 10 10 VERCELLI Carisio 919 --- 5 5 VERCELLI Casanova Elvo 275 --- 5 5 VERCELLI Cellio 863 --- 5 5 VERCELLI Cervatto 49 --- 5 5 VERCELLI Cigliano 4'586 --- 10 10 VERCELLI Civiasco 262 --- 5 5 VERCELLI Collobiano 108 --- 5 5 VERCELLI Costanzana 831 --- 5 5 VERCELLI Cravagliana 272 --- 5 5 VERCELLI Crescentino 8'086 --- 15 15 VERCELLI Crova 423 --- 5 5 VERCELLI Desana 1'083 --- 10 10 VERCELLI Fobello 220 --- 5 5 VERCELLI Fontanetto Po 1'242 --- 10 10 VERCELLI Formigliana 569 --- 5 5 VERCELLI Gattinara 8'340 --- 15 15 VERCELLI Ghislarengo 908 --- 5 5 VERCELLI Greggio 390 --- 5 5 VERCELLI Guardabosone 356 --- 5 5 VERCELLI Lamporo 547 --- 5 5 VERCELLI Lenta 905 --- 5 5 VERCELLI Lignana 584 --- 5 5 VERCELLI Livorno Ferraris 4'529 --- 10 10 VERCELLI Lozzolo 822 --- 5 5 VERCELLI Mollia 106 --- 5 5 VERCELLI Moncrivello 1'444 --- 10 10 VERCELLI Motta de' Conti 812 --- 5 5 VERCELLI Olcenengo 745 --- 5 5 VERCELLI Oldenico 258 --- 5 5 Due Valli Pubblicità S.r.l. -

2-2014 Revoca Convenzione Edilizia E Urbanistica Copia
COMUNE DI RIVE PROVINCIA DI VERCELLI ******************************************** VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 OGGETTO: REVOCA DELLA DELIBERAZIONE N. 35 DEL 11 DICEMBRE 2013, DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ASIGLIANO VERCELLESE, DESANA, LIGNANA E RIVE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI “PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE, NONCHE PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRA COMUNALE” E “CATASTO, AD ECCEZIONE DELLE FUNZIONI MANTENUTE ALLO STATO DALLA NORMATIVA VIGENTE“. L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì CINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 21,00 nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA di prima convocazione. Fatto l’appello risultano: N° COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 1 MANACHINO GIAN FRANCO X 2 NIGRO CARMELA X 3 PEDROLA NATALINO X 4 BARBERIS RICCARDO X 5 TRONEL MONICA X 6 MANACHINO GIANNI X 7 MARTINELLA FLORENCE X 8 LAFRONZA ANNA X 9 SIGAUDO MARIA RITA X 10 PAGGIO SABINA X 11 PASQUINO IGNAZIO X 12 DELLAROLE RICCARDO X 13 TORRIANO LUIGINA X Partecipa il Segretario dell’Ente, Dott. Giulio CATTI, con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a), del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MANACHINO Gianni, nella sua qualità di VICESINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. IL PRESIDENTE PREMESSO che: - questo Comune, per avere una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, soggiace all’obbligo dell’esercizio associato di funzioni e servizi, mediante unioni di comuni o convenzione, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. -

ENTYPO LOSAMEDCHEM FINAL-Per PAGE.Pdf
Publication: Thessaloniki Chamber of Commerce and Industry (TCCI) Creative direction: PARAMOUNT S.A. Printing-Book binding: KETHEA SCHEMA+CHROMA printing unit of Therapy Center for Dependent Individuals s counsellor in charge of European policies for the Province of Novara, during the first periods of the project I have had the opportunity to follow step by step the development of the project A“LOSAMEDCHEM - How could the logistics and the safety of the transports of chemicals be im- proved in the Mediterranean area”. This publication represents the results of the first phase of the project, which is implemented in the framework of the EU Transnational Cooperation Programme “MED” and is co-financed by the European Regional Development Fund. As Lead partner, I strongly believe that LOSAMEDCHEM is a significant occasion of development for all the involved areas. The publication at issue is an opportunity for the dissemination of the results of this initial phase in which the partners have carried out a SWOT analysis within their territory and that has led to the identification of Best Practices. Moreover, I would like to underline the importance of this phase as a basis for the development of subsequent phases of the project. Furthermore, through the development of those phases I hope that it could be possible to obtain benefits for the areas involved by the project. Finally, I think that LOSAMEDCHEM will achieve concrete results and I am sure that, through the efforts of all partners, such an objective will be reached. Indeed, the concreteness in results is a priority for us: this is because it is the only way to produce benefits to the territories involved in the project. -

13010 Stroppiana (Vc)
CURRICULUM V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI Nome FARANA BARTOLOMEO Indirizzo VIA G. FALCONE 1 – 13010 STROPPIANA (VC) Telefono Comune di Stroppiana 016177112 Comune di Pertengo 0161779048 Comune di Costanzana 0161312112 Comune di Asigliano Vercellese 016136121 Fax E-mail [email protected] [email protected] [email protected] t [email protected] Nazionalità Italiana Luogo e Data di nascita NICOSIA (EN) 28/03/1963 ESPERIENZA LAVORATIVA • Date (da – a) TITOLARITA’ DI SEDI: DAL 19.08.1991 AL 19.09.1991 TITOLARE DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI VOCCA (VC) classe IV; DAL 20.09.1991 AL 31.08.1999 TITOLARE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI STROPPIANA E PERTENGO (VC) classe IV DAL 01.09.1999 AL 05.10.2004 TITOLARE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI STROPPIANA PERTENGO COSTANZANA (VC) classe IV – CON FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE; DAL 06.10.2004 TITOLARE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI STROPPIANA COSTANZANA PERTENGO ASIGLIANO VERCELLESE (VC) classe III – CON FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE; SUPPLENZE O REGGENZE A SCAVALCO: DAL 01.06.1993 AL 30.11.1993 SUPPLENZA A SCAVALCO DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CARESANABLOT OLCENENGO E SALI VERCELLESE (VC) classe IV; DAL 25.08.1994 AL 28.02.1995 SUPPLENZA A SCAVALCO DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI PEZZANA E LIGNANA (VC) classe IV; DAL 01.03.1997 AL 31.08.1999 REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL -

Indizione Comizi
PROVINCIA DI VERCELLI ****** Proposta N. 209 / 2021 DECRETO DEL PRESIDENTE N. 4 DEL 01.02.2021 OGGETTO: CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI VERCELLI PER IL GIORNO 21 MARZO 2021 IL PRESIDENTE • Richiamati i propri precedenti decreti numeri 12, in data 02.11.2020, e 15, in data 09.11.2020, con cui rispettivamente sono stati indetti i comizi elettorali per l’elezione del Consiglio Provinciale per il giorno 13 Dicembre 2020 nonché revocati avendo il D.L. 148/2020 stabilito che le elezioni concernenti il Consiglio Provinciale si svolgano entro il 31 Marzo 2021 nonché è stata disposta la proroga della durata del mandato del Consiglio in carica; • Ritenuto, quindi, di stabilire nel giorno di Domenica 21 Marzo 2021, la data di svolgimento delle elezioni del Consiglio Provinciale; DECRETA 1) di indire i comizi elettorali per l’elezione del Consiglio Provinciale di Vercelli, che si svolgeranno domenica 21 Marzo 2021, dalle ore otto alle ore venti; 2) che le operazioni di voto si svolgeranno: presso il seggio centrale costituito presso la Sede della Provincia di Vercelli – Sala delle Tarsie, Via E. De Amicis n. 2 per gli elettori dei Comuni di: Albano, Alice Castello, Arborio, Asigliano Vercellese, Balocco, Bianzè, Borgo d’Ale, Borgo Vercelli, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cigliano, Collobiano, Costanzana, Crescentino, Crova, Desana, Fontanetto Po, Formigliana, Ghislarengo, Greggio, Lamporo, Lignana, Livorno Ferraris, Moncrivello, Motta de’ Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Quinto Vercellese, Rive, Ronsecco, Rovasenda, Salasco, Sali Vercellese, Saluggia, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, Santhià, Stroppiana, Tricerro, Trino, Tronzano Vercellese, Vercelli, Villarboit, Villata. -

Elezioni Provincia Di Vercelli 2018 Allegato 1) Corpo Elettorale Attivo (Aventi Diritto Al Voto)
Elezioni Provincia di Vercelli 2018 Allegato 1) corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) Fascia A COMUNE di ALAGNA N. Prog COGNOME NOME SESSO LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA CARICA RICOPERTA 1 1 1 VEGGI Roberto M VERCELLI 27/03/1982 sindaco ALAGNA Fascia A 2 2 2 BIONI Andrea M BORGOSESIA (VC) 01/03/1991 consigliere ALAGNA Fascia A 3 3 3 CALCAGNI Paola F MILANO 30/08/1980 consigliere ALAGNA Fascia A 4 4 4 COCCHI Andrea M MILANO 25/05/1972 consigliere ALAGNA Fascia A 5 5 5 COCITO Vittorio M NOVARA 30/07/1961 consigliere ALAGNA Fascia A 6 6 6 DEGASPARIS Giuliano M BORGOSESIA (VC) 29/04/1989 consigliere ALAGNA Fascia A 7 7 7 GRASSI del GRUMELLO Alberto M MILANO 13/10/1963 consigliere ALAGNA Fascia A 8 8 8 MIGNELLI Claudia F ISERNIA 05/12/1986 consigliere ALAGNA Fascia A 9 9 9 NEGRA Giovanni M VARALLO (VC) 12/01/1958 consigliere ALAGNA Fascia A 10 10 10 POZZI Marco M MILANO 01/09/1961 consigliere ALAGNA Fascia A 11 11 11 VALZER Lisa F BORGOSESIA (VC) 08/11/1992 consigliere ALAGNA Fascia A COMUNE DI ALBANO VERCELLESE COGNOME NOME SESSO LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA CARICA RICOPERTA 12 12 1 ZARATTINI Massimiliano M VERCELLI 13/03/1974 sindaco ALBANO V.SE Fascia A 13 13 2 CISARO Alessandro M BIELLA 22/03/1976 consigliere ALBANO V.SE Fascia A 14 14 3 DELL'OLMO Roberto M VILLATA 03/02/1954 consigliere ALBANO V.SE Fascia A 15 15 4 FERRARIS Alberto M ALBANO VERCELLESE 27/07/1963 consigliere ALBANO V.SE Fascia A 16 16 5 LIMBERTI Giorgio M GATTINARA 30/03/1974 consigliere ALBANO V.SE Fascia A 17 17 6 NDAHIGWA Jean N NGENDA (RUANDA) 05/09/1976 -

Rapporti Dormienti Per Totem
ELENCO DORMIENTI AL 31.05.2013 COMUNICATI A CONSAP E AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Data di Nascita Nome (GG/MM/AAAA) Codice Cognome Intestazione Luogo di Nascita Provincia CAB Filiale N° Identificativo Rapporto Ragione Sociale / Denominazione Partita IVA Filiale (persone giuridiche) AL PORTATORE INTESTATARIO UNICO 22300 011 FILIALE PRINCIPALE DI BIELLA 1000417 AL PORTATORE INTESTATARIO UNICO 22300 011 FILIALE PRINCIPALE DI BIELLA 1000418 AL PORTATORE INTESTATARIO UNICO 22304 017 AGENZIA N. 4 DI BIELLA 1000052 AL PORTATORE INTESTATARIO UNICO 44330 022 FILIALE DI BRUSNENGO 1000480 MARIA GAGNA COINTESTATARIO 03/10/1931 CERRIONE BI 44400 029 FILIALE DI CERRIONE/VERGNASCO 1000052 TIZIANA MORINO COINTESTATARIO 26/02/1955 CERRIONE BI 44400 029 FILIALE DI CERRIONE/VERGNASCO 1000052 ADRIANA FAVA D'ALBERTO COINTESTATARIO 27/08/1945 TRIVERO BI 44430 034 FILIALE DI COSSATO 1000825 AL PORTATORE INTESTATARIO UNICO 44430 034 FILIALE DI COSSATO 1001042 ALBERTO BIANCO COINTESTATARIO 14/06/1939 TORINO TO 44430 034 FILIALE DI COSSATO 1000825 HENRI ROBERT CATELLA INTESTATARIO UNICO 16/05/1960 FRANCIA EE 44430 034 FILIALE DI COSSATO 1000136 AL PORTATORE INTESTATARIO UNICO 44510 038 FILIALE DI GRAGLIA 1000135 AL PORTATORE INTESTATARIO UNICO 44490 039 FILIALE DI GAGLIANICO 1000050 AL PORTATORE INTESTATARIO UNICO 44560 040 FILIALE DI MASSERANO 3000011 MASSIMO FAZZOLARI INTESTATARIO UNICO 16/06/1946 ARMENTO PZ 01600 041 FILIALE DI MILANO 1000015 AL PORTATORE INTESTATARIO UNICO 44570 042 FILIALE DI MONRANDO 1000616 AL PORTATORE INTESTATARIO UNICO -

Medie Radon Provincia Vercelli 2017
Provincia Comune media radon al piano terra (Bq/m 3) Vercelli Alagna Valsesia 111 Vercelli Albano Vercellese 92 Vercelli Alice Castello 72 Vercelli Arborio 82 Vercelli Asigliano Vercellese 77 Vercelli Balmuccia 89 Vercelli Balocco 74 Vercelli Bianze' 72 Vercelli Boccioleto 85 Vercelli Borgo d'Ale 72 Vercelli Borgo Vercelli 72 Vercelli Borgosesia 95 Vercelli Breia (Cellio con Breia) 95 Vercelli Buronzo 78 Vercelli Campertogno 88 Vercelli Carcoforo 110 Vercelli Caresana 104 Vercelli Caresanablot 84 Vercelli Carisio 74 Vercelli Casanova Elvo 76 Vercelli Cellio (Cellio con Breia) 118 Vercelli Cervatto 96 Vercelli Cigliano 72 Vercelli Civiasco 84 Vercelli Collobiano 84 Vercelli Costanzana 76 Vercelli Cravagliana 63 Vercelli Crescentino 80 Vercelli Crova 72 Vercelli Desana 73 Vercelli Fobello 89 Vercelli Fontanetto Po 77 Vercelli Formigliana 76 Vercelli Gattinara 78 Vercelli Ghislarengo 80 Vercelli Greggio 86 Vercelli Guardabosone 81 Vercelli Lamporo 72 Vercelli Lenta 76 Vercelli Lignana 72 Vercelli Livorno Ferraris 72 Vercelli Lozzolo 81 Vercelli Mollia 85 Vercelli Moncrivello 79 Vercelli Motta dei conti 99 Vercelli Olcenengo 72 Vercelli Oldenico 103 Vercelli Palazzolo Vercellese 84 Vercelli Pertengo 77 Vercelli Pezzana 117 Vercelli Pila 90 Vercelli Piode 89 Vercelli Postua 62 Vercelli Prarolo 110 Vercelli Quarona 123 Vercelli Quinto Vercellese 80 Vercelli Rassa 86 Vercelli Rima San Giuseppe (Alto Sermenza) 98 Vercelli Rimasco (Alto Sermenza) 85 Vercelli Rimella 93 Vercelli Riva Valdobbia 87 Vercelli Rive 74 Vercelli Roasio 87 Vercelli Ronsecco 73 Vercelli Rossa 89 Vercelli Rovasenda 77 Vercelli Sabbia 56 Vercelli Salasco 72 Vercelli Sali Vercellese 72 Vercelli Saluggia 90 Vercelli San Germano Vercellese 72 Vercelli San Giacomo Vercellese 85 Vercelli Santhia' 72 Vercelli Scopa 73 Vercelli Scopello 84 Vercelli Serravalle Sesia 89 Vercelli Stroppiana 77 Vercelli Tricerro 78 Vercelli Trino 74 Vercelli Tronzano Vercellese 72 Vercelli Valduggia 133 Vercelli Varallo 48 Vercelli Vercelli 80 Vercelli Villarboit 83 Vercelli Villata 75 Vercelli Vocca 60 . -

Bando Di Concorso Generale Per L'assegnazione In
CITTÀ DI VERCELLI SETTORE POLITICHE SOCIALI E SICUREZZA TERRITORIALE BANDO DI CONCORSO GENERALE PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria AMBITO TERRITORIALE E REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO Possono presentare la domanda tutti i soggetti residenti da almeno 5 anni o che prestino la loro attività lavorativa da almeno 5 anni in uno dei Comuni compresi nell’ambito territoriale regionale n. 23: ALBANO VERCELLESE, ARBORIO, ASIGLIANO VERCELLESE, BORGO VERCELLI, CARESANA, CARESANABLOT, CASANOVA ELVO, COLLOBIANO, COSTANZANA, DESANA, FORMIGLIANA, GHISLARENGO, GREGGIO, LENTA, LIGNANA, MOTTA DE’ CONTI, OLCENENGO, OLDENICO, PERTENGO, PEZZANA, PRAROLO, QUINTO VERCELLESE, RIVE, RONSECCO, ROVASENDA, SALI VERCELLESE, S. GIACOMO VERCELLESE, STROPPIANA, TRICERRO, VERCELLI, VILLARBOIT, VILLATA, VINZAGLIO. I richiedenti e gli altri componenti il nucleo devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti, previsti dall’art. 3 della L.R. n. 3/2010: non essere titolari di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale; non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima superiore a: - 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone - 60 metri quadri per nucleo