Vittore Carpaccio Tra Narrazione E Devozione
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
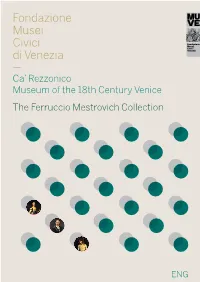
Ca' Rezzonico
Fondazione Musei Civici di Venezia — Ca’ Rezzonico Museum of the 18th Century Venice The Ferruccio Mestrovich Collection ENG da ballo MEZZANINE BROWNING / THE FERRUCCIO MESTROVICH COLLECTION Canal Grande The Collection The collection contains a nucleus his assets were confiscated by of sixteen paintings, all of high the Yugoslav government and never quality. returned. There are two major works by His son Audace worked for many Iacopo Tintoretto, an altar-piece of years in Venice as a lawyer. striking intensity and an austere His youngest son, Ferruccio, portrait. Particularly noteworthy a passionate scholar of early is a glowing and intimate “Sacra Veneto painting, is the donor of Conversazione” by Bonifacio de’ this collection: the attributions of Pitati; in addition, there are other the paintings are the result of his works by Benedetto Diana, Lelio research and studies; indeed, his Orsi, Jacopo Amigoni, Francesco suggestions and indications have Guardi and Alessandro Longhi, two assisted several scholars on many “soprarchi” (paintings above an occasions in the publication of his arch) by Benedetto Carpaccio, son paintings and other collections. and follower of Vittore and a small panel by Cima da Conegliano. The Mestrovichs belong to an ancient Dalmatian family originally from Zara and have lived in Venice since 1945. The head of the family, Aldo (1885-1969) was persecuted during the Austrian rule for his Ca’ Rezzonico, The Ferruccio Mestrovich Collection Italian patriotism; > 1 1. Benedetto Diana section of the polyptych frieze in the ITINERARY AND (Venice, 1460 ca. – 1525) San Francesco convent church in WORKS OF ART Christ Benedictory Miglionico, near Matera, taken there (oil on wood, 60 x 52,5 cm) at the end of the 16th century after being purchased in Venice by Don It’s a very interesting work of art Marcantonio Mizzoni. -

Rethinking Savoldo's Magdalenes
Rethinking Savoldo’s Magdalenes: A “Muddle of the Maries”?1 Charlotte Nichols The luminously veiled women in Giovanni Gerolamo Savoldo’s four Magdalene paintings—one of which resides at the Getty Museum—have consistently been identified by scholars as Mary Magdalene near Christ’s tomb on Easter morning. Yet these physically and emotionally self- contained figures are atypical representations of her in the early Cinquecento, when she is most often seen either as an exuberant observer of the Resurrection in scenes of the Noli me tangere or as a worldly penitent in half-length. A reconsideration of the pictures in connection with myriad early Christian, Byzantine, and Italian accounts of the Passion and devotional imagery suggests that Savoldo responded in an inventive way to a millennium-old discussion about the roles of the Virgin Mary and Mary Magdalene as the first witnesses of the risen Christ. The design, color, and positioning of the veil, which dominates the painted surface of the respective Magdalenes, encode layers of meaning explicated by textual and visual comparison; taken together they allow an alternate Marian interpretation of the presumed Magdalene figure’s biblical identity. At the expense of iconic clarity, the painter whom Giorgio Vasari described as “capriccioso e sofistico” appears to have created a multivalent image precisely in order to communicate the conflicting accounts in sacred and hagiographic texts, as well as the intellectual appeal of deliberately ambiguous, at times aporetic subject matter to northern Italian patrons in the sixteenth century.2 The Magdalenes: description, provenance, and subject The format of Savoldo’s Magdalenes is arresting, dominated by a silken waterfall of fabric that communicates both protective enclosure and luxuriant tactility (Figs. -

Le Due Culture Di Giovanni Buonconsiglio
©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte VITTORIO SGARBI LE DUE CULTURE DI GIOVANNI BUONCONSIGLIO IOVANNI Buonconsiglio detto il Marescalco è Brevi contributi si devono successivamente a Wart un pittore che è andato recuperando terreno Arslan nel 1956 4) e ad Alberto Martini, su tracce G negli ultimi anni sollecitando l'attenzione di longhiane, nel 1957· sl acuti conoscitori, dopo secoli di silenzio. Le tappe Gli anni sessanta registrano un rinnovamento del della critica moderna nella ricostruzione della sua l'interesse locale per il pittore con il catalogo del personalità entro il gruppo nutrito dei maestri belli Museo di Vicenza del Barbieri, del 1962, 6> e con il niani sono ascendenti: come se la focalizzazione della vasto saggio monografico di Lionello Puppi, del conoscenza garantisse al pittore il riconoscimento di 1964. 1> E non va neppure tralasciato l'intervento di meriti dimenticati, per l'alta qualità dei suoi negletti Heinemann, come sempre farraginoso, del 1962. a> risultati. IJ contributo del Puppi sembra porsi come defini Al primo posto in questo avanzamento della con tivo, ma gli anni settanta non mostrano minore siderazione critica sta, quasi inevitabilmente, Ro impegno sull'argomento, prima con l'articolo del berto Longhi il quale nel Viatico per cinque secoli Pallucchini su Arte Veneta nel 1973, 9l attraverso il di pittura veneziana, tl a recensione della grande quale ritorna in luce un importante dipinto inedito mostra del 1945, pur limitando fortemente il proprio firmato; subito dopo, nel 1974, con la tesi di laurea consenso, porrà le basi per la maturazione dell'in dello scrivente, tol e con la mostra padovana Dopo teresse intorno alla figura del pittore, con una pagina Mantegna le cui schede in catalogo si devono ancora e una nota dense di grande interesse: '' Quanto al Puppi. -

The Evolution of Landscape in Venetian Painting, 1475-1525
THE EVOLUTION OF LANDSCAPE IN VENETIAN PAINTING, 1475-1525 by James Reynolds Jewitt BA in Art History, Hartwick College, 2006 BA in English, Hartwick College, 2006 MA, University of Pittsburgh, 2009 Submitted to the Graduate Faculty of The Dietrich School of Arts and Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Pittsburgh 2014 UNIVERSITY OF PITTSBURGH KENNETH P. DIETRICH SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES This dissertation was presented by James Reynolds Jewitt It was defended on April 7, 2014 and approved by C. Drew Armstrong, Associate Professor, History of Art and Architecture Kirk Savage, Professor, History of Art and Architecture Jennifer Waldron, Associate Professor, Department of English Dissertation Advisor: Ann Sutherland Harris, Professor Emerita, History of Art and Architecture ii Copyright © by James Reynolds Jewitt 2014 iii THE EVOLUTION OF LANDSCAPE IN VENETIAN PAINTING, 1475-1525 James R. Jewitt, PhD University of Pittsburgh, 2014 Landscape painting assumed a new prominence in Venetian painting between the late fifteenth to early sixteenth century: this study aims to understand why and how this happened. It begins by redefining the conception of landscape in Renaissance Italy and then examines several ambitious easel paintings produced by major Venetian painters, beginning with Giovanni Bellini’s (c.1431- 36-1516) St. Francis in the Desert (c.1475), that give landscape a far more significant role than previously seen in comparable commissions by their peers, or even in their own work. After an introductory chapter reconsidering all previous hypotheses regarding Venetian painters’ reputations as accomplished landscape painters, it is divided into four chronologically arranged case study chapters. -

Iconic Ansel Adams Photographs and Rarely Seen Renaissance Paintings by Venice Masters at the North Carolina Museum of Art
FOR IMMEDIATE RELEASE December 1, 2016 MEDIA CONTACT Emily Kowalski | (919) 664-6795 | [email protected] Iconic Ansel Adams Photographs and Rarely Seen Renaissance Paintings by Venice Masters at the North Carolina Museum of Art Raleigh, N.C.—The North Carolina Museum of Art (NCMA) opens 2017 with two major exhibitions: one featuring the awe-inspiring work of Ansel Adams, and one showcasing masterpieces from Venice’s cultural Renaissance. Beginning February 4 the Museum presents Ansel Adams: Masterworks, 48 iconic photographs of American landscapes. One month later the Museum opens Glory of Venice: Renaissance Paintings 1470–1520, about 50 paintings by such masters as Giorgione, Giovanni Bellini, and Vittore Carpaccio, many of which have never been seen outside of Venice. The two exhibitions are ticketed together. “These two extraordinary exhibitions allow our visitors to explore the majesty of America and the splendor of Venice— all in one location,” says Lawrence J. Wheeler, director of the NCMA. “It will be an unforgettable and once-in-a-lifetime opportunity to view stunning photographs by the most well-known photographer of our time, and then walk to the next gallery to see rarely exhibited paintings from the most exciting period of Venice’s cultural history.” Ansel Adams: Masterworks February 4–May 7, 2017 East Building, Joyce W. Pope Gallery Ticketed with Glory of Venice In a career that spanned five decades, Ansel Adams (1902–84) became one of America’s most renowned photographers. This exhibition focuses on his “Museum Set,” a collection of 48 photographs carefully selected and printed by Adams. Adams designated these works late in his life as a succinct representation of the best work of his career. -

Tracing Paintings in Napoleonic Italy: Archival Records and the Spatial and Contextual Displacement of Artworks Nora Gietz Independent Scholar, [email protected]
Artl@s Bulletin Volume 4 Article 6 Issue 2 Art Traceability 2015 Tracing Paintings in Napoleonic Italy: Archival Records and the Spatial and Contextual Displacement of Artworks Nora Gietz independent scholar, [email protected] Follow this and additional works at: https://docs.lib.purdue.edu/artlas Part of the Ancient, Medieval, Renaissance and Baroque Art and Architecture Commons, Cultural History Commons, European History Commons, and the History of Christianity Commons Recommended Citation Gietz, Nora. "Tracing Paintings in Napoleonic Italy: Archival Records and the Spatial and Contextual Displacement of Artworks." Artl@s Bulletin 4, no. 2 (2016): Article 6. This document has been made available through Purdue e-Pubs, a service of the Purdue University Libraries. Please contact [email protected] for additional information. This is an Open Access journal. This means that it uses a funding model that does not charge readers or their institutions for access. Readers may freely read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of articles. This journal is covered under the CC BY-NC-ND license. Tracing Paintings in Napoleonic Italy: Archival Records and the Spatial and Contextual Displacement of Artworks Cover Page Footnote This article was borne out of research conducted for Nora Gietz’ PhD (University of Warwick, 2013), which was generously funded by the Gerda Henkel Stiftung, the Deutsches Studienzentrum Venedig, and the Gladys Krieble Delmas Foundation. She completed her BA at the University of Oxford (2007) and MA at the University of Warwick (2009). This article is available in Artl@s Bulletin: https://docs.lib.purdue.edu/artlas/vol4/iss2/6 Art Traceability Tracing Paintings in Napoleonic Italy: Archival Records and the Spatial and Contextual Displacement of Artworks Nora Gietz * Independent scholar, Venice Abstract Using a Venetian case study from the Napoleonic Kingdom of Italy, this article demonstrates how archival research enables us to trace the spatial life of artworks. -

DOSSIER PEDAGOGIQUE CIMA DA CONEGLIANO V3
CCIMAIMACIMA DA CONEGLIANO MMMAAAÎÎÎTRE DE LA RRRENAISSANCE VÉÉÉNITIENNE Exposition du 5 avril au 15 juillet 2012 DDDOSSIER PEDAGOGIQUE SOMMAIRE I)I)I) A propos de l’exposition page 2 II)II)II) Pistes pédagogiques et thématiques page 8 A/ Pour les classes du primaire page 8 B/ Pour les classes du collège et du lycée page 12 I) À propos de l’exposition Aux côtés de Giovanni Bellini et de Vittore Carpaccio, Giovanni Battista Cima da Conegliano (1459-1517) compte parmi les grands peintres qui travaillent à Venise à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, à l’époque où la ville devient un des pôles les plus brillants de la Renaissance italienne. À Venise, Cima s’impose très vite comme le maître des grands retables en explorant des effets de composition inédits, où se mêlent de manière originale nature et architecture. Il introduit des asymétries et des échappées insolites, ménage des ouvertures surprenantes, comme dans la Vierge à l’Enfant entre l’archange saint Michel et l’apôtre saint André (Parme, Galleria Nazionale). Partout apparaît son amour des vastes étendues, exaltées par la lumière, encadrées de montagnes et de collines, qui évoquent les reliefs caractéristiques de sa région natale. A la peinture de paysage, il donne un souffle nouveau. Nul autre avant Cima, n’a su rendre l’atmosphère argentée et légère de la Vénétie avec cette poésie qui n’appartient qu’à lui. La vie de Giovanni Battista Cima est celle d’un jeune homme sorti du lot, porté par son talent à faire une carrière remarquable. -

Summary for Contini Bonacossi, Alessandro, June 30, 1954
KRESS COLLECTION DIGITAL ARCHIVE Contini Bonacossi, Alessandro, June 30, 1954 IDENTIFIER ACQ159 SELLER DATE Contini Bonacossi, Alessandro 06/30/1954 NUMBER OF OBJECTS GROUP PURCHASE PRICE 16 $1,900,000.00 FINAL PAYMENT DATE SELLER LOCATION 01/31/1957 Florence, Italy CITATION Series 1.7b Dealer Correspondence and Bills of Sale. Samuel H. Kress Foundation Archive. 16 RELATED ART OBJECTS NATIONAL GALLERY OF ART, WASHINGTON, DC, GALLERY ARCHIVES Page 1 KRESS COLLECTION DIGITAL ARCHIVE K2061 Andrea Solario Lamentation National Gallery of Art, Washington, District of Columbia Type: purchase Attribution History: Acquired as Altarpiece Deposition by Andrea Solario Note: Purchased as one of 16 objects for the total price of $1,900,000. Individual prices were not assigned to the objects. K2062 Giovanni Girolamo Savoldo Elijah Fed by the Raven National Gallery of Art, Washington, District of Columbia Type: purchase Attribution History: Acquired as Elijah Fed by the Raven by Giovanni Girolamo Savoldo Note: Purchased as one of 16 objects for the total price of $1,900,000. Individual prices were not assigned to the objects. K2064 Jacopo Tintoretto The Conversion of Saint Paul National Gallery of Art, Washington, District of Columbia Type: purchase Attribution History: Acquired as The Conversion of Saint Paul by Jacopo Tintoretto Note: Purchased as one of 16 objects for the total price of $1,900,000. Individual prices were not assigned to the objects. K2065 Jacopo Tintoretto Portrait of a Lady North Carolina Museum of Art, Raleigh, North Carolina Type: purchase Attribution History: Acquired as Portrait of a Lady with White Collar by Tintoretto (Domenico Robusti) Note: Purchased as one of 16 objects for the total price of $1,900,000. -

Cima Da Conegliano La Natura Sugli Altari
26 Venerdì 16 aprile 2010 Artista stupefacente per i colori scintillanti e per gli scenari naturalistici, eppure «segnato» dalla contiguità con altri più apprezzati (come il Bellini). La sua novità di CLARA GELAO ARTE DEL RINASCIMENTO IL SUO PAESE DI ORIGINE, NEL TREVIGIANO, GLI DEDICA UNA BELLA RASSEGNA, CON MOLTE STUPENDE PALE DI ALTARE i sono artisti che nascono «segnati», per così dire, nel bene e nel male, dalla loro contemporaneità o contiguità rispetto C ad altri, ai quali la storia ha decretato un più vasto, universale apprezzamento. Giambatti- sta Cima da Conegliano, stretto tra Giovanni Bel- lini, Alvise Vivarini e, in parte, Giorgione, è si- curamente tra questi e a lui la storia dell’arte, pur Cima da Conegliano riconoscendo l’altissimo magistero tecnico della sua pittura, ha per lo più assegnato un ruolo da c o m p r i m a r i o. Non è la prima volta che il Veneto dedica una mostra a questo maestro (si può ricordare quella, memorabile, di Treviso del 1962), ma l’esposizione attualmente in corso in Palazzo Sarcinelli a Co- negliano Veneto (uno di quei paesi rimasti quasi miracolosamente intatti, dove può capitare per- la natura sugli altari sino, in certe ore del giorno, di sentire l’eco dei propri passi sull’acciottolato delle strade del cen- tro storico) si propone di offrire una nuova lettura La mostra del grande pittore veneto, «poeta del paesaggio» del maestro veneto, cercando di metterne in luce la specifica cifra espressiva e l’apporto personale rispetto ai temi più ricorrenti nella pittura sacra e losità e le durezze d’ebano di Alvise Vivarini, librio compositivo conferito dall’artista alle sue devozione privata - pur riprodotte ed esaminate nel profana dell’epoca e ai modi, anche materiali, con sicuramente uno dei punti di riferimento della sua c re a z i o n i . -

VENICE ITINERARIES CONTENTS Introduction 1 Early Renaissance
VENICE ITINERARIES CONTENTS Introduction 1 Early Renaissance Venice (1350-1480) 1 Venice ca. 1480-1540 3 Venice ca. 1540-1600 6 INTRODUCTION Above all, these itineraries are intended to be enjoyable. They are also a way in which you can get to know Venice better. Each itinerary matches a seminar and you may like to visit some of these places before the seminar. Particularly important items are marked with an *. Buildings on the Canal Grande are listed with the nearest vaporetto stop. For further details, the following guidebooks are recommended: Buckley, Jonathan, The Rough Guide to Venice and the Veneto, 5th ed. (London, 2001) Honour, Hugh, The Companion Guide to Venice (London, 1997) Lorenzetti, Giulio, Venice and its Lagoon, trans. J. Guthrie (Trieste, 1994) Macadam, Alta, Venice, Blue Guide, 7th ed. (London, 2001) Various, Venezia, Touring Club Italiano, 3rd ed. (Milan, 1985) Zucconi, Guido, Venice: An Architectural Guide, trans. A. Shugaar (Venice, 1995) EARLY RENAISSANCE VENICE (1350-1480) The Canal Grande Depositi del Megio (San Stae) *Ca’ d’Oro (Ca’ d’Oro) Palazzo Sagredo (Ca’ d’Oro) *Palazzo Bernardo (San Silvestro) *Ca’ Foscari (Ca’ Rezzonico) Palazzi Giustinian (Ca’ Rezzonico) Palazzo Loredan dell’Ambasciadore (Ca’ Rezzonico) 2 *Palazzo Contarini Fasan (Santa Maria del Giglio) *Palazzo [Ca’] Giustinian (San Marco Calle Vallaresso) Sestiere di San Marco San Marco. Interior: Cappella della Madonna dei Mascoli, *mosaics. Palazzo Ducale. Exterior: *western facade (towards the Piazzetta); *Porta della Carta. Interior: Museo dell’Opera, *original capitals and columns; *Sala del Guariento. Museo Correr. Interior: *works by Paolo Veneziano, Lorenzo Veneziano, Jacobello delle Masegne, Stefano Veneziano, Michele Giambono, Jacobello del Fiore, Bartolomeo Vivarini, Gentile Bellini, and Giovanni Bellini. -

The Cult and Repersentation of the Archangel Raphael in Sixteenth-Century Venice
The Cult and Representation of the Archangel Raphael in Sixteenth-Century Venice Joseph Hammond For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways Psalm 91:11 Today the concept of the guardian angel tends to be thought of as an ‘old’ idea, but there is little indication that the belief achieved any widespread liturgical or artistic attention before around 1600. However, the largely forgotten cult of the Archangel Raphael, to which the concept of the guardian angel is closely linked, predates it by some length. This article considers how popular devotion to one specific angel developed into a more general belief in angelic intervention, through an examination of the iconography associated with the Archangel Raphael in sixteenth-century Venice. The understanding and representation of the role of guardian angels is examined, and I show how the imagery developed from the iconography of Raphael and his relationship with his attribute Tobias. In addition, I examine how the effect of Protestant criticism of the cult of saints — of angels in particular — and the efficacy of prayer affected the cult of Raphael and the saint’s representation in Venice. The Archangel Raphael is mentioned by name only in the deutrocanonical book of Tobit.1 There he is described as being disguised as a human and accompanies the young Tobias and his dog on a journey to reclaim some borrowed money for Tobit, Tobias’ father, who is old, blind and poor. Along the way they catch a monstrous fish and then use its heart and liver to banish a demon from Sarah, who is then given in matrimony to Tobias. -

Syllabus, Art in Venice, 2020
Columbia University – Summer Program in Venice Summer 2020 Art in Venice – AHIS O4430 Venice's unique geographical location in the reflective waters of the Adriatic and at the crossroads between East and West has had a profound impact on all aspects of Venetian life and culture. This course will investigate the artistic production of the Lagoon City between the fourteenth and eighteenth centuries. The compelling works of Venetian artists, such as Carpaccio, Bellini, Giorgione and Titian, Tintoretto and Veronese, as well as the great civic and religious monuments, including the Palazzo Ducale, the great mendicant churches, and the Basilica di San Marco, will be considered in light of the sophisticated political and social systems of the Venetian Republic. Issues such as the development of the distinctive urban fabric, the invention of a civic iconography, the role of the artist, and the Venetian workshop practices, as well as the impact of the Islamic world, and private and corporate patronage, will be examined. INSTRUCTOR Caroline A. Wamsler COURSE DURATION, MEETING TIMES AND MEETING LOCATIONS Between June 9 and July 18, 2019 Tuesdays: 9:00am – ca. 3:30pm Thursdays: 9:00 – 11:00am Location – Each session listed below identifies the meeting location. NOTE: Please review the exact time and location information included in this syllabus carefully and stay posted for changes as we might need to make adjustments. Please arrive on time, as we will often move to another location shortly after gathering. COURSE REQUIREMENTS, GRADING, AND CLASS AND UNIVERSITY POLICIES Attendance: The success of this course will depend on the participants’ presence and active participation.