Medioevo (476
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Frascati Da Famiglia Nomade a Pag
GRATUITO Il Caffè non riceve n. 482 - dal 28 febbraio al 6 marzo 2019 contributi pubblici per l'editoria tel. 06.92.76.222 - 06.92.85.90.20 - [email protected] - GRATUITO ALBANO Certificati medici falsi Mancano 64 milioni per per la licenza di caccia completare l’ospedale La nuova struttura sanitaria, inaugurata a la grave carenza di posti letto e personale. Per portare a pieno regime il nuovo ospedale dicembre scorso, rischia di trasformarsi in Ma il capo della Asl Roma 6, Narciso Mo- dei Castelli devono essere attivati 208 posti letto una cattedrale nel deserto. I medici e gli in- starda, e l’assessore regionale alla Sanità, fermieri che vi lavorano ed i cittadini che la Alessio D’Amato, ancora non hanno dato ed assunti non meno di 250 nuovi dipendenti frequentano quotidianamente lamentano risposte convincenti in merito... a pag. 2 In tre procuravano certificati falsi in cambio di somme di denaro RESTAURATA LA CARROZZINA DEI CHIGI a pag. 18 Comitati di quartiere: LANUVIO «La Asl cambi sede» 27 cani tra sporcizia e I cittadini di Albano chiedono ad Asl e degrado, un denunciato Municipio di cambiare le rispettive sedi a pag. 3 a pag. 29 CIAMPINO Centro di oncologia Casa popolare occupata clinica a Frascati da famiglia nomade a pag. 6 Sequestrato un appartamento Ater La carrozzina da passeggio della famiglia Chigi, ora esposta a Palazzo Chigi, è tornata all’antico splendore grazie alle sapienti mani dell’artigiano Carmine Abbate (in foto) che l’ha restaurata a pag. 24 occupato da famiglia Casamonica a pag. 10 SENZA COSTO Il maltempo ha sradicato molti alberi ai Castelli, alcuni dei quali secolari VIA CISTERNENSE Auto a fuoco vicino ad SENZA CASTA Strage di alberi una pompa di benzina Il giornale Il Caffè non ti costa nulla, abbattuti dal non prende contributi forte vento per l’editoria ed è Alberi crollati in strada hanno bloccato indipendente dalle lobby il traffico a Velletri, Marino, Nemi e.. -
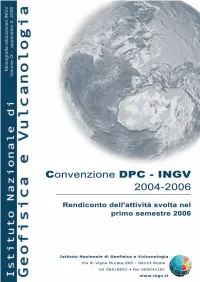
Rapporto Isemestre2006.Pdf
Direttore Responsabile: Enzo Boschi Coordinamento Editoriale: Edoardo Del Pezzo, Antonio Meloni, Gianluca Valensise Redazione Testi: Giuseppe Di Capua Progetto Grafico: Laboratorio Grafica e Immagini - INGV Roma Progetto Editoriale: Francesca Di Stefano - Centro Editoriale Nazionale - INGV Roma © 2006 INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma Tel. 06/518601 Fax 06/5041181 http://www.ingv.it Sommario Introduzione ________________________________________________________________ 7 VOCE A: ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA___________________________ 11 Vulcani siciliani_____________________________________________________________ 13 Introduzione_________________________________________________________________ 13 Monitoraggio vulcanologico _____________________________________________________ 15 Monitoraggio sismico__________________________________________________________ 16 Monitoraggio delle deformazioni del suolo__________________________________________ 16 Attività di sala operativa ________________________________________________________ 18 Sorveglianza sismica del territorio nazionale ____________________________________ 21 Introduzione_________________________________________________________________ 21 Servizio di sorveglianza sismica _________________________________________________ 22 Analisi dei dati: il Bollettino della Sismicità Italiana____________________________________ 25 La manutenzione ordinaria e straordinaria della Rete Sismica Nazionale, della Rete Mednet e delle altre -

Rimodulazione Del Servizio Ardea Dlgs 50.2016
RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI ARDEA: LINEE GUIDA Anni scolastici : dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2023 0 INDICE 1. Premessa………………………………………………………………………………………………..……..2 2. L’organizzazione attuale del servizio di trasporto scolastico…………..………………3 3. Finalità del servizio di trasporto scolastico in gara ........................................... 4 4. Iscritti e plessi di riferimento..............................................................................5 5. Organizzazione del servizio ...............................................................................7 6. Caratteristiche generali del servizio - nuova strutturazione ......................... 10 6.1. Personale di accompagnamento ............................................................... 15 6.2. Tariffe del Servizio...................................................................................... 15 6.3. Pagamenti ................................................................................................. 16 6.4. Rischi da Interferenze - DUVRI ...................................................................16 7. Analisi del costo chilometrico ……………………….............................................. ..17 8. Quadro economico………………………………………..................................................18 9. Scelta della procedura di gara e criterio di aggiudicazione..............................19 1 Relazione sul progetto di rimodulazione per l’appalto del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia, -

Pdf Guida Turistica IT/EN (9.47
Città di Castel Gandolfo Assessorato al Turismo e Attività Produttive cittàCastel Gandolfodi Realizzato dal Comune di Castel Gandolfo con il contributo della Provincia di Roma My Kaywa QR-Code Pubblicazione a www.castelliromanigreentour.itcura dell’associazione Castelli Romani Green Tour www.castelliromanigreentour.it [email protected] Progettohttp://kaywa.me/GY4OD grafico e foto: Gianna Petrucci Progetto editoriale e contenuti: Daniela Da Milano Downloadcoordinamento: the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code! Jessica Proietti Stampa: Uffigraf di Properzi Mario Castel Gandolfo (Rm) Presso i stabilimenti tipografici Quadrifoglio Albano Laziale cittàCastel Gandolfodi Provincia/Province: Roma Prefisso/area code: +39 06 CAP/Zip code: 00040 Coordinate/Coordinates 41° 44’ 48.29’’ N - 12° 39’ 2.11’’ E Altitudine/Altitude 426 m s.l.m./above see level Superficie/Area 14,71 km² Abitanti/Residents: 9.037 (31-12-2010) Frazioni/Localities: Mole di Castel Gandolfo, Pavona Confini/Boundaries: Albano Laziale, Grottaferrata, Marino, Rocca di Papa, Roma Nome abitanti/inhabitants: castellani Patrono/Patron saint: san Sebastiano Giorno festivo/Public holiday: 20 gennaio sito istituzionale/website: www.comune.castelgandolfo.rm.it E821 Roma- San Cesareo Roma Come arrivare Rome via Tuscolana In auto: Prendere la SS 7 Appia nuova (uscita n. 23 del G.R.A.), da qui seguire le indicazioni per Castel Gandolfo. In treno: Dalla Stazione Termini prendere la linea via Anagnina Monte Porzio Catone per Albano Laziale e scendere alla fermata di Castel Gandolfo. Frascati In bus: Da Roma prendere la Metro A con fermata via Appia Nuova Montecompatri ad Anagnina; da qui proseguire con le autolinee Rocca Priora CO.TRA.L linea Roma - Castel Gandolfo. -

Castel Gandolfo (Rm) – Albano Laziale (Rm)
1 Norme tecniche allegate alla DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO ai sensi degli artt. 136 comma 1, lettere c) e d) del Dlgs 42/2004 MARINO (RM) – CASTEL GANDOLFO (RM) – ALBANO LAZIALE (RM) La Campagna Romana tra la via Nettunense e l’Agro Romano (Tenuta storica di Palaverta, Quarti di S. Fumia, Casette, S. Maria in Fornarolo e Laghetto) Le presenti norme integrano nell'area, perimetrata dalla Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico denominata “La Campagna Romana tra la via Nettunense e l’Agro Romano” ricadente nei Comuni di Marino, Castel Gandolfo e Albano Laziale, le corrispondenti norme tecniche di attuazione del P.T.P.R. della Regione Lazio adottato con atti della Giunta Regionale n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007 e pubblicato sul Supplemento n° 14 al B.U.R. Lazio n° 6 del 14 febbraio 2008 e successivi aggiornamenti. Gli obiettivi di tutela della presente Dichiarazione sono conformati a quanto indicato nell’art. 135, comma 4 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lgs 42/20047: - la conservazione degli elementi costituitivi e delle morfologie dei beni paesaggistici esistenti, tenendo presenti le numerose valenze architettoniche e archeologiche e le tecniche e i materiali costruttivi delle preesistenze, con particolare attenzione alle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici; - la compatibilità delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati. In particolare, le specifiche caratteristiche del territorio in esame, nel quale assume grande rilievo la tutela del paesaggio rurale, richiedono di considerare in modo integrato vari aspetti: il tipo e le modalità delle coltivazioni, il patrimonio edilizio esistente, il paesaggio archeologico diffuso e le produzioni tradizionali collegate. -

Dietary Fluoride Intake by Children: When to Use a Fluoride Toothpaste?
International Journal of Environmental Research and Public Health Article Dietary Fluoride Intake by Children: When to Use a Fluoride Toothpaste? Adriano Casaglia 1 , Maria Antonietta Cassini 1,*, Roberta Condò 1 , Flavia Iaculli 2,3 and Loredana Cerroni 1 1 Department of Clinical Science and Translational Medicine, University of Rome Tor Vergata, Via Montpellier 1, 00133 Rome, Italy; [email protected] (A.C.); [email protected] (R.C.); [email protected] (L.C.) 2 Department of Oral and Maxillofacial Science, Sapienza University of Rome, Via Caserta 6, 00161 Rome, Italy; fl[email protected] 3 Department of Neuroscience and Reproductive and Odontostomatological Sciences, University of Naples “Federico II”, Via Pansini 5, 80131 Naples, Italy * Correspondence: [email protected]; Tel.: +39-349-7924926 Abstract: Fluoride is recommended for its cariostatic effect, but excessive fluoride intake may have health risks. Increased prevalence of dental fluorosis in areas with low fluoride content in drinking water has been attributed to the inappropriate excessive intake of fluoride supplements (tablets and drops) and toothpaste ingestion. The aim of the present study was to estimate the fluoride intake and the risk of fluorosis in children (6 months–6 years) in the Castelli Romani area (province of Rome, Italy), which is volcanic, therefore with a higher concentration of fluorine. Measurements of the fluoride content in drinking water, mineral waters, vegetables and commercial toothpaste for children were performed. The fluoride concentrations of all samples were determined using a Fluoride Ion Selective Electrode (GLP 22, Crison, Esp). Data were analyzed by descriptive statistics. Differences between samples were determined by Student’s t-test. -

Handout Directions ≥ 30 Sales Meeting
SALES MEETING 2021 DIRECTIONS ≥ 30 ROME, ITALY, 07-10 September ume Tevere FL3 ROMA Viterbo Viterbo FL1 Orte Viterbo Sacrofano Montebello Fara Sabina - Montelibretti La Giustiniana Piana Bella di Montelibretti Bracciano Prima Porta La Celsa Monterotondo - Mentana Vigna di Valle Labaro Settebagni Anguillara Centro Rai ARE Fidene NUL O A Cesano RD CO Saxa Rubra AC E R G ND Nuovo RA Olgiata RA ND G Grottarossa E Salario RA CC La Storta - Formello OR Due Ponti DO Due Ponti A N METRO ROME U La Giustiniana LA ume Tevere R Tor di Quinto E Ipogeo degli Ottavi Monte Antenne Mancini 2 Ottavia Jonio 2 Campi Sportivi Conca San Filippo Neri Conca d’Oro Acqua Acetosa d’Oro Monte Mario Libia 2 Gemelli Euclide Nomentana Balduina S.Agnese Rebibbia Appiano 19 3 Annibaliano Proba Petronia Ottaviano Valle Giulia 3.19 Ponte Mammolo VALLE TIBURTINA Monti S.Pietro 19 Tiburtini Battistini Cornelia AURELIA Musei Vaticani FLAMINIO Santa Maria del Soccorso Piazza del Popolo BOLOGNA Quintiliani Pietralata Baldo Cipro Lepanto 2 degli 19 Spagna Castro Policlinico Ubaldi Risorgimento Pretorio 3.19 RepubblicaRepubblica Palmiro La Rustica Teatrro OperaOpera Prenestina Togliatti Città Salone Lunghezza Aurelia Barberini Fontana Trevi TERMINI ume Tevere Tor Sapienza La Rustica Ponte FL5 SAN PIETRO 3.19 Serenissima FL2 5 14 UIR di Nona Civitavecchia Laziali Tivoli Grosseto Cavour Avezzano 8 S.Bibiana Vittorio Venezia 8 Emanuele Porta Maggiore Due Leoni/Fontana Candida Monte Compatri/Pantano Colosseo 3 5.14 Ponte Casilino 5.14.19 14 Manzoni 14 Vle P.Togliatti Museo della Liberazione3 -

COMUNE DI CASTEL GANDOLFO (Città Metropolitana Di Roma Capitale)
COMUNE DI CASTEL GANDOLFO (Città metropolitana di Roma Capitale) Ordinanza N. 76 Data di registrazione 08/11/2020 SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI OGGETTO: PAVONA LAGHETTO E MOLE - CASTEL GANDOLFO. Rammentato che: - l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; - con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01 febbraio 2020, è stata attivato lo stato di emergenza sull’intero territorio nazionale; Visto il Decreto Legge 07 ottobre 2020 n. 225, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021; Viste: - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 413/2020 con la quale la Regione Lazio ha definito il calendario scolastico stabilendo l’avvio delle lezioni a far data dal 14/09/2020; - le linee guida per riapertura della scuola (ovvero “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”) emanate dal Ministro dell’Istruzione in data 26/06/2020; - le “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato” di cui al D.P.C.M. 07/09/2020; Vista la comunicazione prot. -

Albano Laziale/Castel Gandolfo
< E S S ROMA S.S V . L R . P S I V GANDOLFO . O A O . N N . GANDOLFO I M . V M A M . ROMA CASTEL CA N O D T 7 ARINO 2 I A . I E P V TA VI IC LET 1 A STEL S. FUMIA R IET A M V . VIL 2 I I R I V A 6 P R V AR ia Co 0 A S I A M LETT 7 A VIA VIL VIA SANTA FUMIA O A INO V G C T A I I A N N lle Pic A Regione A L LLE N D CIAMPINO VIA CO O A T T A I L S.M. D. MOLE EL I T NG T E D MARINO T’A S A O R R E E S A N L R Lazio E L R ROMA I D L c A L A I L hione I V D I G V B A G V E A E I I C M I . APPIA I T O LE OR E M G V V L A O O R A L E . Sepolcro di T C A D E R T T Clodio I TA E DETT E I L ELLE VIO H A N StatoStato delladella I G E Provincia D L B A V D CA L A E VIA E O L E T LE M R CittàCittà deldel S L V ME T L I A D E L L E V D di Roma L I E E . -

Transito Pullman in Orario Di Ingresso a Scuola
TRANSITO PULLMAN IN ORARIO DI INGRESSO A SCUOLA Partenza Arrivo Percorso Ora partenza Ora arrivo Instradamento Nome transito Ora transito Stagionalità Frequenza Orario di Entrata VELLETRI FS FRASCATI VL029A 07.40 08.51 GENZANO-ALBANO LAZIALE-CASTELGANDOLFO /MARIAPOLI-MARINO- ALBANO LAZIALE 08.20 SCOLASTICO LMMGV--- Entrata h 9:00 B GROTTAFERRATA- C ROCCA PRIORA ALBANO LAZIALE SG855D 07.40 08.21 MONTECOMPATRI-FRASCATI OSPEDALE-MARINO- ALBANO LAZIALE 08.21 LOTTO LTA1BIS LMMGV--- Entrata h 9:00 FRASCATI VELLETRI FS CN028D 07.50 09.00 GROTTAFERRATA-MARINO-CASTELGANDOLFO /MARIAPOLI-ALBANO ALBANO LAZIALE 08.21 SCOLASTICO LMMGV--- Entrata h 9:00 C LAZIALE-GENZANO LICEO- ROCCA PRIORA ALBANO LAZIALE SG647D 07.30 08.25 BUERO-FRASCATI VILLA CAVALLETTI-FRASCATI-GROTTAFERRATA- ALBANO LAZIALE 08.25 SCOLASTICO LMMGV--- Entrata h 9:00 C MARINO- B LARIANO (P.ZA BRASS) ROMA ANAGNINA SG682A 07.40 09.15 VELLETRI-GENZANO-ALBANO LAZIALE-FRATTOCCHIE- ALBANO LAZIALE 08.27 SCOLASTICO LMMGV--- Entrata h 9:00 A ROMA ANAGNINA VELLETRI FS CN01D 08.00 09.12 FRATTOCCHIE-ALBANO LAZIALE-GENZANO LICEO- ALBANO LAZIALE 08.29 SCOLASTICO LMMGV--- Entrata h 9:00 C FRASCATI GENZANO LICEO CN128D 08.10 08.43 GROTTAFERRATA-MARINO-ALBANO LAZIALE- ALBANO LAZIALE 08.32 LOTTO LTA1BIS LMMGV--- Entrata h 9:00 FRASCATI VELLETRI FS CN028D 08.05 09.18 GROTTAFERRATA-MARINO-CASTELGANDOLFO /MARIAPOLI-ALBANO ALBANO LAZIALE 08.36 SCOLASTICO LMMGV--- Entrata h 9:00 C LAZIALE-GENZANO LICEO- B LATINA ROMA ANAGNINA CN907D 07.15 09.03 CISTERNA-VELLETRI FS-VELLETRI-GENZANO-ALBANO LAZIALE- ALBANO -

Ardea: Politica Tra Incendi E Tribunali E Incendi Tra Politica Ardea: Boom O Flop? Dovrebbe Aprire Il 29 Maggio Ancora Appese Ancora Di Elezioni Ardea
n. 285 - dal 13 al 26 marzo 2014 - tel. 06.92.76.222 - [email protected] - GRATUITO di ARDEA-POMEZIA POMEZIA Quell’influenza di Grillo Ardea: politica tra incendi e tribunali sul Sindaco Fabio Fucci Sindaco Di Fiori rinviato a giudizio. Bruciata l’auto all’assessore Petricca Non trova pace la politica ad Ardea. Il Sindaco, ha chiesto la convocazione di un consiglio comu- l’assessore Petricca ed altre 9 persone sono state nale durante il quale presentare una mozione di rinviate a giudizio dal Tribunale di Velletri per la sfiducia verso il Sindaco. gestione degli appalti al Cimitero di Ardea. Di Ma non basta. L’auto dell’assessore Petricca è Fiori si dichiara innocente, Petricca addirittura andata completamente distrutta in un incendio estraneo ai fatti: giustificazioni che non hanno doloso: è l’ennesimo esponente politico vittima Assessore placato la sete di giustizia dell’opposizione, che di intimidazioni. Nicola Petricca a pag. 6 Storace alla Regione: tutelare l’au- “SEI DI POMEZIA SE...”: I RICORDI SU FACEBOOK tonomia del Sindaco dal comico Elezioni di Ardea a pag. 11 ancora appese SANITÀ Il Consiglio di Stato vuole far luce sulle Asl Rm H indebitata: contestate consultazioni del maggio 2012 obbligata a pagare a pag. 21 Il Tar condanna l’azienda sanitaria a saldare 3,5 milioni ai debiti Cinecittà World a pag. 26 ARDEA I residenti del lungomare tra rabbia e insicurezza Più di tremila iscritti al gruppo sul social network per rievocare la Pomezia di una volta attraverso foto e commenti: i luoghi, Boom o flop? Dovrebbe aprire il 29 maggio i personaggi, gli scorci e le mode che non ci sono più da pag. -

Indagini Geomitologiche Sul Bacino Idrografico Del Fosso Dell'incastro (RM). Il Mito Dell'antico Fiume Numico Geomythologica
Mem. Descr. Carta Geol. d’It. XCVI (2014), pp. 145-168 figg. 9 Indagini Geomitologiche sul bacino idrografico del Fosso dell’Incastro (RM). Il mito dell’antico fiume Numico Geomythological investigations on the hydrographic basin of Fosso dell’Incastro (RM). The myth of the ancient Numico river AVERSA M. (*), SERA A. (**) RIASSUNTO - La presente indagine si è proposta di investigare tro basin – located in the surroundings of Ardea, a small sui rapporti ambientali esistenti tra le evidenze storico-ar- town near Rome - and the physical elements of hydrograph- cheologiche attualmente riscontrabili nel comprensorio fisico ical and hydrological history of morphological evolution; the del bacino idrografico del Fosso dell’Incastro (RM), con molta latter are likely related to a potential activity of the Colli Al- probabilità coincidente con il misterioso e non ancora ben bani’s composite strato-volcano. The enduring traces of the individuato antico Fiume Numico, e gli oggettivi elementi fi- coexistence between Man and Volcano were analyzed in the sico-areali di evoluzione morfologica. Tali particolari feno- archaeological, historical and mythological works of the an- meni naturali, legati a determinate evidenze quali quelle cient writers. The attention has been focused on the exami- correlabili alla possibilità dell’essersi verificato, in epoca sto- nation of a restricted hydrological area, the Fosso dell’In- rica, qualche evento geofisico connesso alla articolata pre- castro basin, considered as a geographical and physical rep- senza “vivente” del grande complesso del Vulcano Albano, resentative unit. The ultimate aim of the investigation was meglio conosciuto come apparato dei Colli Albani, sono stati to set up and develop a research method that could enable connessi alle informazioni storico-mitologiche a noi perve- the identification of a potential catastrophic event occurred nute.