Massalengo Provincia Di Lodi
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

NABA CALL for the ASSIGNMENT of FINANCIAL AID (DIRITTO ALLO STUDIO) BENEFITS Academic Year 2020/2021 – ACADEMIC YEAR 2020/2021
NABA CALL FOR THE ASSIGNMENT OF FINANCIAL AID (DIRITTO ALLO STUDIO) BENEFITS Academic Year 2020/2021 – ACADEMIC YEAR 2020/2021 Milan, 21st July 2020 – Prot. Nr. 46/2020 (TRANSLATION OF THE DSU NABA APPLICATION REQUIREMENTS AND REGULATIONS In case of discrepancies between the Italian text and the English translation, the Italian version prevails) CONTENTS 1) NABA SERVICES IMPLEMENTING THE RIGHT TO UNIVERSITY EDUCATION 3 2) ALLOCATION OF SCHOLARSHIPS 3 2.1) STRUCTURE AND NUMBER OF SCHOLARSHIPS 4 2.2) GENERAL TERMS AND CONDITIONS 5 2.3) SCHOLARSHIP ALLOCATION CLASSIFICATION LIST ADMITTANCE REQUIREMENTS 6 2.3.1) MERIT-BASED REQUIREMENTS 6 2.3.2) INCOME-BASED REQUIREMENTS 9 2.3.3) ASSESSMENT OF THE FINANCIAL STATUS AND ASSETS OF FOREIGN STUDENTS 9 2.4) SCHOLARSHIP TOTAL AMOUNTS 10 3) SCHOLARSHIP FINANCIAL SUPPLEMENTS 12 12 3.1) STUDENTS WITH DISABILITIES 3.2) INTERNATIONAL MOBILITY 12 4) DRAWING UP OF CLASSIFICATION LISTS 13 5) APPLICATION SUBMISSION TERMS AND CONDITIONS 14 6) PUBLICATION OF PROVISIONAL CLASSIFICATION LISTS AND SUBMISSION OF APPEALS 15 6.1) INCLUSION OF STUDENTS IN THE CLASSIFICATION LISTS 15 6.2) PUBLICATION OF THE CLASSIFICATION LISTS AND SUBMISSION OF APPEALS 16 7) TERMS OF SCHOLARSHIP PAYMENTS 16 8) INCOMPATIBILITY – FORFEITURE – REVOCATION 18 9) TRANSFERS AND CHANGES OF FACULTY 18 10) FINANCIAL STATUS ASSESSMENTS 19 11) INFORMATION NOTE ON THE USE OF PERSONAL DATA AND ON THE RIGHTS OF THE DECLARANT 19 ANNEX A - LIST OF COUNTRIES RELATING TO THE LEGALISATION OF DOCUMENTS 22 ANNEX B – LIST OF MUNICIPALITIES RELATING TO THE DEFINITION OF COMMUTING STUDENTS 28 Financial Assistance Selection Process - A.Y. -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2007
Ufficio del territorio di LODI Data: 19/10/2007 Ora: 14.43.16 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2007 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.64 del 31/01/2007 n.10 del 09/03/2007 REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 PIANURA DI LODI (27 COMUNI) PIANURA DI CODOGNO (19 COMUNI) Comuni di: ABBADIA CERRETO, BOFFALORA D`ADDA, BORGO SAN Comuni di: BERTONICO, BORGHETTO LODIGIANO, BREMBIO, GIOVANNI, CASALETTO LODIGIANO, CASALMAIOCCO, CASELLE CAMAIRAGO, CASALPUSTERLENGO, CASTIGLIONE D`ADDA, LURANI, CASTIRAGA VIDARDO, CERVIGNANO D`ADDA, COMAZZO, CAVACURTA, CAVENAGO D`ADDA, CODOGNO, GRAFFIGNANA, CORNEGLIANO LAUDENSE, CORTE PALASIO, CRESPIATICA, LIVRAGA, MAIRAGO, MALEO, MASSALENGO, OSSAGO LODIGIANO, GALGAGNANO, LODI, LODI VECCHIO, MARUDO, MERLINO, SECUGNAGO, TERRANOVA PASSERINI, TURANO LODIGIANO, TAVAZZANO VILLAVESCO, MONTANASO LOMBARDO, VILLANOVA DEL SILLARO MULAZZANO, PIEVE FISSIRAGA, SALERANO SUL LAMBRO, SAN MARTINO IN STRADA, SANT`ANGELO LODIGIANO, SORDIO, VALERA FRATTA, ZELO BUON PERSICO COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) BOSCO 18700,00 2-VALORE RIFERITO AL 18700,00 2-VALORE RIFERITO AL TERRENO NUDO, IL TERRENO NUDO, IL SOPRASSUOLO DOVRA` SOPRASSUOLO DOVRA` ESSERE STIMATO A PARTE) ESSERE STIMATO A PARTE) COLTURE FLOROVIVAISTICHE 96300,00 2-VALORE RIFERITO AL 96300,00 2-VALORE RIFERITO AL TERRENO NUDO, IL TERRENO NUDO, IL SOPRASSUOLO DOVRA` SOPRASSUOLO DOVRA` ESSERE -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2014
Ufficio del territorio di LODI Data: 12/11/2014 Ora: 10.41.21 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2014 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.2 del 20/01/2014 n.9 del 26/02/2014 REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 PIANURA DI LODI (27 COMUNI) PIANURA DI CODOGNO (19 COMUNI) Comuni di: ABBADIA CERRETO, BOFFALORA D`ADDA, BORGO SAN Comuni di: BERTONICO, BORGHETTO LODIGIANO, BREMBIO, GIOVANNI, CASALETTO LODIGIANO, CASALMAIOCCO, CASELLE CAMAIRAGO, CASALPUSTERLENGO, CASTIGLIONE D`ADDA, LURANI, CASTIRAGA VIDARDO, CERVIGNANO D`ADDA, COMAZZO, CAVACURTA, CAVENAGO D`ADDA, CODOGNO, GRAFFIGNANA, CORNEGLIANO LAUDENSE, CORTE PALASIO, CRESPIATICA, LIVRAGA, MAIRAGO, MALEO, MASSALENGO, OSSAGO LODIGIANO, GALGAGNANO, LODI, LODI VECCHIO, MARUDO, MERLINO, SECUGNAGO, TERRANOVA PASSERINI, TURANO LODIGIANO, TAVAZZANO VILLAVESCO, MONTANASO LOMBARDO, VILLANOVA DEL SILLARO MULAZZANO, PIEVE FISSIRAGA, SALERANO SUL LAMBRO, SAN MARTINO IN STRADA, SANT`ANGELO LODIGIANO, SORDIO, VALERA FRATTA, ZELO BUON PERSICO COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) BOSCO 20700,00 2-VALORE RIFERITO AL 20700,00 2-VALORE RIFERITO AL TERRENO NUDO, IL TERRENO NUDO, IL SOPRASSUOLO DOVRA` SOPRASSUOLO DOVRA` ESSERE STIMATO A PARTE) ESSERE STIMATO A PARTE) COLTURE FLOROVIVAISTICHE 106200,00 2-VALORE RIFERITO AL 106200,00 2-VALORE RIFERITO AL TERRENO NUDO, IL TERRENO NUDO, IL SOPRASSUOLO DOVRA` SOPRASSUOLO DOVRA` ESSERE -

11/02/2020 LODI Pagina 1 Comune Indirizzo Civico Stato Bonifica
LODI 11/02/2020 Comune Indirizzo Civico Stato Bonifica ABBADIA CERRETO C,NA CANTATANA IN FASE DI BONIFICA ABBADIA CERRETO RONCHI 6 NON BONIFICATO ABBADIA CERRETO UGO FOSCOLO 3 IN FASE DI BONIFICA BERTONICO ALDO MORO 21 BONIFICATO BERTONICO BRUSADA DI SOTTO IN FASE DI BONIFICA BERTONICO C,NA GUASTIMONE IN FASE DI BONIFICA BERTONICO C,NA TACCAGNA BONIFICATO BERTONICO CASCINA MONTICELLI IN FASE DI BONIFICA BERTONICO DE GASPERI 12 NON BONIFICATO BERTONICO GIUSEPPE GARIBALDI 128BONIFICATO BOFFALORA D'ADDA MAGGIORE GIULIO PAGANI 37 IN FASE DI BONIFICA BOFFALORA D'ADDA PAGANI 37 NON BONIFICATO BOFFALORA D'ADDA UMBERTO I NON BONIFICATO BOFFALORA D'ADDA UMBERTO I 41 IN FASE DI BONIFICA BOFFALORA D'ADDA UMBERTO I 33 NON BONIFICATO BOFFALORA D'ADDA UMBERTO I 31 IN FASE DI BONIFICA BOFFALORA D'ADDA VIA UMBERTO I IN FASE DI BONIFICA BORGHETTO LODIGIANO C,NA FUGAZZINA IN FASE DI BONIFICA BORGHETTO LODIGIANO GARIBALDI 1 IN FASE DI BONIFICA BORGHETTO LODIGIANO MONS CESARE GIANNINI 3 BONIFICATO BORGHETTO LODIGIANO PROVINCIALE 54 IN FASE DI BONIFICA BORGHETTO LODIGIANO ROMA 2 BONIFICATO BORGHETTO LODIGIANO VIA DEI SALICI IN FASE DI BONIFICA BORGHETTO LODIGIANO VIA LAGO IN FASE DI BONIFICA BORGHETTO LODIGIANO XX SETTEMBRE NON BONIFICATO BORGHETTO LODIGIANO XX SETTEMBRE 12 IN FASE DI BONIFICA BREMBIO C,NA CÀ DEL BOSCO IN FASE DI BONIFICA BREMBIO DANTE 10 NON BONIFICATO BREMBIO GRAMSCI 46 NON BONIFICATO CAMAIRAGO FRAZ, BOSCO VALENTINO 24 IN FASE DI BONIFICA CAMAIRAGO VIA E, BERLINGUER 8 IN FASE DI BONIFICA CASALETTO LODIGIANO GARIBALDI 10 NON BONIFICATO CASALMAIOCCO -

Limitazione Transito Provincia
PROVINCIA DI LODI Area 1 U.O. 1 Viabilità, Edilizia, Patrimonio, LL.PP. Via Fanfulla 14 - 26900 Lodi (LO) pec: [email protected] ITINERARI PERCORRIBILI DA VEICOLI ECCEZIONALI E TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' (ai sensi del 1° aggiornamento con D.G.R. X/7859 del 12/02/2018) Categorie L Macchine Agricole Eccezzionali N° Denominazione Strada Provinciale dal Km al Km Note SP 16 San Grato - Zelo Buon Persico 0,200 9,400 SP 16 var. Variante di Zelo Buon Persico 9,400 11,610 4,657 5,925 SP 16 dir. San Grato - Zelo Buon Persico ( diramazione per Paullo ) 7,175 10,147 SP 16 bis 0,000 0,859 0,000 9,040 SP 17 Mairano - Sant' Angelo Lodigiano – confine PV 9,040 12,248 SP 19 Graffignana 0,650 6,500 SP 20 Mantovana 0,000 4,973 SP 22 Casalpusterlengo - Castiglione d’Adda 0,000 3,300 SP 23 Lodi - San Colombano al Lambro 0,000 12,363 SP 25 Lodi - Boffalora d’Adda 0,750 4,784 SP 26 Lodi - Castiglione d’Adda 0,000 15,640 SP 27 Castiglione d’Adda - Castelnuovo Bocca d'Adda 0,000 23,401 0,000 12,525 SP 107 Lodi - Ospedaletto Lodigiano 13,350 16,240 SP 107 var. Lodi - Ospedaletto Lodigiano 0,000 1,680 SP 108 Codogno - Cavacurta 2,500 3,862 SP 115 Lodi - Salerano 0,000 8,566 SP 115 Borgo San Giovanni - Salerano (vecchio tronco) non percorribile SP 116 Codogno - Meleti 0,450 10,750 SP 116 dir. Codogno - Meleti 0,000 1,250 SP 123 Sant' Angelo Lodigiano - Valera Fratta 0,000 4,200 SP 124 Cadilana - Abbadia Cerreto 0,000 7,464 Macchine Agricole larghezza <= 3,20 m SP 125 Graffignana - Livraga 0,000 8,097 SP 126 Ospedaletto Lodigiano -

Massalengo Portavoce Del Progetto Ciclopedonale Lodi-S.Colombano
maassssaleennggoonnewews.sc.oim t Cronaca, attualità ed eventi del tuo paese 1 2 0 2 MMaassssaalleennggoo ppoorrttaavvooccee o i l g u L a ddeell pprrooggeettttoo pprroovviinncciiaallee e r a p m a t ppeerr llaa cciiccllooppeeddoonnaallee LLooddii--SS..CCoolloommbbaannoo s i d o t i a pag. 3 n i F AMMINISTRAZIONE Massalengo, un Comune virtuoso Cari concittadini, torno su queste pagine, per parlarvi di un aspetto importante della gestione del nostro Comune, quello economico fi - nanziario, e per darvi una breve rappresentazione del funzionamento del bilancio comunale. Niente paura, nessun elenco di cifre; i numeri sono disponibili a tutti nel sito del Comune. Scrivo questo articolo perché credo sia importante che ogni cittadino abbia almeno una idea generale di come funziona il proprio Comune, e di come prendono sostanza i servizi che ognuno di noi riceve quotidianamente. • a Pag.2 Per la tua pubblicità su “Massalengo News” scrivi a: [email protected] AMMINISTRAZIONE «Ogni giorno competenza e dedizione affinchè non un euro di risorse pubbliche vada sprecato» Avanzo di bilancio: Massalengo, un Comune virtuoso sono classificate come Spese l’Unione Europea. Ogni Comune fondi per finanziare progetti di Correnti. L’altra componente del ha l’obbligo di rispettare un equi - sviluppo; abbiamo risorse cui ri - Bilancio Comunale è quella dedi - librio tale per cui le Spese (Spesa corre in caso di necessità ed cata agli investimenti, il cosid - Corrente e Conto capitale) non emergenza. Inoltre, e questo non detto Conto Capitale. In questo devono mai superare l’ammon - è un discorso economico ma un comparto del bilancio conflui - tare delle Entrate. -

Graduatoria 2021 BUONI
ID Comune Misura richiesta ADL IADL ISEE esito A1 Valera Fratta Buono Sociale Caregiver 0 0 € - finanziata A2 Tavazzano con Villavesco Buono Sociale Caregiver 0 0 € 75,20 finanziata A3 Salerano sul Lambro Buono Sociale Caregiver 0 0 € 1.875,47 finanziata A4 Codogno Buono Sociale Caregiver 0 0 € 2.393,07 finanziata A5 Casalpusterlengo Buono Sociale Caregiver 0 0 € 3.009,40 finanziata A6 Graffignana Buono Sociale Caregiver 0 0 € 3.275,12 finanziata A7 Sant'Angelo Lodigiano Buono Sociale Caregiver 0 0 € 3.802,63 finanziata A8 Corno Giovine Buono Sociale Caregiver 0 0 € 3.957,97 finanziata A9 Casalpusterlengo Buono Sociale Caregiver 0 0 € 4.851,38 finanziata A10 Casalpusterlengo Buono Sociale Assistente Familiare 0 0 € 6.109,18 finanziata A11 Orio Litta Buono Sociale Caregiver 0 0 € 6.149,21 finanziata A12 Codogno Buono Sociale Caregiver 0 0 € 6.170,87 finanziata A13 Zelo Buon Persico Buono Sociale Caregiver 0 0 € 6.308,70 finanziata A14 Brembio Buono Sociale Caregiver 0 0 € 6.350,00 finanziata A15 Sant'Angelo Lodigiano Buono Sociale Caregiver 0 0 € 6.726,67 finanziata A16 Lodi Vecchio Buono Sociale Caregiver 0 0 € 7.195,41 finanziata A17 Tavazzano con Villavesco Buono Sociale Caregiver 0 0 € 7.229,21 finanziata A18 Casalpusterlengo Buono Sociale Caregiver 0 0 € 7.244,67 finanziata A19 Secugnago Buono Sociale Caregiver 0 0 € 7.373,12 finanziata A20 San Colombano al Lambro Buono Sociale Assistente Familiare 0 0 € 7.936,89 finanziata A21 Codogno Buono Sociale Assistente Familiare 0 0 € 8.503,33 finanziata A22 Cervignano d'Adda Buono Sociale -

Top200 Le Eccellenze Di Lodi
Top200 Le eccellenze di Lodi Analisi 2020 RICERCA N° 06/2020 A cura dell’Area Centro Studi La presente ricerca è stata curata dal Centro Studi Assolombarda. Si ringraziano Stefano Bravo (PwC), Andrea Cominelli (PwC), Francesco Ferrara (PwC), Stefano Pavesi (PwC), Alessandro Righetti (Assolombarda), Gigliola Santin (Assolombarda) per la collaborazione. Indice EXECUTIVE SUMMARY 5 METODOLOGIA 7 1. INTRODUZIONE: LE VOCAZIONI DEL TERRITORIO 9 2. LA CLASSIFICA TOP200 10 3. I SETTORI DELLA TOP200 12 4. LA CLASSIFICA DEI COMUNI 14 5. LE PROSPETTIVE DELLE IMPRESE 15 APPENDICE: LA CLASSIFICA PER FATTURATO 19 APPENDICE: LA CLASSIFICA PER EBITDA 27 APPENDICE: LA CLASSIFICA DEI COMUNI 31 Executive summary La provincia di Lodi conta oltre 15 mila imprese che occupano 58 mila addetti. Il manifatturiero è il vero traino dell’economia di questo territorio, generando un quarto del valore aggiunto provinciale, e si fonda su alcune specifiche vocazioni: la più ‘storica’ è quella agroalimentare (forte del suo legame con il sistema agricolo locale), a cui si uniscono altre due specializzazioni produttive, ovvero la farmaceutica e la chimica. In particolare, Lodi è la prima provincia in Italia e in Lombardia nella cosmetica. Elettronica, gomma- plastica, meccanica e automotive completano il quadro delle specializzazioni produttive del territorio. Tra i servizi, la logistica è un settore rilevante, soprattutto in termini di forza lavoro occupata. Altrettando importanti per l’economia lodigiana sono i servizi di informazione e comunicazione. In questo panorama della struttura economica della provincia di Lodi, si inserisce la terza edizione della TOP200, un progetto di ricerca e di analisi dei dati economico-finanziari delle maggiori realtà imprenditoriali nel 2019, promosso da Assolombarda, PwC e Banco BPM, in collaborazione con Il Cittadino di Lodi. -

CARTA DELLE OPERE DI BONIFICA in PROGETTO .! TAV.17D MEZZANA CASATI Scala 1:25.000
CAVO BARDO PAN Mappatura del bacino 3a con indicazione degli interventi relativi Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana DERIVATORE CODOGNINO CAVO BARDO PAN via Nino Dall’Oro 4 - 26900 LODI tel. 0371-420189 r.a. fax 0371-50393 alla bonifica ed alla riduzione del rischio idraulico email: [email protected] PRESIDENTE: COLLABORAZIONI ESTERNE: CAVALLONA Descrizione N. Distretto Azioni Obiettivo generale Obiettivo specifico Criticità Enti coinvolti Comune/i Importo progetti Priorità Ettore Grecchi intervento 3a DIRETTORE GENERALE: l e g e n d a : Dott. ing. Ettore Fanfani Risoluzione delle basi tematiche: problematiche di DIRIGENTI: progettualità: Soluzione delle allagamento del Studio Associato PERCORSI SOSTENIBILI colatore Spoldo nel Dott. Ing. Marco Chiesa - VICE DIRETTORE Vettoriamento parziale delle portate del problematiche relative ad via Volterra, 9 tratto urbano di Ossago Dott. Sergio Carniti PADERNINO colatore Spoldo in Colatrice Casala per la Riduzione rischio almeno 20 ha del bacino Esondazione nell'abitato di Frazione Ossago BIP14 Lodigiano e territori Ossago Lodigiano € 500.000,00 1 Dott. Caludio Tarlocco 20146 MILANO 9 idraulico 3a e conseguente Ossago Lodigianao Lodigiano Canale Muzza Interventi lineari salvaguardia idraulica dell'abitato di limitrofi, mediante www.percorsisostenibili.com riduzione del rischio Ossago costituzione di nuovo idraulico canale scaricatore in Colatrice Casala CAVO CAMPA PIANO COMPRENSORIALE DI BONIFICA, DI IRRIGAZIONE S# all'esterno dell'abitato CAVO CAMPA bocca di presa PRIORA Interventi puntuali I numerosi eventi pluviali degli 46a derivatore !. Convenzione con Regione Lombardia per ultimi anni hanno ridotto in E DI TUTELA DEL TERRITORIO RURALE Soluzione delle modo consistente la capacità la gestione dei corsi d’acqua del reticolo Comuni di Brembio, Brembio, problematiche relative ad idraulica del colatore Risagomatura, L.R. -

Legenda Terraverde 1 Paderno
Lavagna L O S P 1 Vaiano 8 1 D 1 COMAZZO 5 A L MERLINO O S L P O 2 S 0 P Marzano 1 1 8 1 LO S PE XS S4 15 ZELO BUON PERSICO Bisnate Casolate Muzza no 6 1 P Mignete Cassino d` Alberi S L O O L S P 1 6 A5 L 0 O D Villa Pompeiana S P 1 5 8 8 P13 LOS MULAZZANO CERVIGNANO D'ADDA Buttintrocca 8 LO 5 S P A 1 6 D L O S BOFFALORA D'ADDA P 5 1 Quartiano LOSP18 5 9 CASALMAIOCCO CRESPIATICA 5 8 2 5 Casolta P 1 S P O A Modignano S LO L 4R O SP P20 L 20 235 LOS 2 EXSS 2 P Arcagna LOS 7 SORDIO 4 S Tormo S X E P Riolo MONTANASO LOMBARDO S O L TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO SP2 Cadilana 02 Prada LO Pezzolo S 1 P 0 1 4 6 San Grato 1 b L O Bagnolo P is !S Cavelzano S Revellino P O L 1 2 A 4 Legenda Terraverde 1 Paderno T ABBADIA CERRETO Villa Rossa A Mairano N 4 CORTE PALASIO G 0 5 E 2 ! N P MANUFATTO SU LINEA TRADIZIONALE L Z O S LODI S I O ! A P 1 L 7 15 LODIVECCHIO San Bernardo L E Casellario P1 5 S 40 3 E LO SP1 2 LO S S S T San Bassano X SS9 E ! P MANUFATTO SU LINEA ALTA VELOCITA' S SALERANO AL LAMBRO O Gugnano L Olmo 9 CASALETTO LODIGIANO L 16 6 O SP 16 S LO SP P LO LO 1 S 8 P 6 LOSP186 Soltarico 14 B RETE FERROVIARIA 0 Muzza Sant` Ang elo Sesto CAVENAGO D'ADDA S CASELLE LURANI CORNEGLIANO LAUDENSE S 2 9 6 6 LOSP18 BORGO SAN GIOVANNI 7 ! LOS 8 Paderno Isimbardo P186 Caviaga RETE AUTOSTRADALE ! 1 MAIRAGO Cusanina P Castiraga S SAN MARTINO IN STRADA Calvenzano Pozzobonella O L Robe cco 7 Basiasco 1 Muzza Piacentina 9 L O PIEVE FISSIRAGA MASSALENGO 1 7 RETE STRADALE P 3 S ! S Vigana 2 P Domo dosso la Fissira ga O P 2 L S 0 O VALERA FRATTA 5 D1 Motta Vigana -
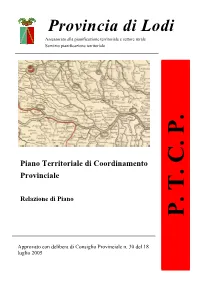
Piano Territoriale Di Coordinamento Provinciale
Provincia di Lodi Assessorato alla pianificazione territoriale e settore rurale Servizio pianificazione territoriale Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Relazione di Piano Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 18 luglio 2005 Provincia di Lodi Assessorato alla pianificazione territoriale e settore rurale Servizio pianificazione territoriale Coordinamento istituzionale Vicepresidente Fabrizio Santantonio Dirigente Savino Garilli Consulenza scientifica Politecnico di Milano Dipartimento di Architettura e Pianificazione Responsabili Maria Cristina Treu, Carlo Peraboni Gruppo di lavoro Barbara Bisconcini, Alessandra di Marco, Sara Dossena, Caroline Jabour de França, Paola Marzorati, Margherita Muzzi, Norma Tedeschi, Sara Zorzolo Consulenza Analisi sistema economico Flavio Boscacci Elena Maggi Viviana Magnaghi Silvia Passera Analisi assetto infrastrutturale Gianluigi Sartorio Paola Rosa Elaborazioni cartografiche Deltadator spa Elaborazioni Fabio Zanini cartografiche 1 Premessa pag. 4 Prima parte – Le scelte strutturali del Piano pag. 7 1. IL CONTESTO DI AZIONE DEL PIANO pag. 8 1.1. LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE ED IL CONCETTO DI LEALE COLLABORAZIONE pag. 8 1.2. LA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 5/1/2000 E LE DIRETTIVE REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PTCP pag. 10 2. LA STRUTTURA DEL PTCP pag. 36 2.1. GLI OBIETTIVI DEL PTCP DELLA PROVINCIA DI LODI pag. 36 2.2. LA STRATEGIA DEL PIANO pag. 41 2.3. LA STRUTTURA OPERATIVA DEL PIANO pag. 49 Seconda Parte – Il sistema della conoscenza pag. 69 3. IL SISTEMA DELLA CONOSCENZA E L’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DEL PTCP pag. 70 3.1. L’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO ORIZZONTALE: LA PROGETTAZIONE SETTORIALE pag. 70 3.2. L’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO VERTICALE: DAL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE INTEGRATO ALLE INDICAZIONI PER LA PROGETTUALITÀ COMUNALE pag. -

2013 – 2014 Isu Bocconi Application Requirements and Regulations
2013 – 2014 ISU BOCCONI APPLICATION REQUIREMENTS AND REGULATIONS - ISU Bocconi Scholarships - Integrations for internships and international programs - Canteen Service Translation of the final ISU Bocconi Application Requirements and Regulations Published on 30 July 2013 In case of discrepancies between the Italian text and the English translation, the Italian text prevails. CONTENTS CHAPTER I – PAGE 3 Art. 1 Benefits for the right to study – PAGE 3 Art. 2 Financial status verification and veracity of economic information provided (Italian D.P.R. 445/2000, article 71) – PAGE 3 Art. 3 Information on the use of personal information and the rights of the declarant – PAGE 3 CHAPTER II - ISU BOCCONI SCHOLARSHIPS – PAGE 4 Art.1 – Recipients of assistance – PAGE 4 Art. 2 – Duration of assistance granted – PAGE 4 Art. 3 – Number of scholarships – PAGE 5 Art. 4 – Total scholarship amounts – PAGE 5 Art. 4.1 – Brackets for I.S.E.E./I.S.E.E.U. values – PAGE 5 Art. 4.2 – Place of origin – PAGE 6 Art. 4.3 – Scholarship amounts – PAGE 6 Art. 5 – General Application Conditions – PAGE 7 Art. 6 – Students with Disabilities – PAGE 7 Art. 7 – Merit requirements – PAGE 8 Art. 7.1 – Bachelor and/or Combined Bachelor and Master of Science programs – PAGE 8 Art. 7.2 – Master of Science programs – PAGE 9 Art. 7.3 – PhD programs – PAGE 9 Art. 8 – Bonuses for meeting merit requirements – PAGE 10 Art. 9 – Requirements regarding economic conditions – PAGE 10 Art. 9.1 – Criteria for accessing assistance: Indicator of university equivalent assets situation (I.S.P.E./I.S.P.E.U.) and indicator of university equivalent financial situation (I.S.E.E./I.S.E.E.U.) – PAGE 10 Art.