I Tesori Dell'isola
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
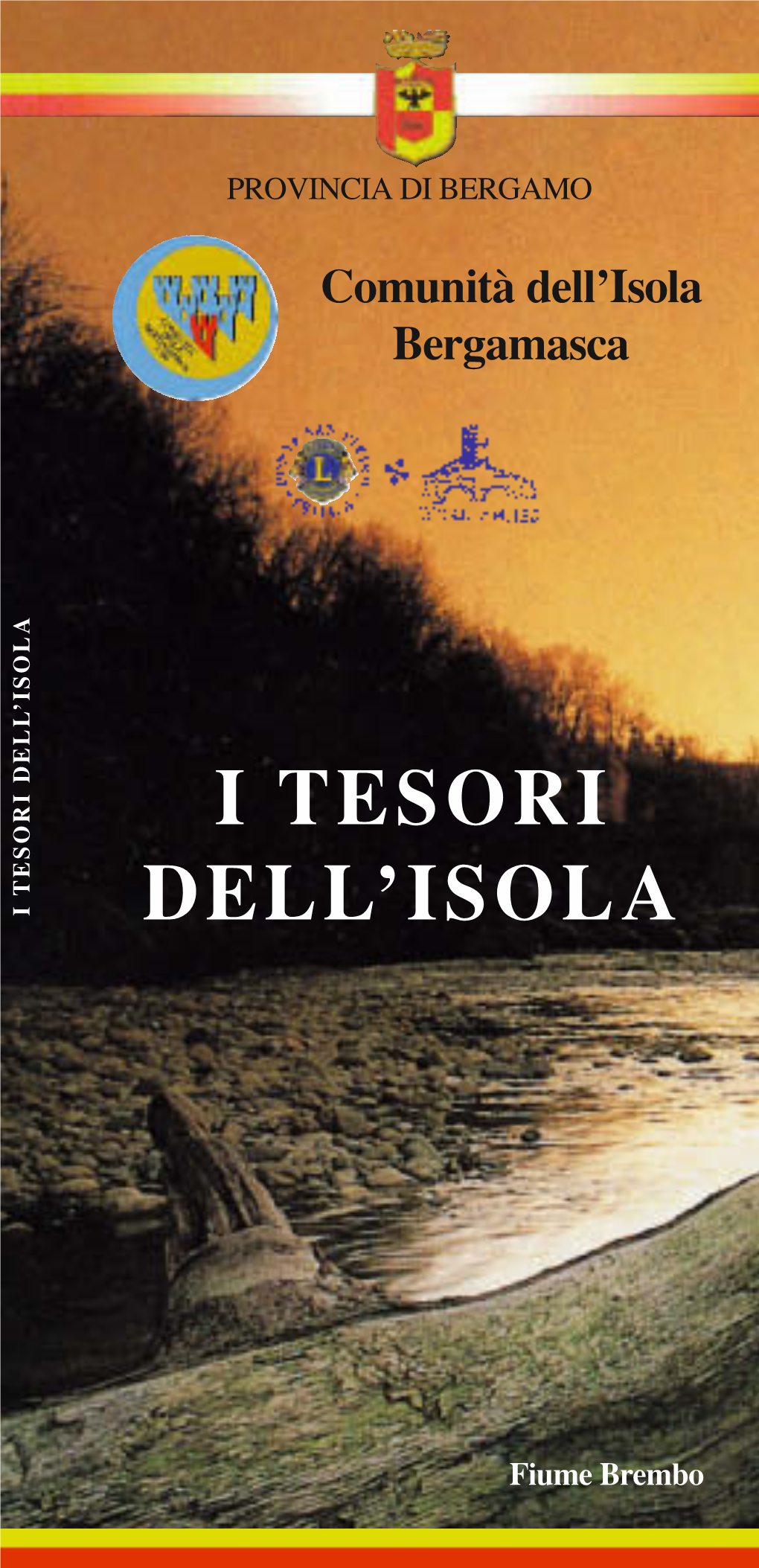
Load more
Recommended publications
-

PROVINCIA DI BERGAMO Via Torquato Tasso, 8 - 24121 BERGAMO SETTORE: POLITICHE SOCIALI – SERVIZIO INTERVENTI in CAMPO SOCIALE Via Camozzi, 95 - 24121 BERGAMO Tel
PROVINCIA DI BERGAMO Via Torquato Tasso, 8 - 24121 BERGAMO SETTORE: POLITICHE SOCIALI – SERVIZIO INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE Via Camozzi, 95 - 24121 BERGAMO Tel. 035-387.728 -Fax 035-387.682 e-mail: [email protected] Aggiornamento libretto “Coordinamento degli sportelli per l’immigrazione 2011” Rete di sportelli per la popolazione immigrata residente nei comuni dell’Ambito dell’Isola bergamasca e della bassa Val San Martino (Ambito territoriale n. 12) ENTE GESTORE : AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino” Azienda territoriale per i servizi alla persona Via Garibaldi, 15 24040 Bonate Sotto (Bg) TELEFONO 035 4991278 FAX 035 4991277 POSTA ELETTRONICA [email protected] SITO INTERNET www.aziendaisola.it PARTNER TECNICO: Fondazione Diakonia dell’isola Giovanni XXIII – ONLUS Tel 035902621 /fax 0354933354 [email protected] ENTI LOCALI ASSOCIATI: 24 COMUNI DELL’AMBITO AMBIVERE FILAGO BONATE SOPRA MADONE BONATE SOTTO MAPELLO BOTTANUCO MEDOLAGO BREMBATE SOPRA PONTE SAN PIETRO BREMBATE SOTTO PONTIDA CALUSCO D’ADDA PRESEZZO CAPRIATE S.GERVASIO SOLZA CAPRINO BERGAMASCO SOTTO IL MONTE CARVICO SUISIO CHIGNOLO D’ISOLA TERNO D’ISOLA CISANO BERGAMASCO VILLA D’ADDA ANNO INIZIO ATTIVITA’: 1999 STRUTTURE PRESSO LE QUALI SONO UBICATI GLI SPORTELLI – INDIRIZZI - GIORNI ED ORARI DI APERTURA Comune/SEDE Indirizzo Recapiti Apertura del servizio 0356228411 COMUNE PONTE S. PIETRO PIAZZA DELLA Fax - 0356228499 2° e 4 Giovedì di ogni mese , LIBERTA', 1 [email protected] -

Dott. Stefano Valli, Segretario Comunale
******************************************************************************** CURRICULUM VITAE ******************************************************************************** Dati personali Cognome e nome VALLI STEFANO Nato a Trescore Balneario il 17/08/1967 Residente a Trescore Balneario in Via Don Minzoni n. 3/a Nr. cell.: 349 8727848; nr. casa 035 940728 Titolo di studio Diploma di Ragioniere conseguito presso l’ITC Vittorio Emanuele II, nell’anno scolastico 1985/86. Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Bergamo, anno accademico 2000/01, titolo Tesi: “la gestione in forma associata di funzioni e servizi pubblici locali”. Diploma di Perfezionamento Universitario in “Disegni organizzativi – gestione e sviluppo delle risorse umane e performance negli Enti Locali” conseguito presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bergamo, anno accademico 2003/04. Iscrizione Albo Segretari Comunali Decreto del Presidente dell’Unità di Missione n. 491(P) del 12/07/2011. Iscritto all’Albo dal 10/08/2011 al n. 8408. Esperienze professionali Alle dipendenze dell’azienda Triumph SpA di Trescore B., con mansioni di impiegato nell’Ufficio Disposizioni dal 1988 al 1991. Dipendente presso il Comune di Zandobbio dal 01/07/1991 all’8/08/2011, con posizione di funzionario direttivo contabile e Vice Segretario - Categoria D, titolare di posizione organizzativa. Segretario Comunale del Comune di Zandobbio dal 10/08/2011. Titolare della convenzione di segreteria Zandobbio-Valnegra dal 01/01/2012 al 13/10/2014. Titolare della convenzione di segreteria Zandobbio - Carobbio degli Angeli – Entratico dal 14/10/2014 al 31/12/2016. Titolare della convenzione di segreteria Pradalunga - Zandobbio – Entratico dal 01/01/2017 al 28/02/2018. Titolare della convenzione di segreteria Mozzo – Pradalunga – Zandobbio dal 01/03/2018 al 20/05/2018. -

BG) Il 07/07/1946
CURRICULUM PROFESSIONALE Dott. Ing. Franco Salvetti, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 07/07/1946. Laureato al Politecnico di Milano nel 1970. Iscritto nel 1971 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo, al n° 825. Iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori al n° 791. Iscritto nell’elenco del M.I. ai sensi della L. 07/12/1984, n. 818, al n° BG-825-I-111. Abilitato allo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs 81/2008. Qualificato come esperto ambientale ai sensi della L.R. 18/97. Studio professionale in Bergamo, Via Innocenzo XI n° 8, tel. 035/403247 – fax 035/403257 – cell.: 348-4209398 – mail: [email protected]. CONSULENTE URBANISTICO dei Comuni di Berzo San Fermo Branzi, Carona, Piazza Brembana, Mezzoldo, Cassiglio, Roncobello, Gaverina Terme, Vigano San Martino, Luzzana, Locatello, Corna Imagna. Ha gestito l’Ufficio Tecnico dei Comuni di Mornico al Serio, Parzanica, Vigolo, Vigano San Martino, Berzo San Fermo, Roncobello. E’ Presidente delle Commissioni del Paesaggio dei Comuni di Cassiglio e Branzi. Alcuni dei lavori pubblici svolti: 1 URBANISTICA Piano di Governo del Territorio, e relativa VAS, del Comune di Corna Imagna (in corso di redazione); Piano di Governo del Territorio, e relativa VAS, del Comune di Berzo San Fermo; successiva. variante Generale 2011 al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi; successiva Variante n 2 di aggiornamento quinquennale. Piano di Governo del Territorio, e relativa VAS, del Comune di Branzi; successiva Variante di aggiornamento quinquennale. Piano di Governo del Territorio, e relativa VAS, del Comune di Roncobello; successiva Variante di aggiornamento quinquennale; successiva variante n 2 al Piano delle Regole. -

ALLEGATO 4: CARTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO (Fonte: Sistema Informativo Territoriale – SITER - Della Provincia Di Bergamo)
ALLEGATO 4: CARTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO (fonte: Sistema Informativo TERritoriale – SITER - della Provincia di Bergamo) VILMINORE DI SCALVE VALGOGLIO GROMO COLERE ´ OLTRESSENDA ALTA ARDESIO ANGOLO TERME CASTIONE DELLA PRESOLANA FINO DEL MONTE VILLA D`OGNA PARRE PIARIO ONORE CLUSONE ROGNO SONGAVAZZO CERETE ROVETTA COSTA VOLPINO BOSSICO SOVERE GANDINO LOVERE 1:50.000 Confine comunale Industriale Raffreddamento Scarico di emergenza privato Scarico depurato pubblico Terminale pubblica fognatura bianche Scarico di emergenza (Staz. sol. / bypass) Sfioratore Sfioratore/scarico staz. sollevamento Reticolo idrografico Carta degli scarichi autorizzati in corpo d'acqua superficiale VILMINORE DI SCALVE VALGOGLIO GROMO COLERE ´ OLTRESSENDA ALTA ARDESIO ANGOLO TERME CASTIONE DELLA PRESOLANA FINO DEL MONTE VILLA D`OGNA PARRE PIARIO ONORE CLUSONE ROGNO SONGAVAZZO CERETE ROVETTA COSTA VOLPINO BOSSICO SOVERE GANDINO LOVERE 1:50.000 Confine comunale Sorgenti / Fontanili Derivazioni superficiali Pozzi Potabile Potabile Potabile Antincendio Antincendio Antincendio Igienico Igienico Igienico Industriale Industriale Industriale Produzione Energia Produzione Energia Produzione Energia Piscicoltura Piscicoltura Piscicoltura Zootecnico Zootecnico Irriguo Zootecnico Irriguo Uso Domestico Irriguo Uso Domestico Altro uso Uso Domestico Altro uso Altro uso Carta delle piccole derivazioni di acqua VILMINORE DI SCALVE VALGOGLIO GROMO COLERE ´ OLTRESSENDA ALTA ARDESIO ANGOLO TERME CASTIONE DELLA PRESOLANA FINO DEL MONTE VILLA D`OGNA PARRE PIARIO ONORE CLUSONE ROGNO SONGAVAZZO -

Elenco Operatori Accreditati Per I SERVIZI AL LAVORO Con Sedi Operative Nella Provincia Di Bergamo
Servizio Orienta Lavoro Sportello Ricomincio a studiare www.cgil.bergamo.it CGIL BERGAMO, Via Garibaldi 3, 24122 Bergamo. Tel. 035.3594111 Elenco Operatori Accreditati per i SERVIZI AL LAVORO con sedi operative nella provincia di Bergamo AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE CFP DI SAN GIOVANNI BIANCO Telefono: 34543811 24015 SAN GIOVANNI BIANCO LOCALITA' MONTEROSSO [email protected] MANPOWER S.R.L. MANPOWER SAN PELLEGRINO Telefono: 0345/20.107 24016 SAN PELLEGRINO TERME VIALE PAPA GIOVANNI XXIII [email protected] PROVINCIA DI BERGAMO CENTRO PER L'IMPIEGO DI ZOGNO Telefono: 0345/90819-820 24019 ZOGNO PIAZZA BELOTTI 4 [email protected] ISTITUTO SORDOMUTI D'AMBO I SESSI DI BERGAMO FONDAZIONE I.S.B. - BERGAMO Telefono: 035340444 24020 TORRE BOLDONE VIA REICH 49 [email protected] AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE CFP ALBINO Telefono: 35760022 24021 ALBINO VIA PADRE DEHON [email protected], MANPOWER S.R.L. MANPOWER ALBINO Telefono: 035760024 24021 ALBINO VIALE LIBERTÀ , 6 [email protected] MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MESTIERI LOMBARDIA UO ALBINO Telefono: 035/76.10.60 24021 ALBINO VIA PROVINCIALE 24/C [email protected] OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO Telefono: 035773775 24021 ALBINO VIA ROMA, 87 [email protected] PROVINCIA DI BERGAMO CENTRO PER L'IMPIEGO DI ALBINO Telefono: 035/751344 24021 ALBINO VIA SERIO 2/A [email protected] ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZO AGENZIA LAVORO 03 A.F.P. PATRONATO SAN VINCENZO - CLUSONE Telefono: 034621131 24023 CLUSONE VIALE SAN LUCIO, 27 [email protected] AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE CFP CLUSONE Telefono: 34622808 24023 CLUSONE VIA G. -

[email protected] COMUNE DI
Regione Lombardia - Giunta DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE VIARIE E AEROPORTUALI VIABILITA' E MOBILITA' CICLISTICA Piazza Città di Lombardia n.1 www.regione.lombardia.it 20124 Milano [email protected] Tel 02 6765.1 Protocollo S1.2019.0010104 del 20/03/2019 PROVINCIA DI BERGAMO Email: [email protected] COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO Email: [email protected] mbardia.it COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO Email: [email protected] COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO Email: [email protected] COMUNE DI ALBINO Email: [email protected] COMUNE DI ALGUA Email: [email protected] COMUNE DI ALME Email: [email protected] COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO Email: [email protected] mo.it COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE Email: [email protected] COMUNE DI ALZANO LOMBARDO Email: [email protected] COMUNE DI AMBIVERE Email: [email protected] Referente per l'istruttoria della pratica: PAOLA VIGO Tel. 02/6765.5137 GABRIELE CASILLO Tel. 02/6765.8377 COMUNE DI ANTEGNATE Email: [email protected] COMUNE DI ARCENE Email: [email protected] COMUNE DI ARDESIO Email: [email protected] COMUNE DI ARZAGO D'ADDA Email: [email protected] COMUNE DI AVERARA Email: [email protected] COMUNE DI AVIATICO Email: [email protected] -

CASSIGLIO: Dipinto Sulla Facciata Della Casa Milesi
Parco delle Orobie Bergamasche SULLE TRACCE DELL’ORSO PROGETTO DI PARTECIPAZIONE DEL PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE AD EXPO 2015 Bergamo, gennaio 2013 Parco delle Orobie Bergamasche Via Camozzi n. 111 – 24121 BERGAMO Tel. 035/224249 Fax 035/219333 [email protected]; [email protected] www.parcorobie.it SULLE TRACCE DELL’ORSO PROGETTO DI PARTECIPAZIONE DEL PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE AD EXPO 2015 A cura di Chiara Crotti e Claudia Rota Parco delle Orobie Bergamasche Direzione editoriale Yvan Caccia, Presidente Parco delle Orobie Bergamasche Parco delle Orobie Bergamasche Via Camozzi n. 111 – 24121 BERGAMO Tel. 035/224249 Fax 035/219333 [email protected]; [email protected] www.parcorobie.it 2 INDICE PREMESSA Cenni sul Parco delle Orobie Bergamasche Expo 2015: un’opportunità per il territorio del Parco delle Orobie Bergamasche L’Orso, simbolo del progetto di partecipazione del Parco a Expo 2015 Sottotemi del progetto “Sulle tracce dell’orso” Capitolo 1- CHI E’ L’ORSO BRUNO? CENNI DI BIOLOGIA 1.1 Sistematica 1.2 Morfologia 1.3 Riproduzione 1.4 Ecologia alimentare 1.5 Habitat 1.6 Legame al territorio 1.7 Distribuzione Capitolo 2- L’ORSO NELLA PREISTORIA Capitolo 3- L’ORSO NELLA STORIA 3.1 L’orso nei documenti storici 3.2 L’orso nella toponomastica e cultura locale 3.3 L’orso nell’arte e iconografia 3.4 L’orso nell’araldica 3.5 L’orso nell’onomastica 3.6 L’orso nelle leggende 3.7 Lo sapevi che... Parco delle Orobie Bergamasche Via Camozzi n. 111 – 24121 BERGAMO Tel. 035/224249 Fax 035/219333 [email protected]; [email protected] www.parcorobie.it 3 Capitolo 4- L’ORSO AL GIORNO D’OGGI 4.1 L’orso e i media 4.2 L’orso e i giovani CONCLUSIONI OPERE CITATE E CONSULTATE ALLEGATI Parco delle Orobie Bergamasche Via Camozzi n. -

SEAP Luzzana Action Plan for Energy Luzzana Piano D’Azione Per L’ Energia
Comune di Luzzana SEAP Luzzana Action Plan for Energy Luzzana Piano d’Azione per l’ Energia Partner tecnici Il progetto è stato eseguito dal gruppo di lavoro costituito dalla società Val Cavallina Servizi S.r.l., dal Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Lecco, e dalla società ING S.r.l. COORDINAMENTO SCIENTIFICO Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Lecco Prof. Ing. Gabriele Masera e Ing. Graziano Salvalai GRUPPO DI LAVORO Ing. S.r.l. Ing. Gabriele Ghilardi, Ing. Cristina Bonfanti, Ing. Federica Maroni Val Cavallina Servizi S.r.l. Dott. Enrico Agazzi, Dott. Francesco Bari, Ing. Andrea Vigani Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Lecco Paola Forlani, Alessandro Bernasconi Il seguente Piano d’Azione per l’energia sostenibile di Luzzana è stato redatto per la Val Cavallina Servizi S.r.l. da: Graziano Salvalai, Federica Maroni, Cristina Bonfanti, Andrea Vigani, Paola Forlani e Alessandro Bernasconi 2 LUZZANA PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA Indice 1. Premessa ........................................................................................................................... 4 2. Contesto ............................................................................................................................ 5 3. Cos’è il SEAP ? .................................................................................................................. 5 3.1 Contesto normativo ..................................................................................................................................6 3.2 Articolazione -

UFFICIO COMUNICAZIONE CGIL RASSEGNA STAMPA Mercoledì 17 FEBBRAIO 2021
UFFICIO COMUNICAZIONE CGIL RASSEGNA STAMPA MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 2021 CGIL L’ECO DI BERGAMO 8 MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 2021 Abi: rallenta in gennaio Economia la crescita dei prestiti Rallenta, a gennaio la crescita dei prestiti banca- [email protected] ri a famiglie e società. Secondo l’Abi sono saliti www.ecodibergamo.it/economia/section/ del 4,5% contro il 5,5 di dicembre a 1.303 miliardi Passaggio delle filiali Ubi a Bper Banca, le tappe Per 77 filiali Ubi Giovedì 18 febbraio Gli sportelli di prelievo delle filiali Ubi interessate al passaggio (elenco sotto) cessano di funzio- nare. Ritorneranno operativi la mattina di lunedì 22 febbraio. I clienti possono prelevare gratuitamente presso gli sportelli delle altre banche. Venerdì 19 febbraio arriva il passaggio Alle 11,30 le filiali Ubi chiudono. Riapriranno come filiali Bper lunedì 22 febbraio. Dalle ore 22 il servizio di Internet Banking di Ubi non è più disponibile. La carta prepagata Ubi non è più attiva. La nuova carta Bper potrà essere attivata da lunedì 22 febbraio. Sabato 20 e domenica 21 febbraio a Bper Banca I canali digitali Ubi non sono accessibili a tutti i clienti. Compresi quelli delle filiali non interessate alla migrazione. Lunedì 22 febbraio Migrazione. Da domani l’avvio delle prime procedure Apertura delle filiali con le insegne Bper Banca. E’ possibile attivare i servizi digitali di Bper Banca attraverso il link di accesso sul sito bper.it. Ma i dipendenti restano gli stessi. Cambia invece l’Iban Le filiali e i mini sportelli Ubi interessati al passaggio a Bper Lunedì 22 il -

Autovelox Lombardia BERGAMO
Luglio 2005 Saloni e Motori – Autovelox Lombardia BERGAMO BERGAMO Sarnico, Viale Europa, entrambe le direzioni, Fiat Panda ferma al benzinaio Shell, veicolo fermo. BERGAMO A4 - TORINO-TRIESTE, fra Seriate e Bergamo, entrambe le direzioni, treppiede. BERGAMO Albano Sant'Alessandro, SS direzione Bergamo, installazione permanente. BERGAMO SP 35, direzione nord-sud, treppiede. BERGAMO Bergamo - Tra Cassina de’ Pecchi, SS 11, direzione Bergamo, treppiede. BERGAMO Medolago, Rivierasca, direzione Suisio, installazione permanente. BERGAMO Mapello/Bonate Sopra, Via Scotti, direzione stabilimento freni Brembo Foom, direzione Bonate, telelaser. BERGAMO A4 - TORINO-TRIESTE, Seriate, sotto il secondo cavalcavia dopo l’uscita di Seriate, direzione Milano, treppiede. BERGAMO Mozzanica, ex statale n°11, in entrambi i sensi di marcia, installazione permanente. BERGAMO Bonate Sotto, direzione Chignolo – Bonate Sotto, all’altezza centro sportivo nascosto dietro a una siepe, treppiede. BERGAMO Chignolo d’Isola , direzione Terno d’Isola - Chignolo, dopo il cimitero, treppiede. BERGAMO Sarnico, Tavernola Bergamasca, entrambe le direzioni, strade video sorvegliate, velox con foto frontale, installazione permanente. BERGAMO Bergamo, direzione Milano, telelaser. BERGAMO A4 - TORINO-TRIESTE, Brescia ,direzione Venezia, treppiede. BERGAMO Presezzo, principale, direzione centro, al semaforo della piazza, treppiede. BERGAMO Gorlago - Strada che porta a Bolgare, SP 89, direzione Bolgare – alla fine del cavalcavia della ferrovia, telelaser. BERGAMO Brignano, strada Treviglio- Brignano, nelle vicinanze dell’ abitato di Brignano, telelaser BERGAMO Sorisole , SS 470 semaforo per entrare a Sorisole (venendo da BG), n°2 velox appena installati ed in ambo i sensi, installazione permanente. BERGAMO Medolago altezza semaforo vicino al bar Bibis, rivierasca, puntato verso chi viene da Suisio, installazione permanente. Www.Infobergamo.it di Graziano Paolo Vavassori – Copyright HSE Autorizzazione Tribunale di Milano n.256 del 13 aprile 2004. -

PDF Dei Turni
TURNI FARMACIE BERGAMO E PROVINCIA mercoledì 1 settembre 2021 Zona Località Ragione Sociale Indirizzo Da A Da A Alta Valle Seriana Rovetta Re Via Tosi 6 9:00 9:00 Bg citta Bergamo Borgo Palazzo Bialetti Via Borgo Palazzo 83 9:00 12:30 15:00 20:00 Cinque Vie dr. Rolla G.P. & C. Via G. B. Moroni 2 9:00 9:00 Hinterland Curno Invernizzi dr. Invernizzi G.& C Snc Via Bergamo 4 9:00 9:00 Stezzano S.Giovanni Srl Via Dante 1 9:00 0:00 Imagna Capizzone Valle Imagna Snc Corso Italia 17 9:00 9:00 Isola Almè Visini Del dr. Giovanni Visini & C. Snc Via Italia 2 9:00 9:00 Carvico Pellegrini dr. Reggiani Via Don Pedinelli 16 9:00 0:00 Romano Ghisalba Pizzetti Sas Via Provinciale 48/B 9:00 9:00 Seriate Grumello Chiuduno Farmacia S. Michele Srl Via C. Battisti 34 9:00 0:00 Gorle Pagliarini dr. Dario Via Mazzini 2 9:00 9:00 Treviglio Canonica d'Adda Peschiulli Sas Via Bergamo 1 9:00 20:00 Caravaggio Antonioli & C. Sas Via Matteotti 14 9:00 20:00 Treviglio Comunale N.3 Treviglio Az. Sp. Farm. Viale Piave 43 20:00 9:00 Valle Brembana Oltre il Colle Farmacia Viganò Di Passera dr.ssa Francesca Via Roma 272 9:00 9:00 San Pellegrino Terme Della Fonte Snc Viale Papa Giovanni 12 9:00 9:00 Valle Cavallina Alto e BassoBerzo San Sebino Fermo Scarpellini Via Europa Unita 14 9:00 9:00 Trescore Albarotto Srl Via Volta 26 9:00 9:00 Valle Seriana Leffe Pancheri Sas Via Mosconi 10 9:00 9:00 Pradalunga Strauch dr. -

E) VARIE Provincia Di Bergamo
Bollettino Ufficiale – 47 – Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 14 gennaio 2015 te durante il periodo di deposito e nei 30 (trenta) giorni succes- E) VARIE sivi, comunque, entro e non oltre il giorno 18 marzo 2015 presso il Protocollo Generale del Comune, sito in Piazza Manara n. 1 op- Provincia di Bergamo pure, trasmesse mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), all’indirizzo [email protected] Provincia di Bergamo Settore Ambiente – Servizio Rifiuti - Esito verifica di Le osservazioni che perverranno oltre tale termine non saran- assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale. no prese in considerazione. Ditta Roncelli Costruzioni s.r.l. – Progetto di variante all’attività Al fine di facilitare la consultazione, il Piano Attuativo adottato è di recupero (R3, R5, R12, R13) di rifiuti non pericolosi sita in altresì pubblicato, sul sito comunale all’indirizzo http://www.comu- comune di Brembate di Sopra (BG). (Avviso deposito istanza ne.treviglio.bg.it/?q=content/doc_piano-attuativo-at1b-porta-nord pubblicato sul BURL – n. 8 – Serie avvisi e concorsi del 19 febbraio 2014) Treviglio, 7 gennaio 2015 Il dirigente Lo scrivente Servizio ha proceduto ad effettuare il controllo in Pier Luigi Assolari ordine all’assoggettabilità alla procedura di valutazione di im- patto ambientale ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. sul: Comune di Treviglio (BG) Progetto di variante all’attività di recupero (R3, R4, R12, R13) di Avviso di adozione e deposito atti relativi alla «Variante al rifiuti non pericolosi sita in comune di Brembate di Sopra (BG) piano di governo del territorio (PGT) n.