Henry De Groux, Il Pittore Di Andronico
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Dossier De Presse
Au cœur de votre culture Henry(1866-1930) de Grouxmaître de la démesure 24/05 u22/09/2019 « J’avais connu le peintre belge Henry de Groux chez Félicien Rops, son compatriote », écrit Ambroise Vollard, célèbre marchand d’art, dans ses Souvenirs d’un marchand de tableaux. La carrière du jeune de Groux com- mence à Bruxelles au milieu des années 1880 et se poursuit en France puis en Italie. Félicien Rops, ami du père d’Henry, Charles Degroux, joue le rôle de conseiller et de protecteur auprès du jeune artiste. Henry de Groux naît à Bruxelles, en 1866. Il suit les cours de Jean-François Portaels à l’Atelier libre de Bruxelles, mais doit les interrompre à dix-sept ans. Il expose ses premières œuvres en 1885 avec le groupe l’Essor à Bruxelles, puis est élu en 1886 au sein du groupe des XX, avec lequel il participe à trois expositions annuelles (1887- 1889). En 1888-89, il peint son œuvre la plus célèbre, Le Christ aux outrages qu’il expose à Paris en 1892, dans une grange, défrayant la chronique artistique. Il est menacé d’exclusion du groupe des XX en 1890 pour avoir refusé d’exposer ses œuvres à proximité de celles de Van Gogh. En quête perpétuelle d’acheteurs ou de mécènes qui l’aideraient à mener à bien ses projets grandioses, Henry de Groux poursuit sa carrière entre Paris, Bruxelles, Florence, Avignon et Marseille. Il y mène une vie chaotique, perturbée par la détresse matérielle et un rejet obstiné, quasiment maladif, des évolutions sociales, politiques et artis- tiques du monde moderne. -
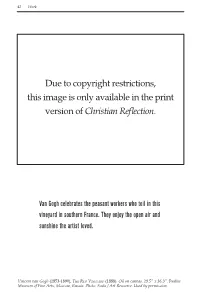
Working in Fields of Sunshine by HEIDI J
42 Work Due to copyright restrictions, this image is only available in the print version of Christian Reflection. Van Gogh celebrates the peasant workers who toil in this vineyard in southern France. They enjoy the open air and sunshine the artist loved. Vincent van Gogh (1853-1890), THE RED VINEYARD (1888). Oil on canvas. 29.5” x 36.3”. Puskin Museum of Fine Arts, Moscow, Russia. Photo: Scala / Art Resource. Used by permission. Copyright © 2015 Institute for Faith and Learning at Baylor University 43 Working in Fields of Sunshine BY HEIDI J. HORNIK he workers depicted here by Vincent van Gogh are the subject of the only painting by the artist known to have been purchased during This lifetime. It is believed that he painted the vineyard from memory. Van Gogh had worked and studied in London, Antwerp, and The Hague. But it is not until seeing the paintings of the Impressionists and Post-Impressionists in Paris that he changed his palette dramatically in 1887 to use brighter, less opaque colors. Like the Impressionists, he painted from life, preferred the use of natural light, and employed the synthetic evocation of color through Divisionism (the juxtaposition of small touches of pure, unmixed pigment directly on the canvas). This last characteristic became the expressive trademark of his later works.1 In February 1888, Van Gogh left the bustle of Paris to live in Arles, a small town in southern France. He was inspired by Jean-Francois Millet’s paintings that focused on the work of the common peasant. Van Gogh enjoyed studying the workers as he viewed the golden wheat fields, the blossoming orchards, and sunflowers that appear in his later and most famous paintings. -

The Artists of Les Xx: Seeking and Responding to the Lure of Spain
THE ARTISTS OF LES XX: SEEKING AND RESPONDING TO THE LURE OF SPAIN by CAROLINE CONZATTI (Under the Direction of Alisa Luxenberg) ABSTRACT The artists’ group Les XX existed in Brussels from 1883-1893. An interest in Spain pervaded their member artists, other artists invited to the their salons, and the authors associated with the group. This interest manifested itself in a variety of ways, including references to Spanish art and culture in artists’ personal letters or writings, in written works such as books on Spanish art or travel and journal articles, and lastly in visual works with overtly Spanish subjects or subjects that exhibited the influence of Spanish art. Many of these examples incorporate stereotypes of Spaniards that had existed for hundreds of years. The work of Goya was particularly interesting to some members of Les XX, as he was a printmaker and an artist who created work containing social commentary. INDEX WORDS: Les XX, Dario de Regoyos, Henry de Groux, James Ensor, Black Legend, Francisco Lucientes y Goya THE ARTISTS OF LES XX: SEEKING AND RESPONDING TO THE LURE OF SPAIN by CAROLINE CONZATTI Bachelor of Arts, Manhattanville College, 1999 A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of The University of Georgia in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree MASTER OF ARTS ATHENS, GEORGIA 2005 © 2005 CAROLINE CONZATTI All Rights Reserved THE ARTISTS OF LES XX: SEEKING AND RESONDING TO THE LURE OF SPAIN by CAROLINE CONZATTI Major Professor: Alisa Luxenberg Committee: Evan Firestone Janice Simon Electronic Version Approved: Maureen Grasso Dean of the Graduate School The University of Georgia December 2005 iv ACKNOWLEDGEMENTS I would like to thanks the entire art history department at the University of Georgia for their help and support while I was pursuing my master’s degree, specifically my advisor, Dr. -

James Ensor the Entry of Christ Into Brussels in 1889
James Ensor The Entry of Christ into Brussels in 1889 Pandora Publishers James Ensor The Entry of Christ into Brussels in 1889 Xavier Tricot WITH THE SUPPORT OF BART VERSLUYS In memory of Martine Franck and Henri Cartier-Bresson pp. 6-7 Martine Franck The Salon bleu Ensor’s house Ostend, 22 April 1998 © Magnum Photos The Entry of Christ into Brussels is a world one would like to study at leisure, providing countless resources to those who take it upon themselves to explore it. This is certainly one of the boldest, strangest and most disconcerting works that a modern artist has ever undertaken. Waldemar-George, 1926 contents 10 Acknowledgements 11 Foreword by Timothy Potts 13 Introduction 15 Situating the painting — 15 The significance of the title 20 Four studio photos as research sources 31 Analysis of the painting — 31 Significance of the subject 33 Composition and perspective 38 Figures and characters 55 Sources — 55 Religious sources The Gospels Jesus’s return to Earth 57 The figure of Jesus in the nineteenth century 63 Pictorial sources Historical painting Religious painting French painting English caricature Japanese prints 94 Folkloric and historical sources The carnival Joyous Entries and historical & religious processions The Brussels Ommegang The Saint-Verhaegen The Blessing of the Sea in Ostend 108 Literary sources Balzac and Jésus-Christ en Flandre Dostoevsky and The Brothers Karamazov 115 Aspects and context 188 Published studies on The Entry — 188 Exhibitions of The Entry 115 ‘A Picture of Belgium’ in 192 The sale of The -

Heritage Days 14 & 15 Sept
HERITAGE DAYS 14 & 15 SEPT. 2019 A PLACE FOR ART 2 ⁄ HERITAGE DAYS Info Featured pictograms Organisation of Heritage Days in Brussels-Capital Region: Urban.brussels (Regional Public Service Brussels Urbanism and Heritage) Clock Opening hours and Department of Cultural Heritage dates Arcadia – Mont des Arts/Kunstberg 10-13 – 1000 Brussels Telephone helpline open on 14 and 15 September from 10h00 to 17h00: Map-marker-alt Place of activity 02/432.85.13 – www.heritagedays.brussels – [email protected] or starting point #jdpomd – Bruxelles Patrimoines – Erfgoed Brussel The times given for buildings are opening and closing times. The organisers M Metro lines and stops reserve the right to close doors earlier in case of large crowds in order to finish at the planned time. Specific measures may be taken by those in charge of the sites. T Trams Smoking is prohibited during tours and the managers of certain sites may also prohibit the taking of photographs. To facilitate entry, you are asked to not B Busses bring rucksacks or large bags. “Listed” at the end of notices indicates the date on which the property described info-circle Important was listed or registered on the list of protected buildings or sites. information The coordinates indicated in bold beside addresses refer to a map of the Region. A free copy of this map can be requested by writing to the Department sign-language Guided tours in sign of Cultural Heritage. language Please note that advance bookings are essential for certain tours (mention indicated below the notice). This measure has been implemented for the sole Projects “Heritage purpose of accommodating the public under the best possible conditions and that’s us!” ensuring that there are sufficient guides available. -

PDF Files 04Journal
Poets as Modern Art Critics: Stating the “Redemptive Power” of the Abstracted Image Mary Dezember New Mexico Institute of Mining and Technology Si nous savions, tous les dieux s’éveilleraient. [If we knew, all the gods would awaken.] — poet and art critic Apollinaire1 n the essay “The Spiritual Problem of Modern Man,” C.G. Jung defines the I“completely modern” person as one who “has come to the very edge of the world, leaving behind him all that has been discarded and outgrown, and acknowl- edging that he stands before a void out of which all things may grow” (197). This image of the modern person edged onto an abyss of hope holds, simultaneously, despair and promise — and a need for faith to go forward when there is seem- ingly nowhere to go. However, during the Renaissance, when humankind began its progression to modernity and to the “edge of the world,” the intellect began its gain in supremacy over faith, delegating faith to the realm of superstition and “dark age” thinking. By the eighteenth century, intellect was sovereign, and faith had no credibility during such a reasonable age. Art corresponded with the times, as images in painting moved away from religious depictions and the God-image,2 becoming more secular. By the early nineteenth century, artists began replacing the concrete, traditional religious images of faith with abstracted images that emphasized their compositional elements, specifically color and shape.3 By the mid-nineteenth century, art was becoming a quasi-religion composed of these secular symbols of color and shape, and art critics as the modern “priests” to deci- pher these symbolic codes for the public emerged. -

Maître De La Démesure (1866-1930) 24/05 22/09/2019
Au cœur de votre culture Henry(1866-1930) de Grouxmaître de la démesure 24/05 u22/09/2019 “Ik heb de Belgische schilder Henry de Groux leren kennen bij Félicien Rops, zijn landgenoot”, schreef de beroemde kunsthandelaar Ambroise Vollard, in zijn memoires, Herinneringen van een kunsthandelaar. De car- rière van de jonge de Groux begint midden de jaren 1880 in Brussel, om verder te lopen in Frankrijk en vervolgens in Italië. Félicien Rops was bevriend met Henry’s vader, Charles Degroux, en speelde de rol van raadgever en beschermer van de jonge kunstenaar. Henry de Groux wordt in 1866 geboren in Sint-Joost-ten-Node, bij Brussel. Hij volgt les bij Jean-François Portaels aan het Brussels Atelier libre, maar moet daar op zijn zeventiende een punt achter zetten. In 1885 stelt hij zijn eer- ste werken tentoon met de groep L’Essor in Brussel. Een jaar later wordt hij opgenomen in de kunstenaarsgroep Les XX, waarmee hij aan drie jaarlijkse tentoonstellingen deelneemt (1887- 1889). Zijn beroemdste werk, Le Christ aux outrages, schildert hij in 1888-1889. Hij zal het in 1892 tentoonstellen in een schuur en gaat zo meteen over heel wat artistieke tongen. Intussen is hij bedreigd met uitsluiting van de groep Les XX, omdat hij weigert zijn werken naast werk van Van Gogh te hangen. Henry de Groux is voortdurend op zoek naar kopers of mecenassen die hem kunnen en willen helpen om zijn grandioze projecten uit te voeren. Hij reist heen en weer tussen Parijs, Brussel, Florence, Avignon en Marseille. Daar leidt hij een woelig leven, altijd ten prooi aan geldtekort. -

Henry De Groux, Peintre Antimoderne À La Fin Du Xix E Siècle
04 Les Errants, ca 1889-1890, I craie noire et de couleur, encre de Chine et gouache sur papier marouflé sur carton, 87,3 x 72,5 cm. Bruxelles, musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 6302 Henry de Groux, peintre antimoderne à la fin du XIXe siècle DENIS LAOUREUX Henry de Groux n’est pas né dans une dynastie de Groux étaient inscrits3. Les responsables de L’Art d’artistes comme les Kindt, les Ronner, les Meunier, moderne et du cercle des XX ont certainement dû les Danse ou encore les Stevens qui lui sont contem- rappeler Charles Degroux à leur souvenir en voyant porains. Bien évidemment, son père, Charles apparaître aux cimaises de l’Essor au milieu des Degroux, est un peintre très intégré au monde de années 1880 le patronyme d’un ami cher. Félicien l’art belge1, mais il est le seul artiste de la famille Rops et Alfred Stevens ont été des relais essentiels à et, quand sa mort précoce survient en 1870, son l’installation du jeune artiste en 1891 à Paris. fils Henry est âgé de quatre ans à peine. Si Henry De Groux franchit les portes de l’Académie de Groux n’a donc pas été formé par son père, en des beaux-arts de Bruxelles en octobre 1882. Les revanche, l’ombre de ce dernier a pris dans sa vie registres portent en effet la marque de son inscrip- la place d’un repère, et en cela il n’est peut-être tion. Il y reste un an. Peut-être est-ce dans ce cadre pas exagéré de dire que sa vocation artistique s’est qu’il rencontre Jan Toorop. -

Modernist Tendencies in the Literature of the Low Countries 1880-19'20
Modernist Tendencies in the Literature of the Low Countries 1880-19'20 A.P. Dierick to the majority of European citizens that a radical questioning of the very foundations and structures of Western society might be in order. I Fin de Siecle And yet such questioning and probing had already taken place in the initial phase of the bourgeoisie's The end of the nineteenth century and the begin rise to power. The conflict between the demands of ning of the twentieth is a period of transition in society and those made by the individual is stated the arts, often compared by historians and critics in philosophical terms by Jean Jacques Rousseau, in with earlier periods like the Baroque and Roman his contrast between natural and political man, in ticism. The term "mannerism" has been proposed his basic rejection of the "blessings" of civilization to describe such periods, in opposition to so-called and in his propagation of the myth of the "noble "classicist" periods. Whereas the latter may pro savage." In much more crude, but also more aggres duce art which, at its best, is exemplary and valid sive terms, the· Marquis de Sade elaborates a view for all times, or, conversely, art which is conven in which "natural" man is one, as Richard Gilman tional, derivative and facile, "mannerist" art periods writes, who "refuses to be bound by established val tend to break down the formal balance achieved in ues, inherited and institutionalized pieties" (81). In classicism, not through incompetence, but through Gilman's view, Sade was "the originator or, more a wilful calling into question of the norms by which accurately, the first compelling enunciator in mod the previously stable period of art has come to define ern times of the desire to be other than what soci itself. -

Press File Openning: 6 December 2013
Press File Openning: 6 december 2013 Under the High Patronage of Their Majesties the King and the Queen Press service MUSEE FIN-DE-SIECLE MUSEUM BE CULTURE General Manager: Séverine Provost Project Coordinators: Charlotte Materne (FR) [email protected] - +32 (0)484 82 19 43 Lore Lambrechts (DU) [email protected] - +32 (0)478 43 66 67 T: (0)2 644 61 91 - [email protected] - www.beculture.be Communication & External Relations ROYAL MUSEUMS OF FINE ARTS OF BELGIUM Press - Barbara Porteman [email protected] - +32 (0)2 508 34 08 www.fine-arts-museum.be 1 SUMMARY 1. EDITORIAL BY MICHEL DRAGUET 3 2. PRESS RELEASE 7 3. MUSÉE FIN-DE-SIÈCLE MUSEUM, A BEACON OF BELGIAN HERITAGE 8 4. MUSÉE FIN-DE-SIÈCLE MUSEUM WITH EDUCATEAM 20 5. A TECHNICAL CHALLENGE 21 6. A UNIQUE MULTIDISCIPLINARY PARTNERSHIP 24 7. MUSEE FIN-DE-SIECLE MUSEUM AND BASE DESIGN 30 8. EUROPALIA INDIA 31 9. VISITOR INFORMATION 32 2 1. EDITORIAL BY MICHEL DRAGUET Many contemporary studies see a major role for culture and, more particularly, for cultural heritage, in the development of an economy in Europe in order to break out of the crisis. Characterized as “old” and aware of the need to develop an economy based on sustainable development, Europe has to draw a vital impulse from what makes it historically distinctive : a knowledge economy rooted in a heri- tage that brings together, within a single perspective, natural sites and the evidence of an unrivalled past. In 2009 the first edition of the Forum d’Avignon emphasized this dual aspect of the development of our territory that would combine sustainable development with the promotion of our cultural heritage. -

Van Gogh and Britain 10
ART HISTORY REVEALED Dr. Laurence Shafe This course is an eclectic wander through art history. It consists of twenty two-hour talks starting in September 2018 and the topics are largely taken from exhibitions held in London during 2018. The aim is not to provide a guide to the exhibition but to use it as a starting point to discuss the topics raised and to show the major art works. An exhibition often contains 100 to 200 art works but in each two-hour talk I will focus on the 20 to 30 major works and I will often add works not shown in the exhibition to illustrate a point. References and Copyright • The talks are given to a small group of people and all the proceeds, after the cost of the hall is deducted, are given to charity. • The notes are based on information found on the public websites of Wikipedia, Tate, National Gallery, Oxford Dictionary of National Biography, Khan Academy and the Art Story. • If a talk uses information from specific books, websites or articles these are referenced at the beginning of each talk and in the ‘References’ section of the relevant page. The talks that are based on an exhibition use the booklets and book associated with the exhibition. • Where possible images and information are taken from Wikipedia under 1 an Attribution-Share Alike Creative Commons License. • If I have forgotten to reference your work then please let me know and I will add a reference or delete the information. 1 ART HISTORY REVEALED 1. Impressionism in London 1. -

Dossier De Presse
DOSSIER DE PRESSE Exposition Henry de Groux : Un symboliste engagé Du 6 février au 22 mars 2015 Vernissage le 6 février 2015 à partir de 18h30 Musée de La Roque d’Anthéron – Cours Foch Mercredi 4 mars 2015- 18h au Musée- Conférence de Alain Anquetin : « Henry de Groux et les peintres de la Grande guerre » Le Musée (anciennement Musée de Géologie et d’Ethnographie) de La Roque d’Anthéron sis Cours Foch inaugure ses locaux avec une exposition des œuvres du peintre Henry de Groux, les œuvres de cet artiste (huiles sur toiles, fusains, gravures ) prêtées par ses héritiers et par des collectionneurs seront montrées au public en première mondiale dans un musée. Henri de Groux un des plus grands peintres symbolistes de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, fut l’ami de Léon Bloy, défendit Zola dans l’affaire Dreyfus, alla le chercher à sa sortie de prison, se disputa violemment avec Van Gogh trois semaines avant le suicide de celui-ci. Son œuvre fut comparée à celle de Munch . Gauguin le considérait comme le peintre le plus important du XIXème siècle, Debussy, son protecteur le qualifiait affectueusement de « ce pitre de de Groux ..avec dans les yeux tous les rêves du monde », Apollinaire louait « sa fougue visionnaire » Henry de Groux naît en Belgique en 1866, près de Bruxelles, fils cadet du peintre belge Charles Degroux attaché à la représentation du réalisme social en Belgique. Son père meurt lorsqu’il a 4 ans, la pauvreté dans laquelle il vit alors le placera dans l’impossibilité de pouvoir apprendre les bases techniques de la peinture, chose qu’il regrettera toute sa vie.