La Salvation Army E Le Donne Della Working-Class
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Religion and Working-Class Culture in Ontario, 1882-1890
The Knights of Labor and the Salvation Army: Religion and Working-Class Culture in Ontario, 1882-1890 Lynne Marks IN 1883 THE SALVATION ARMY marched on Kingston. Intense excitment pervaded the town, with the Army hall packed night after night As was the case in towns and cities across Ontario, most of the men and women who flocked to the Salvation Army's tumultuous all-night meetings and rowdy parades were working-class. In Kingston, working-class involvement is seen most vividly in reports that in the town's major factories, "noon day prayer meetings amongst the working men are established.Jind conducted by the men themselves".1 By 1887 a very different working-class movement gripped the same workplaces. Workers at Kingston's Victoria Foundry, the Locomotive Works, and the cotton mill, who had organized Salvation Army prayer meetings four years earlier, now had joined the Knights of Labor (K of L). In May 1887, they were out on strike.2 Bom the Knights of Labor, a major working-class organization, and the Salvation Army, which in this period was an exclusively revivalistic movement, drew mass support from Ontario's working class. It is no coincidence that both movements appeared in the 1880s, and saw their period of greatest strength in this decade. Industrialization first emerged in Ontario after mid-century, but was not well established until the 1870s and more particularly, the 1880s. In tiny villages and small towns across the province, as well as in larger centres, industrial wage work had become a way of life for many Ontarians.3 Choroid Post, 23 March 1883 (letter from Kingston). -

Proceed I Ngs Wesley Historical Society
Proceed ings OFTHE Wesley Historical Society Editor: E. ALAN ROSE, B.A. Volume XLVIII May 1992 THE ORIGINS AND GROWfH OF PRIMITIVE METHODISM IN FAST SURREY ESCRlrTIONS of southern England as poor territory for Nonconformity abound in the writings of nineteenth-<:entury D ministers and laity. Seeing Anglicanism as wholly predominant in the South, contemporary observers were quick to draw connections between the perceived ecclesiastical tyranny of the Established Church and the social and political domination of the squirearchy. The Congregationalist,John Burnet, in 1844 wrote of this 'spiritual despotism' in rural Surrey that 'the clergy and gentry who practise this contemptible, petty tyranny, seem to be quite unconscious oftheir self-degradation.' I The establishmentofthe Surrey Congregational Union in 1862-63 followed on directly from the perception of continuing failure in the county, where 'Nonconformity had made less progress... than any other county of England.'~ Baptists faced the same difficulties.:! So too did Methodists: W. W. Pocock as late as the 1880s described Hampshire, Surrey and Sussex as a 'Methodist wilderness' in which more than 500 parishes were without a Methodist chapel or Methodist preaching, and he claimed that, in Surrey and Sussex, 'where Methodism has no hold, the contrasted evils of superstitious Anglicanism and of fatalistic and antinomian Dissent too commonly divide the ground between them', though it was hard in practice to claim much influence for the latter.4 As with the Congregationalist~ and Baptists, the efforts ofWesleyans to reach out from London to the villages and towns of southern England were given L Quoted in J.Waddington, Surrry (AJngrpgationai History (1866), p.135. -

Boundless East End Tours
. India of film including internationally, Salvation Army in East London, Britain and and Britain London, East in Army Salvation short films from the historic work of The The of work historic the from films short historian, will be presenting a number of of number a presenting be will historian, Archives Film event: Tony Fletcher, film film Fletcher, Tony event: Film Archives 9.30am – 4pm – 9.30am July 6 Monday Thursday 9 July at 6 – 7pm – 6 at July 9 Thursday Closed July 5 Sunday development of The Salvation Army in the East End East the in Army Salvation The of development 5pm – 10am July 4 Saturday explore unique historical materials that chart the the chart that materials historical unique explore 5pm – 9.30am July 3 Friday - June 30 Tuesday Workshop: William Booth’s East End. A chance to to chance A End. East Booth’s William Workshop: 8pm – 9.30am June 29 Monday 277 Bancroft Road, London E1 4DQ E1 London Road, Bancroft 277 Heritage Centre will be open as follows: as open be will Centre Heritage Archives, and Library History Local Hamlets Tower During the 150th anniversary Boundless Congress, the the Congress, Boundless anniversary 150th the During 2.30pm June, 30th Tuesday 484 stop outside the College. the outside stop 484 Library and Archives and Library History Bus routes Bus and 185 176, 40, : Station Hill Denmark Station: Train Closest 11 Tower Hamlets Local Local Hamlets Tower SE5 8BQ SE5 of The Salvation Army in East London. East in Army Salvation The of London Camberwell, of short films from the past and present work work present and past the from films short of College, Booth William (Salvation Army) will be presenting a number number a presenting be will Army) (Salvation Centre Heritage International Anscombe John event: Film Archives Saturday 4 July 2.30 – 3.30pm – 2.30 July 4 Saturday to 5.30pm and on Saturday from 11am to 4pm. -
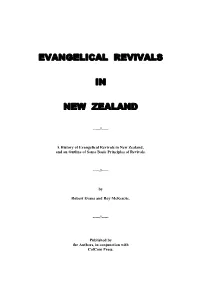
Evangelical Revivals in New Zealand, and an Outline of Some Basic Principles of Revivals
EVANGELICAL REVIVALS IN NEW ZEALAND -----//----- A History of Evangelical Revivals in New Zealand, and an Outline of Some Basic Principles of Revivals. -----//----- by Robert Evans and Roy McKenzie. -----//----- Published by the Authors, in conjunction with ColCom Press. PREFACE Many years of experience in the Lord's work, and the relative ease of retirement from parish responsibilities, have provided both of us with the time to carry out a work of love in presenting to the public this history of evangelical revivals in New Zealand. It is an aspect of the work of God which we believe is of enormous importance, both for church and for society, but which has been widely neglected for many years. The research for this book has relied, in the first instance, upon our privately-owned library resources. The main public libraries to which we are indebted are the New South Wales Uniting Church Archives Library and the Camden Library of the United Theological College, both in North Parramatta, the Hewitson Library of the Knox Theological Hall in Dunedin, the John Deane Memorial Library of the Bible College of New Zealand in Auckland (formerly The New Zealand Bible Training Institute), the Moore College Library (Anglican) in Sydney, and the Alexander Turnbull Library in Wellington. We also acknowledge the help of Miss Ferne Weimer, Director of the Billy Graham Center Library, in Wheaton, Illinois. We have also been indebted to many individuals. Chief amongst these have been the Rev. Dr. J. Graham Miller, now living in Wangaratta, Victoria, Dr. Brett Knowles of Dunedin, and the Rev. John Thomson, now living in Nelson. -

50TH Anniversary Events
June 2015 Opening Times Tues: 10am-5pm Wed: 9am-5pm Thu: 9am-8pm Fri: closed Sat: (1st & 3rd of the month): 9am-5pm Sun, Mon: closed Contact Us Send us your enquiry via email, phone or letter at Tower Hamlets Local History Library and Archives #50TH anniversary events 277 Bancroft Road London E1 4DQ Our latest exhibition here at Tower Hamlets Local History Library & Archives was launched last week to a great Phone: 020 7364 1290 reception, and will be on display until Thursday 6 August. It Email: explores the fifty years since the establishment of the [email protected] London Borough of Tower Hamlets through a detailed exploration of over 100 items from our collections. We have Visit our website at programmed a series of free public events on this theme, www.ideastore.co.uk taking place here and across the borough, over the next two months. If you can't make it to the exhibition in person, check out some images from our collections which are featured in London Councils' 50th anniversary online gallery. Tour of the former Bethnal Green Town Hall Town Hall Hotel, Patriot Square, London E2 9NF Monday 1 June, 11am - 12pm Join us for a tour of the Town Hall Hotel, used until the 1990s by the local authority and formerly the Bethnal Green Town Hall. This will be led by the hotel's General Manager, Marie Baxter. Free. To book, email: [email protected] or telephone: 020 7364 1290. Tour of the former Vestry Hall of Mile End Old Town Tower Hamlets Local History Library & Archives Monday 1 June, 2 - 3pm Join us for a tour of the former Vestry Hall of Mile End Old Town, led by Natasha Luck, Heritage Officer (Archives). -

The Salvation Army: Signalling New Religious Possibilities
The Salvation Army: Signalling New Religious Possibilities Mark Knight, Lancaster University Although The Salvation Army formally came into existence in 1878, the movement founded by William and Catherine Booth began life much earlier. The Booths started out as itinerant evangelists in the 1850s, initially with the Methodist New Connexion and then, from 1861, as independents. In 1865, they moved to London and began running the East London Christian Mission. It was here, in London’s East End, that the work of The Salvation Army took shape. Alongside the evangelical focus on preaching the gospel and calling sinners to conversion, the work featured a Methodist-inspired emphasis on holiness teaching and instruction on how one should live a godly life, a concern for those on the margins of society, and an accentuated version of the activism that was a defining characteristic of the wider evangelical movement. Explaining the distinctive hue of The Salvation Army in his preface to In Darkest England and the Way Out (1890), William Booth asked: “what is the use of preaching the Gospel to men whose whole attention is concentrated upon a mad, desperate struggle to keep themselves alive” (45)? Believing their spiritual movement to be engaged in a battle of apocalyptic proportions, the Booths sought to mobilise recruits into a revolutionary and disciplined unit. With the change of title in 1878, William Booth installed himself as General, encouraged followers to wear soldier-like uniforms, and used militaristic vocabulary at every opportunity. Leaders were referred to as officers, members were described as soldiers, and local gathered communities were named corps rather than churches. -

Photo Collection D
PHOTOGRAPH COLLECTION D D. William Booth – the Founder of The Salvation Army TEACHERS’ NOTES – BACKGROUND INFORMATION The following information gives the teacher an insight into the life of the founder of The Salvation Army and a background into how The Salvation Army started. William Booth was born in Nottingham on April 10th, 1829. His father, Samuel Booth, was a poor man without education who had one ambition in life – to gain lots of money! However, this ambition was not realised as he made and lost his fortune even before the birth of William, his son. William’s mother, Mary, was a quiet, reserved woman, who, like her husband Samuel, was very proud. Even though Samuel Booth had little money, he was still determined to send his son to a good school. Unfortunately when William turned thirteen years of age, his father could no longer afford to pay for his schooling and so William’s education ended and he was sent to work. Due to Samuel Booth’s passion for money, he decided to choose a career for his son, William, which would earn him good money. He apprenticed him for six years to a pawnbroker. This was in Nottingham in 1842 and here William saw what poverty was really like. He saw people pawn their belongings and then spend money getting drunk to try and forget their misery. Employers, in Victorian times, gave very low wages and the only place for people to go was the pub, which used to stay open most of the day and night. At the age of only 15, Booth decided to do something about what he saw around him. -
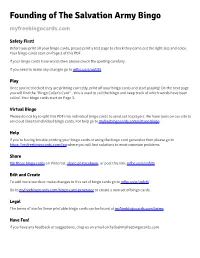
Founding of the Salvation Army Bingo Myfreebingocards.Com
Founding of The Salvation Army Bingo myfreebingocards.com Safety First! Before you print all your bingo cards, please print a test page to check they come out the right size and color. Your bingo cards start on Page 3 of this PDF. If your bingo cards have words then please check the spelling carefully. If you need to make any changes go to mfbc.us/e/uqfzt5 Play Once you've checked they are printing correctly, print off your bingo cards and start playing! On the next page you will find the "Bingo Caller's Card" - this is used to call the bingo and keep track of which words have been called. Your bingo cards start on Page 3. Virtual Bingo Please do not try to split this PDF into individual bingo cards to send out to players. We have tools on our site to send out links to individual bingo cards. For help go to myfreebingocards.com/virtual-bingo. Help If you're having trouble printing your bingo cards or using the bingo card generator then please go to https://myfreebingocards.com/faq where you will find solutions to most common problems. Share Pin these bingo cards on Pinterest, share on Facebook, or post this link: mfbc.us/s/uqfzt5 Edit and Create To add more words or make changes to this set of bingo cards go to mfbc.us/e/uqfzt5 Go to myfreebingocards.com/bingo-card-generator to create a new set of bingo cards. Legal The terms of use for these printable bingo cards can be found at myfreebingocards.com/terms. -

"Recent Evangelistic Movements in Great
1884.] RECENT EVANGELISTIO MOVEMENTS. 849 sense, keenly sensitive to the facts of history, and weighs them with a judicial mind. Meanwhile, the writings of this school have been the occasion of a more general and thoughtful study of the Old Testament history and literature among Christian scholars, and seem likely to usher in the dawn of a genuine Old Testament renaissance. ARTICLE VIII RECENT EVANGELISTIC MOVEMENTS IN GREAT BRITAIN AND ON THE CONTINENT.' BY BBT. I.unJBL IVB8 OURTI88. D.D., PllOI'B880B 111 OHI04GO THBOLOGIC4L 8BK11I4RT. Tms is an age of great cities. London, Paris, Berlin, and Yienna are growing in population and magnificence every year. And there are a score of other cities on the continent that are opening their gates for the thronging multitudes. For weal or woe the masses are deserting the country and pressing to the cities, until, as has been estimated, from a fifth to a seventh of the population of some countries live in cities. As the battle centres where the enemy is most thickly gathered, we shall find that the recent evangelistic movements have been especially confined to cities and 1arge towns. These movements have sprung from certain needs. Loudon, Paris, Berlin are each situated at the foot of slumbering volcanoes. To the ordinary eye all is calm and peaceful; and but for an occasional wreath of smoke around tIle sum mits of the heights that overhang them, there would be no suspicion of those molten streams that are liable to leap forth at any moment, carrying ruin and death in their train. -

"In Darkest England and the Way Out" the Salvation Army, Social Reform and the Labour Movement, 1885-1910*
VICTOR BAILEY "IN DARKEST ENGLAND AND THE WAY OUT" THE SALVATION ARMY, SOCIAL REFORM AND THE LABOUR MOVEMENT, 1885-1910* The British bourgeois [...] finally [...] accepted the dan• gerous aid of the Salvation Army, which revives the propa• ganda of early Christianity, appeals to the poor as the elect, fights capitalism in a religious way, and thus fosters an element of early Christian class antagonism, which one day may become troublesome to the well-to-do people who now find the ready money for it. F. Engels1 In the past decade a prominent theme in the historiography of nineteenth-century Britain has been the imposition of middle-class habits and attitudes upon the populace by means of new or re-invigorated mechanisms of "social control". To the apparatus of law enforcement and to the disciplines of the factory and wage labour, historians have added the less overt instruments of social welfare, education, religion, leisure and moral reform. Philanthropists, educators, clergymen and moralizers have all become soldiers in a campaign to uproot the "anti-social" character• istics of the poor and to cement the hegemony of the elite.2 Not surprisingly, the concept of "social control", and the depiction of the activities and institutions of the propertied as effective instruments of social discipline, have run into opposition. Most significant, for present purposes, is F. M. L. Thompson's objection that the idea of social control * The research for this paper was greatly facilitated by the R. T. French Visiting Professorship, which links the University of Rochester, New York, and Worcester Col• lege, Oxford. -

The Army of Tennessee in War and Memory, 1861-1930
University of Tennessee, Knoxville TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange Doctoral Dissertations Graduate School 8-2016 Experiencing Defeat, Remembering Victory: The Army of Tennessee in War and Memory, 1861-1930 Robert Lamar Glaze University of Tennessee, Knoxville, [email protected] Follow this and additional works at: https://trace.tennessee.edu/utk_graddiss Part of the Cultural History Commons, Military History Commons, Other History Commons, Social History Commons, and the United States History Commons Recommended Citation Glaze, Robert Lamar, "Experiencing Defeat, Remembering Victory: The Army of Tennessee in War and Memory, 1861-1930. " PhD diss., University of Tennessee, 2016. https://trace.tennessee.edu/utk_graddiss/3860 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. It has been accepted for inclusion in Doctoral Dissertations by an authorized administrator of TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. For more information, please contact [email protected]. To the Graduate Council: I am submitting herewith a dissertation written by Robert Lamar Glaze entitled "Experiencing Defeat, Remembering Victory: The Army of Tennessee in War and Memory, 1861-1930." I have examined the final electronic copy of this dissertation for form and content and recommend that it be accepted in partial fulfillment of the equirr ements for the degree of Doctor of Philosophy, with a major in History. Stephen V. Ash, Major Professor We have read this dissertation and recommend its acceptance: Luke E. Harlow, Daniel Feller, Martin Griffin Accepted for the Council: Carolyn R. Hodges Vice Provost and Dean of the Graduate School (Original signatures are on file with official studentecor r ds.) Experiencing Defeat, Remembering Victory The Army of Tennessee in War and Memory, 1861-1930 A Dissertation Presented for the Doctor of Philosophy Degree The University of Tennessee, Knoxville Robert Lamar Glaze August 2016 Copyright © 2016 by Robert L. -

The Knights of Labor and the Salvation Army: Religion and Working-Class Culture in Ontario, 1882-1890 Lynne Marks
Document generated on 09/28/2021 12:12 p.m. Labour/Le Travailleur The Knights of Labor and the Salvation Army: Religion and Working-Class Culture in Ontario, 1882-1890 Lynne Marks Volume 28, 1991 Article abstract In the 1880S both the Knights of Labor, and the Salvation Army, which in this URI: https://id.erudit.org/iderudit/llt28art03 period was an exclusively revivalistic movement, drew mass support from Ontario's working class. This paper looks at the nature of working class support See table of contents for the two movements, noting that the Salvation Army was more likly to attract working class women and unskilled men, while the Knights were most popular among skilled men. The possibility of overlap in membership is also Publisher(s) addressed. In assessing the appeal of the two movements to working class Ontarians the Canadian Committee on Labour History relationship between working class religion and class consciousness is explored. Christianity was clearly important to many individual Knights, and ISSN fueled the Order's class conscious critique of nineteenth century society. The 0700-3862 (print) Salvation Army's otherworldly emphasis meant that it ignored contemporary 1911-4842 (digital) social and economic issues; nonetheless the Army provided a distinctly working class religious alternative which was actively critical of the respectable mainstream churches. The popularity of both the Knights and the Explore this journal Army demonstrate the importance of class identity and religious belief within the late nineteenth century Ontario working class. Cite this article Marks, L. (1991). The Knights of Labor and the Salvation Army: Religion and Working-Class Culture in Ontario, 1882-1890.