PROVINCIA DI IMPERIA Ambito Territoriale Ottimale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Scents and Flavours
Typical products Boccadasse - Genoa Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “in Liguria” [email protected] www.turismoinliguria.it Seaside emotions Art Settings www.turismoinliguria.it History Trail Scents and flavours Sports itineraries A sea of gardens From the Woods, the Garden, and the Sea - a Taste of Ligurian Gastronomy - Shades of Flavours from Green to Blue. Publishing Info Publishing Project and All Rights reserved to Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “in Liguria”. Images: Archive Agenzia “in Liguria”, and “Regione Liguria” from “Prodotti di Liguria Atlante Regionale dei prodotti tradizionali” - except for page 3-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Slow Food Copyright. Graphic Project by: Adam Integrated Communications - Turin - Printed in 2008 - Liability Notice: notwithstanding the careful control checks Agenzia “in Liguria” is Farinata not liable for the reported content and information. www.turismoinliguria.it Scents and Tastes. In all Italian regions traditional recipes originate from the produce of the land. In Liguria the best ingredients are closely linked to sunny crops and terraces plummeting into the sea, to mountains, sandy and rocky beaches, valleys, and country plains. In this varied land fine cuisine flavours are enriched by genuine and simple products, this is why the Ligurian tradition for gourmet food and wine is an enchanting surprise to discover along the journey. Cicciarelli of Noli www.turismoinliguria.it Gallinella 3 Extra Virgin Olive Oil. This magic fluid, with a unique consistency, is the olive groves nectar and the ingredient for Mediterranean potions. The Extra Virgin Olive Oil of the Italian Riviera now has a millenary tradition. -

La Val Nervia Media Alta Val Nervia Alta Val Nervia
La Val Nervia Media alta Val Nervia Alta Val Nervia UN PANORAMA STORICO-ECONOMICO Economia Insediamenti generali nella Val Nervia 5 6 La Val Nervia La Val Nervia è da sempre un punto nevralgico per il controllo del commercio. Ancora nel XX secolo pare fosse attiva la casella di Dazio (qui ci si doveva fermare per esibire le merci in transito per i controlli e le gabelle), ciò testimonia limportanza SP65 del sito quale luogo di controllo e di passaggio tra lItalia e la Francia. Il torrente Nervia, a cui la Valle deve il suo nome, nasce dalle pendici meridionali dei monti Toraggio e Pietravecchia e sfocia in mare vicino a Ventimiglia, arricchito FRANCIA da numerosi tributari. La Val Nervia è caratterizzata, come le altre valli del Ponente ligure, da un clima mediterraneo temperato. SP64 Nelle valli laterali si osserva peraltro una notevole variabilità delle condizioni SP63 climatiche, in relazione allesposizione dei versanti. La parte più alta del bacino presenta condizioni climatiche più rigide, di tipo quasi alpino. SP68 Le temperature medie registrate sono rispettivamente 14,2°C per la media valle SP62 (Rocchetta Nervina, m 225) e 6,4°C per lalta valle (Colla Melosa, m 1600). SP70 Fiume Torrente SP59 SS20 SP69 SP64 Roja Nervia A10 A10 SS1 SS1 A10 Figura 1 - La Val Nervia MAR LIGURE 7 Media Val Nervia Alta Val Nervia Sistema vallivo delimitato dai crinali prevalenti e caratterizzato dalla maggior Sistema vallivo torrentizio delimitato dai crinali prevalenti, caratterizzato ampiezza della valle Nervia rispetto alle confluenti valli profondamente incise dai dallandamento del torrente Nervia e contraddistinto da alcune peculiarità naturali rii Bonda, Vetta e Merdanzo. -

CARATTERISTICHE ACQUE COSTIERE: Scheda 05 IMP ______A
CARATTERISTICHE ACQUE COSTIERE: scheda 05_IMP _______________________________________________________________________ a. IDENTIFICAZIONE DEL TRATTO DI COSTA Lunghezza Denominazione Codice inizio fine (Km) Imperia 0700800805 Foce Rio San Lorenzo Capo Berta 21,4 * Il codice è costruito con i seguenti campi: Codice Istat Regione Liguria Codice Istat Provincia in cui ricade il confine ovest del tratto Codice Istat Provincia in cui ricade il confine est del tratto Numero progressivo all’interno della Regione, da ovest ad est Coordinate (Gauss Boaga – fuso ovest) latitudine longitudine Inizio (ovest) 4855984 1416887 Fine (est) 4860953 1426362 Considerabile come corpo idrico di riferimento : NO Specifica destinazione : Balneazione: SI vita molluschi: NO acquacoltura: NO altro:NO Imperia 1 M05 CARATTERISTICHE ACQUE COSTIERE: scheda 05_IMP _______________________________________________________________________ b. CARATTERISTICHE DEL TRATTO COSTIERO Tipizzazione idrologica - geomorfologica (DM 131/08): rilievi montuosi - bassa stabilità. Descrizione geomorfologica Il tratto costiero, caratterizzato da un’alternanza di tratti rocciosi e di spiagge a prevalenza di ciottoli, ha subito numerosi interventi di opere a mare per cui per gran parte risulta artificiale. Il litorale comprende inoltre i due porti di Porto Maurizio e Oneglia, che racchiudono uno specchio acqueo, rispettivamente, di circa 75.000 mq e 90.000 mq. Il fondale è prevalentemente alto, tranne nel tratto centrale, lungo circa 4 km, antistante Imperia Porto Maurizio-Borgo Prino, che digrada più dolcemente verso il largo. Il fondo è sabbioso /sabbioso-pelitico. Biocenosi marine costiere ed aspetti naturalistici Nei fondali antistanti il tratto in questione sono presenti due siti di interesse comunitario: - “Fondali di Porto Maurizio S.Lorenzo al mare-Torre dei Marmi” (SIC marino IT 1315971), una parte dei quali ricadono nel tratto omogeneo a ponente “Santo Stefano”. -

Badalucco Bajardo Bordighera Borgomaro Camporosso Castellaro
Quota di riparto FONDO COMUNI LOCAZIONE 1 Alassio 40,541.92 2 Albenga 24,135.18 3 Albisola Superiore 43,863.12 4 Albissola Marina 16,557.54 5 Altare 5,828.47 6 Ameglia 6,851.26 7 Andora 24,830.85 8 Arcola 7,790.42 9 Arenzano 12,204.19 10 Avegno 4,260.20 11 Badalucco 1,639.64 12 Bajardo 1,108.81 13 Bargagli 9,256.73 14 Bogliasco 9,043.38 15 Boissano 2,689.69 16 Bolano 10,815.32 17 Bonassola 2,353.76 18 Bordighera 10,535.78 19 Borghetto Santo Spirito 19,081.22 20 Borgio Verezzi 5,843.83 21 Borgomaro 1,329.87 22 Bormida 1,333.11 23 Borzonasca 5,402.46 24 Busalla 8,785.86 25 Cairo Montenotte 11,077.47 26 Calice al Cornoviglio 1,697.98 27 Camogli 8,637.26 28 Campo Ligure 6,806.81 29 Campomorone 23,211.64 30 Camporosso 3,253.90 31 Carasco 7,696.77 32 Carcare 14,967.49 33 Casanova Lerrone 2,264.44 34 Casarza Ligure 11,676.99 35 Casella 4,951.43 36 Castellaro 1,297.34 37 Castelnuovo Magra 15,238.75 38 Castiglione Chiavarese 2,537.17 39 Celle Ligure 9,151.19 40 Cengio 6,647.44 41 Ceranesi 5,072.80 42 Ceriale 20,594.14 43 Ceriana 3,878.34 44 Cervo 4,549.89 45 Chiavari 21,748.58 Quota di riparto FONDO COMUNI LOCAZIONE 46 Chiusanico 1,725.70 47 Chiusavecchia 916.26 48 Cicagna 5,832.09 49 Cisano sul Neva 4,624.95 50 Cogoleto 15,522.07 51 Cogorno 14,717.94 52 Cosseria 3,180.16 53 Davagna 3,406.12 54 Deiva Marina 3,210.82 55 Diano Castello 3,311.33 56 Diano Marina 6,292.25 57 Dolceacqua 2,137.06 58 Dolcedo 2,577.13 59 Finale Ligure 57,918.04 60 Follo 7,416.98 61 Framura 1,989.84 62 Garlenda 3,449.93 63 Genova 446,099.43 64 Giustenice 2,902.96 65 Imperia -

Natura Bene Stato Accatastamento Indirizzo Completo Cod. Comune
Natura Bene Stato Indirizzo Completo Cod. Comune Sezione Sezione Urbana Foglio Particella Denominatore Tipo Particella Sub. Accatastamento Unità Immobiliare Accatastato VIA CAVOUR SNC H257 10 398 1 Ordinario 18026 Rezzo (IM) (IMPERIA) LIGURIA Unità Immobiliare Accatastato VIA CAVOUR SNC H257 10 398 2 Ordinario 18026 Rezzo (IM) (IMPERIA) LIGURIA Unità Immobiliare Accatastato VIALE VITTORIO G632 8 53 2 Ordinario VENETO 2 18026 Pieve di Teco (IM) (IMPERIA) LIGURIA Unità Immobiliare Accatastato VIALE VITTORIO G632 8 53 3 Ordinario VENETO 2 18026 Pieve di Teco (IM) (IMPERIA) LIGURIA Unità Immobiliare Accatastato VIA TORINO 11 G632 2 796 1 Ordinario 18026 Pieve di Teco (IM) (IMPERIA) LIGURIA Unità Immobiliare Accatastato Via Torino 15 G632 2 796 2 Ordinario 18026 Pieve di Teco (IM) (IMPERIA) LIGURIA Unità Immobiliare Accatastato Via Torino 13 G632 2 796 3 Ordinario 18026 Pieve di Teco (IM) (IMPERIA) LIGURIA Unità Immobiliare Accatastato Via Torino 9 18026 G632 2 796 4 Ordinario Pieve di Teco (IM) (IMPERIA) LIGURIA Unità Immobiliare Accatastato Corso Giacomo I138 42 1254 5 Ordinario Matteotti 18 18038 San Remo (IM) (IMPERIA) LIGURIA Unità Immobiliare Accatastato via roma 27 18022 C578 4 296 Ordinario Cesio (IM) (IMPERIA) LIGURIA Unità Immobiliare Accatastato Galleria Unione 5 F205 437 1 162 Ordinario 20122 Milano (MI) (MILANO) LOMBARDIA Natura Bene Stato Indirizzo Completo Cod. Comune Sezione Sezione Urbana Foglio Particella Denominatore Tipo Particella Sub. Accatastamento Unità Immobiliare Accatastato Galleria Unione 5 F205 437 1 264 Ordinario -

Dopo L'alluvione: Il Sindaco Adorno Scrive Al Governo “Renzi Aiutaci Tu
1 Dopo l’alluvione: il sindaco Adorno scrive al Governo “Renzi aiutaci tu”, viaggio a Rezzo isolato da una settimana di Giò Barbera – 29 Novembre 2016 – 17:54 Rezzo. “Caro Matteo, aiutaci tu, non lasciarci soli”. Una lettera scritta dal sindaco Renato Adorno che suona come un grido d’allarme per un paese, Rezzo, in Valle Arroscia, che ha subito danni gravissimi dopo l’alluvione di giovedì scorso: una casa è crollata, una seconda è stata seriamente danneggiata, una terza si è salvata per miracolo dopo che è esondato il rio Santa Lucia. Per arrivare in paese devi superare una montagna di detriti col fango che ti entra fin nelle ossa.Per superare la casa sventrata dal rio Santa Lucia salgo sulla benna dell’impresa incaricata di rimettere in sicurezza la strada, ora assolutamente impraticabile. Perché oltre alla carreggiata che costeggia il torrente Giara di Rezzo che conduce al paese, anche la strada per Cenova è stata stravolta dalla valanga di fango. In questa località, arrampicata sulle colline della Valle Arroscia, che raggiungo a bordo di un fuoristrada del capo cantiere, ci vivono 350 persone. Tutti ostaggio della frana che ha costretto a far abbassare la saracinesca del ristorante, dell’agriturismo e della pensione. Nel negozio di alimentari gestito dalla famiglia di Bruno Riviera24 - 1 / 3 - 28.09.2021 2 Bertone ci sono ancora un po’ di scorte. “Ancora qualche giorno poi saranno necessari rinfornimenti”, mi dice il titolare mentre con la scopa spazza via dall’ingresso del negozio quella patina di fango trasportata dalle auto che fanno la spola dal cantiere aperto alla piazza del Comune. -

Orario Invernale Dal 13 Settembre 2021 Al 8 Giugno 2022 A-Asssabaaaaaassasssbaalmgaaaba
ORARIO INVERNALE DAL 13 SETTEMBRE 2021 AL 8 GIUGNO 2022 www.rtpiemonte.it A-ASSSABAAAAAASSASSSBAALMGAAABA MOROZZO - Banca 07.10 MOROZZO - Morozzo / Fine paese 07.11 MOROZZO Distributore 07.12 MOROZZO - Morozzo 07.13 CRAVA - Via Umberto I / Via Fornace 07.13 CRAVA - Via Umberto I / Via DonRosso 07.14 CRAVA - Via Umberto I / Banca 07.15 CRAVA - Bivio Carleveri 07.18 CRAVA - Bivio Magliano FS 07.19 BREOLUNGI - Rotonda per Magliano 07.20 BREOLUNGI - Presso case/Fermata SAAR 07.22 CRAVA Ponte Pesio 07.22 MARTINETTO- Martinetto Scuole 07.24 MONDOVI - Bivio S.Giovanni 07.25 MONDOVì - Gazzola 07.30 MONDOVì - Piazza Mellano 07.32 MONDOVì - Corso Statuto 07.34 MONDOVI - Z. IND. 06.10 - MONDOVI FS 06.20 - 08.20 MONDOVI VIA CUNEO 06.22 - - MONDOVI - AGRARIO I 07.34 - 13.08 MONDOVI - BREO 06.28 07.35 - 13.12 13.12 13.13 MONDOVI - PIAZZA I 07.40 - I I 13.15 13.18 13.20 SANTUARIO DI VICOFORTE 06.38 08.30 13.18 13.18 13.25 13.28 13.30 SAN MICHELE 06.45 08.40 13.25 13.25 13.30 13.33 13.35 LESEGNO 06.53 08.44 13.35 13.35 13.35 13.38 13.40 MOMBASIGLIO I - I I 14.00 I I CEVA FS 07.00 07.05 08.20 08.20 09.00 09.00 12.20 13.35 I I I 13.50 I 14.20 15.00 16.35 17.30 18.30 19.30 20.20 20.30 CEVA I I I 09.07 I I 13.50 13.50 14.10 14.00 13.50 I I I I I I I I NUCETTO 07.15 08.25 08.30 09.20 12.30 13.45 14.05 14.05 14.05 14.05 14.25 15.10 16.45 17.40 18.40 19.40 20.25 20.40 BAGNASCO 07.20 08.32 08.35 09.25 12.35 13.50 14.10 14.10 14.10 14.10 14.32 15.15 16.50 17.45 18.45 19.45 20.31 20.45 PIEVETTA 07.23 08.38 08.38 09.29 12.38 13.53 14.15 14.14 14.15 14.15 14.38 -

COMUNE Provincia Funzionario Airole IMPERIA Alassio SAVONA
Aggiornato al 01-set-13 COMUNE Provincia Funzionario Airole IMPERIA Gambaro Alassio SAVONA Starnini Albenga SAVONA Starnini Albisola Superiore SAVONA Bulgarelli Albissola Marina SAVONA Bulgarelli Altare SAVONA Del Lucchese Ameglia LA SPEZIA Gervasini Andora SAVONA Starnini Apricale IMPERIA Gambaro Aquila di Arroscia IMPERIA Bottini Arcola LA SPEZIA Mancusi Arenzano GENOVA Traverso Armo IMPERIA Bottini Arnasco SAVONA Starnini Aurigo IMPERIA Bottini Avegno GENOVA Cagnana Badalucco IMPERIA Traverso Bajardo IMPERIA Gambaro Balestrino SAVONA Starnini Bardineto SAVONA Starnini Bargagli GENOVA Cagnana Bergeggi SAVONA Bulgarelli Beverino LA SPEZIA Mancusi Bogliasco GENOVA Traverso Boissano SAVONA Starnini Bolano LA SPEZIA Mancusi Bonassola LA SPEZIA Campana Bordighera IMPERIA Gambaro Borghetto d'Arroscia IMPERIA Bottini Borghetto di Vara LA SPEZIA Mancusi Borghetto s. Spirito SAVONA Starnini Borgio Verezzi SAVONA Del Lucchese Borgomaro IMPERIA Bottini Bormida SAVONA Del Lucchese Borzonasca GENOVA Cagnana Brugnato LA SPEZIA Mancusi Busalla GENOVA Traverso Cairo Montenotte SAVONA Del Lucchese Calice al Cornoviglio LA SPEZIA Mancusi Calice Ligure SAVONA Del Lucchese Calizzano SAVONA Starnini Camogli GENOVA Traverso Campo Ligure GENOVA Traverso Campomorone GENOVA Traverso Camporosso IMPERIA Gambaro Carasco GENOVA Campana Caravonica IMPERIA Bottini Carcare SAVONA Del Lucchese Carpasio IMPERIA Traverso Carro LA SPEZIA Campana Carrodano LA SPEZIA Campana Casanova Lerrone SAVONA Starnini Casarza Ligure GENOVA Campana Casella GENOVA Cagnana Castel Vittorio -

Indagine Su Beni E Strutture Culturali in Provincia Di Imperia
P.T.C della Provincia di Imperia – TEMA : BENI CULTURALI INDAGINE SU BENI E STRUTTURE CULTURALI IN PROVINCIA DI IMPERIA 1. - MAPPATURA EDIFICI VINCOLATI EX 1089 (D. LGS. n° 490 /1999) Sulla base dell’elenco gentilmente fornito, su supporto Excell, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria1 e grazie alla collaborazione della competente struttura della Regione Liguria, si è sviluppato un lavoro di reperimento dell’indirizzario dei Beni e quindi la mappatura informatica degli edifici interessati dal vincolo, operando in parte tramite conoscenza diretta, in parte previa ricerca presso gli uffici Tecnici Comunali. Contestualmente si è proceduto ad una elementare codifica degli edifici (o parti di edifici) suddividendoli in base alle seguenti voci (riferite alla funzione d’origine degli edifici stessi): A - BENI RELIGIOSI: cattedrale, chiesa, santuario, cappella, convento, cimitero, sepolcro. B - BENI CIVILI: palazzo, casa, casa con parco, villa, teatro, mercato, prigione, ponte, fontana, porta, giardino. C - BENI MILITARI: castello, torre, opera fortificata. E - EDIFICI INDUSTRIALI: oleifici, frantoi, mulini, fornaci. F - AFFRESCHI, BASSORILIEVI, ARCHITRAVI, colonne sovrapporte, piccole opere in esterno. G - BENI ARCHEOLOGICI (beni di palese tipologia archeologica). Il risultato del lavoro, comunque molto oneroso ed ancora perfezionabile, è espresso nella Carta di Mappatura Beni Culturali prodotta su base informatica georeferenziata, di contenuto molto elementare, pur tuttavia molto efficace nel consentire una prima identificazione delle Emergenze Monumentali in Provincia di Imperia, che devono essere considerate anche anche ai fini delle previsioni di interventi sul territorio. A partire da questa prima base cartografica è possibile procedere con celerità ad ulteriori verifiche di dettaglio delle localizzazioni, alla integrazione degli attributi assegnati ai Beni mediante acquisizione di informazioni anche di merito in relazione ai pregi architettonici ed artistici, all’accessibilità per la visita, ecc. -

Vallearroscia
La Strategia Nazionale per le Aree Interne e nuovi assetti istituzionali VALLE ARROSCIA Analisi delle soluzioni intercomunali proposte (31 ottobre 2019) Sintesi della diagnosi L’isomorfismo tra perimetro dell’area e ente di secondo livello (Unione di Comuni), costituito infatti ad hoc nella prospettiva della progettazione SNAI, rappresenta senz’altro un elemento di interesse, condizione utile anche se di per sé non sufficiente a rafforzare la governance del territorio nella prospettiva dell’impegnativa futura implementazione della strategia. Questa compattezza, infatti, richiederà un investimento nella struttura organizzativa, di cui allo stato attuale non sono state esplicitate le modalità. Il requisito associativo risulta soddisfatto in termini formali grazie a due delle funzioni fondamentali in capo all’Unione (I e E, Polizia municipale e polizia amministrativa locale; attività̀, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi) oltreché a una complessiva positiva valutazione dell’intero aggregato dei servizi trasferite. Si raccomanda tuttavia una necessaria e sostanziale precisazione del modello di funzionamento delle funzioni stesse, oggi di fatto prive di personale dedicato. 1. Analisi dei comuni dal punto di vista strutturale Il territorio della Valle Arroscia, ricompreso nella Provincia di Imperia, è interamente montano e omogeneo sotto il profilo delle caratteristiche strutturali. In modo non dissimile dai Comuni con queste caratteristiche, anche gli 11 comuni dell’area progetto -

IL RAID DELLA RIVIERA DEI FIORI Ritorna in Banchina!
IL RAID DELLA RIVIERA DEI FIORI ritorna in banchina! Questo importante e seguitissimo evento legato al mondo delle auto e moto d’epoca finalmente ritorna alle “origini”. A fine luglio 2016 gli amici dell’Associazione Autostory & c. Imperia organizzano il 5° RAID DELLA RIVIERA DEI FIORI con gradirti ritorni ed importanti novità PROGRAMMA DELL’EVENTO La manifestazione “5° RAID DELLA RIVIERA DEI FIORI” si svolgerà ad Imperia nei giorni 29- 30- 31 luglio prossimi. I primi due giorni le auto saranno ospitate presso la banchina di Oneglia Calata G. B. Cuneo ed il giorno 31 in Via Bonfante e Piazza Dante. Venerdì 29 luglio - Ore 14.00 inizio della manifestazione con accredito degli equipaggi - Ore 16.00 partenza per Diano Marina per una degustazione e shopping in Via Genova - Ore 19.00 rientro in banchina ed esposizione delle auto - Ore 20.30 cena in banchina Calata Cuneo Ristorante Matama - tel 0183.449947 Sabato 30 luglio - Ore 08.30 ritrovo in Calata Cuneo - Ore 9.30 partenza per tour gastronomico nell’entroterra - Ore 10.00 arrivo a Ceriana per la degustazione della famosa salsiccia di Ceriana: il prodotto più noto della gastronomia di questo territorio la cui ricetta di preparazione è gelosamente custodita dagli artigiani del paese. - Ore 12.00 arrivo a Bajardo e visita guidata alla chiesa di S. Nicol - Ore 13.00 degustazione a buffet di prodotti tipici - Ore 15.30 partenza per Imperia. Bajardo - Vignai- Badalucco – Carpasio - Dolcedo-Clavi - Imperia, Calata Cuneo - Ore 19.00 Cena di Gala presso il ristorante “Altamarea” con menù tipicamente ligure a base di Cappon magro e Coniglio alla Ligure Domenica 31 luglio - Ore 09.30 ritrovo in Via Bonfante - Imperia - Ore 10.30 partenza per un tour direzione Andora, Passo del Ginestro, Colle S. -
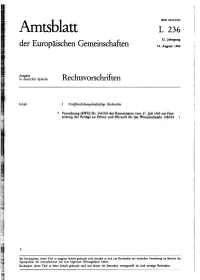
Page 1 Ww. W ::: ::: : : .. Inhalt Ausgabe in Deutscher Sprache I
ISSN 0376-9453 Amtsblatt L 236 32. Jahrgang der Europäischen Gemeinschaften 14. August 1989 Ausgabe in deutscher Sprache Rechtsvorschriften Inhalt I Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte * Verordnung (EWG) Nr. 2455/89 der Kommission vom 27 . Juli 1989 zur Fest setzung der Erträge an Oliven und Olivenöl für das Wirtschaftsjahr 1988/89 1 2 Bei Rechtsakten, deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind, handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im Bereich der Agrarpolitik, die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben. Rechtsakte, deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist, sind sonstige Rechtsakte. 14. 8 . 89 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 236/ 1 I (V?röjjentlichungsbedü rftige Rechtsakte) VERORDNUNG (EWG) Nr. 2455/89 DER KOMMISSION vom 27 . Juli 1989 zur Festsetzung der Erträge an Oliven und Olivenöl für das Wirtschaftsjahr 1988/89 DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN Aufgrund der erhaltenen Angaben sind diese Erträge wie GEMEINSCHAFTEN — im Anhang I angegeben festzusetzen . gestützt auf dien Vertrag zur Gründüng der Europäischen Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen Wirtschaftsgemeinschaft, entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus schusses iür Fette — gestützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des Rates vom 22. September 1966 über die Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation für Fette ('), zuletzt geän dert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1225/89 (2), HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN : gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2261 /84 des Rates vom 17 . Juli 1984 mit Grundregeln für die Gewährung Artikel 1 der Erzeugungsbeihilfe für Olivenöl und für die Oliven ölerzeugerorganisationen (3), zuletzt geändert durch die ( 1 ) Für das Wirtschaftsjahr 1988/89 werden die Erträge Verordnung (EWG) Nr.