LE DUE RIVOLUZIONI VERDI DEL XX SECOLO Seconda Parte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lettera Al CONAF Sul Prof. Girolamo Caruso
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI Ministero Della Giustizia Prot. 107 Trapani lì 26/06/2014 Al Presidente del CONAF Andrea Sisti, dottore agronomo [email protected] [email protected] Al Consigliere Coordinatore Dipartimento CONAF Comunicazione e Promozione Professionale – Vice Presidente CONAF Rosanna ZARI, dottore agronomo [email protected] Al Coordinatore del Centro Studi del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali Giancarlo Quaglia, dottore forestale [email protected] Oggetto: Riflessione sul Prof. GIROLAMO CARUSO, nato ad Alcamo (TP) e dal 1864 al 1917 Prof. Ordinario di Agronomia della R. Università di Pisa Il 14 giugno 2014, l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Trapani ha dato il patrocinio per l’organizzazione del Convegno “ Girolamo Caruso: lo scienziato, il docente, l’innovatore, ma soprattutto l’uomo che per primo ha dato dignità scientifica alla ricerca in campo agrario” - ha relazionato il Prof. Andrea Peruzzi – Ordinario di Meccanica e Meccanizzazione Agricola Università degli Studi di Pisa - presso l’Istituto Tecnico Statale G. Caruso” di Alcamo grazie all’iniziativa del Rotary Club di Alcamo e dei colleghi Andrea Ferrarella e Piero Catania. GIROLAMO CARUSO: Nasce ad Alcamo il 18 settembre 1842, studiò a Palermo e si laureò a Napoli nel 1861. Fu per breve periodo volontario nel genio militare e nel 1864 venne nominato professore di Agraria e direttore della Scuola di agricoltura di Corleone, donde nel 1867 passò all’Istituto tecnico di Messina come insegnante di Economia rurale ed Estimo. Nel 1871, in seguito a concorso, successe a Pietro Cuppari nell’insegnamento dell’Agronomia, agricoltura ed economia rurale della R. -

Bilancio Sociale E Di Missione
BILANCIO SOCIALE E DI MISSIONE DUEMILADICIOTTO BILANCIO SOCIALE E DI MISSIONE DUEMILADICIOTTO INDICE 7 LA 16ˆ EDIZIONE DEL BILANCIO SOCIALE E DI MISSIONE 8 L’IDENTITÀ AZIENDALE 9 LA STORIA DELLA BANCA 10 LA STORIA DEL CREDITO COOPERATIVO 11 LE PRINCIPALI TAPPE ATTRAVERSO LE PERSONE 12 IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO 13 L’ASSETTO ISTITUZIONALE 14 LA RELAZIONE CON I PORTATORI DI INTERESSE 16 I SOCI - LA COMPAGINE SOCIALE 18 IL PREMIO DI STUDIO “BANCA DON RIZZO” 19 IL PREMIO AI NUOVI NATI “BABY EXPRESS” 20 IL CONCORSO FOTOGRAFICO: “DALLE NOSTRE PARTI. GLI SPLENDORI DEI MONUMENTI, DEL PAESAGGIO, DEL MARE, DELLE CAMPAGNE” 21 I COLLABORATORI 22 I CLIENTI 24 I FORNITORI 25 LA COMUNITÀ LOCALE 26 SPONSORIZZAZIONI CULTURALI 27 IL CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI LOCALI 27 ALCAMO, GLI ALUNNI DELL’I. T. “GIROLAMO CARUSO” OSPITI DI BANCA DON RIZZO ALL’ICCREA 28 CORSO DI AGGIORNAMENTO ANACI PALERMO E TRAPANI 29 SOSTEGNO ALLE IMPRESE. CATANIA: CONVEGNO CNA ECOBONUS E SISMABONUS WORKSHOP “FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE” A PARTANNA 30 “RESTO AL SUD. NUOVE OPPORTUNITÀ PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE” 31 ASSEMBLEA STRAORDINARIA: BANCA DON RIZZO ADERISCE AL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA 31 INTOUR - INNOVATIVE TOURISM. IL NUOVO PROGETTO DEL GRUPPO BANCARIO ICCREA DEDICATO AGLI IMPRENDITORI DEL TURISMO 32 IL CENTRO STUDI DON RIZZO 33 LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2018 36 IL SISTEMA A “RETE” DEL CREDITO COOPERATIVO 38 LA RIFORMA DEL CREDITO COOPERATIVO ED IL GRUPPO BANCARIO ICCREA 40 LA CARTA DEI VALORI DEL CREDITO COOPERATIVO 42 LA CARTA DELLA FINANZA, LIBERA, FORTE -

Contemporary Agriculture Vol
Contemporary Agriculture Vol. 67, No. 1, Pp. 1 - 8, 2018. The Serbian Journal of Agricultural Sciences ISSN (Online) 2466-4774 UDC: 63(497.1)(051)-“540.2” www.contagri.info Review paper UDC: 582.542.11 DOI: 10.2478/contagri-2018-0001 AGROBIODIVERSITY GENETIC VARIABILITY UTILIZATION IN ORGANIC FOOD PRODUCTION* Miodrag DIMITRIJEVIĆ1♦, Sofija PETROVIĆ, Borislav BANJAC, Goran BARAĆ, Velimir MLADENOV1 Summary The food production at the global level is about to meet its border. Industrialization of agriculture correlates with an explosive enlargement of human population, during XX and at the beginning of XXI centuries. An ongoing process of environmental erosion has been speeding up during that period, not only in our physical surrounding, but also in biodiversity. A new direction in agricultural food production is in demand. Organic food production has been recognized as the way of providing safety and quality food, preserving the environment in the same time. In the other hand new land areas have to be explored for agricultural use, in order to enhance food quantity to meeting the increasing demand for food. These targets set new requirements in plant breeding. To fulfill these requirements the genetic variability harbored in genetic resources has to be preserved, examined and put to good use. Key words: biodiversity, organic, agriculture, genetics, breeding, agriculture INTRODUCTION The human population is growing in a burst. The World entered 20th Century with about 1.5 billion inhabitants, and left it enriched by more than 6 billion. In just 100 years the increment was three time bigger than in all previous human history. At the moment there is more than 7 billion of us, as UN reported, summarized by Roser and Ortiz- Ospina (2017). -
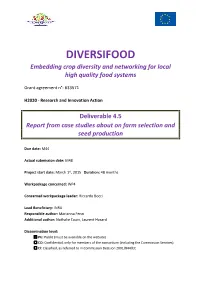
Report from Case Studies About on Farm Selection and Seed Production
DIVERSIFOOD Embedding crop diversity and networking for local high quality food systems Grant agreement n°: 633571 H2020 - Research and Innovation Action Deliverable 4.5 Report from case studies about on farm selection and seed production Due date: M44 Actual submission date: M48 Project start date: March 1st, 2015 Duration: 48 months Workpackage concerned: WP4 Concerned workpackage leader: Riccardo Bocci Lead Beneficiary: INRA Responsible author: Marianna Fenzi Additional author: Nathalie Couix, Laurent Hazard Dissemination level: PU: Public (must be available on the website) CO: Confidential, only for members of the consortium (including the Commission Services) Cl: Classified, as referred to in Commission Decision 2001/844/EC Collective Management of Maize Landraces in France and Italy Abstract In industrialized countries, maize culture is associated with the use of hybrid varieties and industrialized agriculture. Despite the homogeneity of maize landscapes, alternative models of maize production exist. This comparative study is based on farmers collectives from Aquitaine (France) and Veneto (Italy) that manage maize landraces. Since the early 2000s, the Aquitaine group adopted maize landraces from different regions of the world while Veneto groups recovered the "historical" and local maize landraces. In Italy, maize landraces are mainly used for human consumption while in France animal feed represents their principal usage. Each group has developed different strategies to define, distinguish and legitimatize their work on maize landraces within a broader context dominated by commercial hybrids. The Aquitaine and Veneto groups display very different organizational functions, practices, and visions. This diversity reflects different productive systems and priorities. The Aquitaine group focuses on the development of maize diversity and related knowledges. -

Building the Casaccia Gamma Field. Nuclear Energy, Cold War and the Transnational Circulation of Scientific Knowledge in Italy (1955-1960)
Building the Casaccia gamma field. Nuclear energy, Cold War and the transnational circulation of scientific knowledge in Italy (1955-1960) Francesco Cassata* The article will focus on the mutagenesis programme in agriculture implemented by the Italian Atomic Energy Commission, starting from 1955, through the establishment of a specific technological and experimental system: the so-called “gamma field”, a piece of agricultural land with a radioisotope of Cobalt-60 at the centre. The Cobalt-60 would emit constant radiation, which would bombard the specimens planted in concentric circles around the source, inducing genetic mutations. The Italian gamma field went into operation in January 1960 at the Casaccia Laboratory, about twenty miles north of Rome, with a radia- tion device made available by the US Government for the Atoms for Peace programme This article will analyse, first of all, how the American experimental model of mutation breeding was translated into the Italian context, becoming instrumental for the establishment of plant genetics within the local academic system; secondly, it will describe how the sociotechnical imaginary embodied by the gamma field was part and parcel of this process of discipline- building and scientific demarcation. Key words: Cold War, Atoms for Peace, Nuclear energy, Agriculture, Plant breeding, Genetics It was a round-shaped field, covering a surface of some six thousand square metres: at the centre, in a hole made of concrete walls, the radiation unit that the United States had donated in 1958 as part of the Atoms for Peace programme. The unit was composed of a lead cylinder that weighed about a ton, which contained a radioactive source: two Cobalt-60 rings, approximately twenty centi- metres long. -

The Italian Emigration of Modern Times
The University of Southern Mississippi The Aquila Digital Community Dissertations Spring 5-2010 The Italian Emigration of Modern Times: Relations Between Italy and the United States Concerning Emigration Policy, Diplomacy, and Anti-Immigrant Sentiment, 1870-1927 Patrizia Fama Stahle University of Southern Mississippi Follow this and additional works at: https://aquila.usm.edu/dissertations Part of the Cultural History Commons, European History Commons, Political History Commons, Social History Commons, and the United States History Commons Recommended Citation Stahle, Patrizia Fama, "The Italian Emigration of Modern Times: Relations Between Italy and the United States Concerning Emigration Policy, Diplomacy, and Anti-Immigrant Sentiment, 1870-1927" (2010). Dissertations. 934. https://aquila.usm.edu/dissertations/934 This Dissertation is brought to you for free and open access by The Aquila Digital Community. It has been accepted for inclusion in Dissertations by an authorized administrator of The Aquila Digital Community. For more information, please contact [email protected]. The University of Southern Mississippi THE ITALIAN EMIGRATION OF MODERN TIMES: RELATIONS BETWEENITALY AND THE UNITED STATES CONCERNING EMIGRATION POLICY,DIPLOMACY, AND ANTI-IMMIGRANT SENTIMENT, 1870-1927 by Patrizia Famá Stahle Abstract of a Dissertation Submitted to the Graduate School of The University of Southern Mississippi in Partial Fulfillment of the Requirements of the Degree of Doctor of Philosophy May 2010 ABSTRACT THE ITALIAN EMIGRATION OF MODERN TIMES: RELATIONS BETWEEN ITALY AND THE UNITED STATES CONCERNING EMIGRATION POLICY, DIPLOMACY, AND ANTI-IMMIGRANT SENTIMENT, 1870-1927 by Patrizia Famà Stahle May 2010 In the late 1800s, the United States was the great destination of Italian emigrants. In North America, employers considered Italians industrious individuals, but held them in low esteem. -

Girolamo Caruso”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Girolamo Caruso” Settore Economico - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING Settore Tecnologico - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA Settore Economico - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI Settore Tecnologico - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Settore Economico - RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING Settore Tecnologico - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO Via J. F. Kennedy N. 2 - 91011 ALCAMO (TP) - C.F.: 80003680818 - C.M.: TPTD02000X - C.U.: UFCB1B Tel. 0924/507600-507605 – www.gcaruso.edu.it – e-mail: [email protected] – P.E.C.: [email protected] Ai Dirigenti Scolastici Ambito 27 Provincia di Trapani Alla Dottoressa Figuccia Maria Lisa Oggetto: formazione docenti in servizio a. s. 2019-2020 - Ambito 27 Trapani – Calendario iniziative formative anno scolastico 2019/2020. Si comunica che a decorrere dal 4 maggio 2020, il polo formativo ambito 27 dà avvio ai corsi di formazione per i quali sono state confermate le iscrizioni come richiesto nella nostra precedente comunicazione. Si precisa che dato l’elevato numero di edizioni il loro svolgimento si svilupperà da maggio a settembre 2020. Le iscrizioni sono state tutte accolte e verranno avviate 20 edizioni. I corsisti sono stati suddivisi per ordine di scuole e nel rispetto della cronologia della conferma pervenuta. Di seguito si specificano i laboratori e il numero di edizioni organizzate con la data di inizio della EDIZIONE 1. LABORATORIO NUMERO DATA INIZIO EDIZIONI 3.1.2020 corso per animatore digitale 3 edizioni 4 maggio 2020 3.1.2020-G-suite-web-apps e risorse didattiche n 9 edizioni 4 maggio 2020 5.1.2020-Il Pei in chiave ICF 5 edizioni 4 maggio 2020 5.2.2020 LIS_ prima annualità n. -
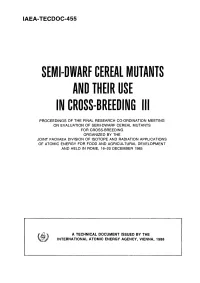
Semi-Dwarf Cereal Mutants and Their Use in Cross-Dreeding Iii
IAEA-TECDOC-455 SEMI-DWARF CEREAL MUTANTS AND THEIR USE IN CROSS-DREEDING III PROCEEDINGS OF THE FINAL RESEARCH CO-ORDINATION MEETING ON EVALUATION OF SEMI-DWARF CEREAL MUTANTS FOR CROSS-BREEDING ORGANIZEE TH Y DB JOINT FAO/IAEA DIVISION OF ISOTOPE AND RADIATION APPLICATIONS ATOMIF O C ENERG FOOR AGRICULTURAD YFO D AN L DEVELOPMENT AND HELD IN ROME, 16-20 DECEMBER 1985 A TECHNICAL DOCUMENT ISSUED BY THE INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, VIENNA, 1988 SEMI-DWARF CEREAL MUTANTS AND THEIR USE IN CROSS-BREEDING IAEA, VIENNA, 1988 IAEA-TECDOC-455 Printe IAEe th Austrin Ai y d b a March 1988 PLEASE BE AWARE THAT MISSINE TH AL F LO G PAGE THIN SI S DOCUMENT WERE ORIGINALLY BLANK The IAEA does not normally maintain stocks of reports in this series. However, microfiche copie f thesso e reportobtainee b n sca d from IN IS Clearinghouse International Atomic Energy Agency Wagramerstrasse5 P.O. Box 100 A-1400 Vienna, Austria Orders should be accompanied by prepayment of Austrian Schillings 100,- in the form of a cheque or in the form of IAEA microfiche service coupons which may be ordered separately from the INIS Clearinghouse. FOREWORD A Co-ordinated Research Programme on the "Evaluation of semi-dwarf mutants as cross-breeding material in cereals" was initiated in 1980, with the main objective to provide cereal breeders with new, alternative sources of genes for semi-dwarf, lodging resistant plant types. In the early 50's it became obvious that lodging, cause y longb d , weak stra d leadinan w o t g w responslo a o nitroget e n fertiHzation e maith n s reasowa , n which limited the yield potential of cereals, particularly in good agro-ecological conditions. -

Onoranze Al Prof. Girolamo Caruso Il Giorno 12 Novembre 1925, Come
Onoranze al prof. Girolamo Caruso Il giorno 12 novembre 1925, come coronamento all’iniziativa di un gruppo di laureati della Scuola superiore agraria di Pisa, venne scoperto nell’aula di Agronomia un busto del compianto prof. Girolamo Caruso. In tale circostanza i dottori in scienze agrarie d’Italia si riunirono a congresso e venne stabilito che lo scoprimento del busto del prof. Caruso e l’inaugurazione del congresso venissero riuniti in un’unica cerimonia. Ad essa aderirono, scusando l’assenza perché trattenuti a Roma per motivi di governo, S. E. Belluzzo, ministro dell’Economia nazionale; S. E. Fedele, ministro della Pubblica istruzione; S. E. Peglion, sottosegretario all’Agricoltura; gli alti funzionari del Ministero dell’Economia nazionale, grand’uff. Brizi, comm. Stringher, ecc. Intervennero le autorità locali, numerosi rappresentanti di istituti superiori e medi d’Italia, di sindacati, di ordini; il corpo accademico dell’Università e degli istituti superiori di Pisa; un largo stuolo di congressisti, di amici, di ammiratori, di discepoli del venerato maestro. Allo scoprimento del busto il prof. Ravenna, direttore del R. Istituto superiore agrario, spiegò il significato della cerimonia e dopo una felice improvvisazione del Prefetto di Pisa grand’uff. Cotta, presero la parola il prof. Todaro, presidente del Comitato ordinatore delle onoranze; il prof. D’Achiardi rettore della R. Università, il dott. Calzavara, per i discepoli e a nome dell’Associazione dottori in scienze agrarie delle Tre Venezie; il dott. Ferrucci, come presidente del Comitato ordinatore del congresso e del sindacato pisano dei dottori in scienze agrarie. Infine il senatore prof. Passerini lesse il discorso commemorativo. -

Historic Role of the Wheat Variety Akakomugi in Southern and Central European Wheat Breeding Programs
Breeding Science 55 : 253–256 (2005) Review Historic Role of the Wheat Variety Akakomugi in Southern and Central European Wheat Breeding Programs Katarina Borojevic1) and Ksenija Borojevic*2) 1) Faculty of Natural Science, University of Novi Sad, Novi Sad 21000, Serbia & Monte Negro (Former Yugoslavia) 2) Department of Archaeology, Boston University, Boston, MA 02215, USA The old semidwarf, not very attractive, Japanese wheat variety Akakomugi was the source of the dwarfing gene Rht8 and photoperiodic insensitive gene PpD1 to many semidwarf wheat varieties in South and Central Europe in the 20th century. Integrating the Rht8 and PpD1 genes in wheat varieties offered the best oppor- tunities for reducing plant height, accelerating time of flowering, improving grain fill before the onset of dry summer conditions, enhancing spikelet fertility, and consequently increasing yields. Many breeders from South and Central Europe and from the former Soviet Union were creating winter short high yielding wheat varieties without knowing at the time that Akakomugi was the donor of such important genes. At the end of the 20th century, it was discovered that dwarfing gene Rht8 and photoperiodic insensitive gene PpD1 are lo- cated on the short arm of chromosome 2D in wheat. Microsatellite analyses proved that Akakomugi is the source for the Rht8 and PpD1 genes in many short wheat varieties in South and Central Europe. Key Words: Wheat, Akakomugi, Rht8, PpD1, wheat history. Introduction Centenario of Nazareno Strampelli 2000, most of the scien- tists present supposed that the seeds of Akakomugi were In the beginning of the 20th century, the Italian breeder brought by a visitor to Strampelli at the beginning of the 20th Nazareno Strampelli was in charge of wheat breeding in century (according to the personal communication of the Rieti when the project “Bataglia del Grano” (Wheat Battle) senior author). -

I Georgofili E Le Innovazioni in Agricoltura Dalla Nascita Dell’Accademia Ad Arrigo Serpieri
ACCADEMIA DEI GEORGOFILI I Georgofili e le innovazioni in agricoltura dalla nascita dell’Accademia ad Arrigo Serpieri Saggio storico di Lucia Bigliazzi – Luciana Bigliazzi Firenze, aprile 2016 1 La pubblicazione è stata realizzata in occasione della Mostra I Georgofili e le innovazioni in agricoltura. Dalla nascita dell’Accademia a Arrigo Serpieri, 5-26 aprile 2016 2 Introduzione L’agricoltura, “Madre di tutte l’Arti, e lor Natura” Affrontare il tema delle “innovazioni in agricoltura” legate al mondo dei Georgofili, significa trattare dei Georgofili stessi, della vita stessa dell’Accademia, della linfa vitale che da oltre 250 anni permea l’essenza stessa dell’istituzione e la sua attività. Il motto assunto a rappresentare la prima Accademia di agricoltura del mondo, “Prosperitati Publicae Augendae” bene evidenzia la volontà dei Georgofili di lavorare per la prosperità pubblica, per mantenerla, migliorarla, incrementarla, non tralasciando alcun campo d’azione. Esemplificativo in merito è da considerarsi l’assetto organizzativo che l’Accademia si dette pochi anni dopo la nascita e così dal Ragguaglio dell’istituzione, reggimento e progressi della Accademia dei Georgofili, del 1756, si evince che l’attività accademica era suddivisa in 8 classi di cui oggetto della prima erano il clima della Toscana, le proprietà dei terreni e la loro esposizione, la coltura dei grani e delle biade, biade; la seconda classe si occupava delle viti, della vendemmia, della fattura e conservazione dei vini; oggetto della terza classe, gli alberi da frutta e non; -

Nazareno Strampelli, the 'Prophet' of the Green Revolution
Journal of Agricultural Science (2013), 151,1–5. © Cambridge University Press 2012 doi:10.1017/S0021859612000214 EDITORIAL Nazareno Strampelli, the ‘Prophet’ of the green revolution 1 2 3 S. SALVI *, O. PORFIRI AND S. CECCARELLI 1 National Research Institute on Food and Nutrition (INRAN), Rome, Italy 2 Agronomist Consultant, Via Valleresco 24, 62010 Urbisaglia, Italy 3 Consultant, 40 Impasse Suzanne Bernard, 34070 Montpellier, France (Received 18 October 2011; revised 9 December 2011; accepted 24 February 2012; first published online 21 March 2012) SUMMARY 23 January 2012 marked 70 years since the death of the Italian plant breeder Nazareno Strampelli (1866–1942), one of the most important plant geneticists of the 20th century. During the first 30 years of what is known as the ‘short century’, Strampelli was among the first, in Europe and in the world, to systematically apply Mendel’s laws to plant breeding, particularly to wheat breeding which resulted in varieties characterized by rust resistance, early flowering and maturity and short straw. Due to Strampelli’s varieties Italian wheat production doubled, an achievement that during the fascist regime was referred to as the ‘Wheat Battle’. Some of Strampelli’s wheats, such as Mentana, Ardito and San Pastore, were used as parents in the breeding programmes of several countries after the Second World War; they also had a key role in the first phase of Norman Borlaug’s Green Revolution, being instrumental in the development of the high-yielding varieties of the future Nobel Peace Laureate. A century after the key cross in which Strampelli, 30 years before Borlaug, used the genes for short straw and earliness in wheat breeding, his name and his work are not known and appreciated as they deserve, despite the recent evidence that the resistance to the new rust races could derive from the very same resistance genes identified by the Italian breeder at the beginning of the 20th century.