Comune Di Santa Cristina E Bissone
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
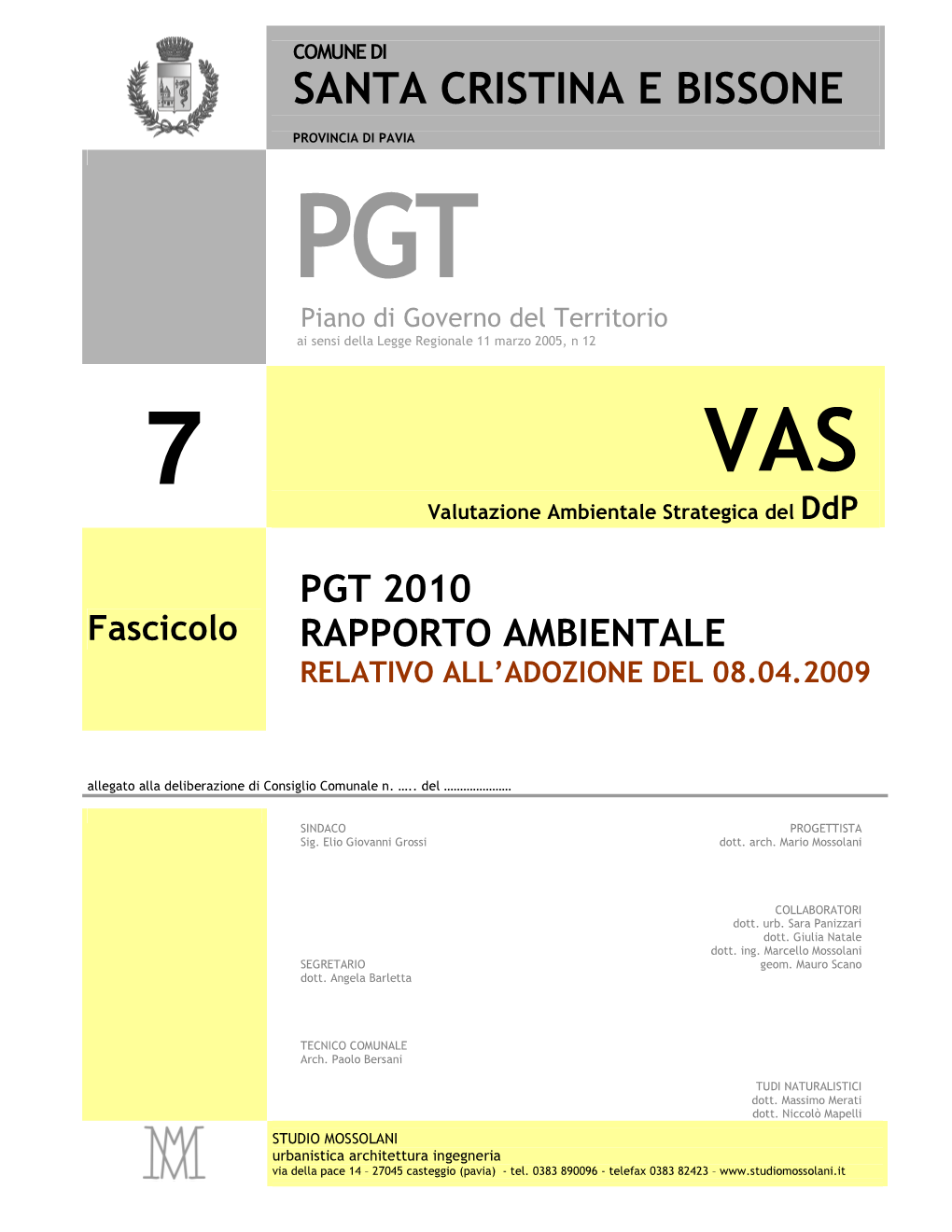
Load more
Recommended publications
-
Estratto Le Terre Dei Re
UN FANTASTICO ITINERARIO STORICO E ARCHITETTONICO TRA MEDIOEVO Itineraries E RINASCIMENTO A great historical and architectural tour trough the Middle Ages and Reinassance Le Terre dei Re DAI LONGOBARDI AI VISCONTI The Lands of Kings FROM THE LONGOBARDS TO THE VISCONTI LA PROVINCIA DI PAVIA, THE PROVINCE OF PAVIA, con la forza della qualità e della bellezza, ha selezionato Confident of the beauty of the territory and what it has con gli operatori del territorio 4 itinerari che favoriscono to offer visitors, the provincial authorities have joined with la scoperta di luoghi di grande attrattiva. various organisations operating in the area to draw up four itineraries that will allow travellers to discover intriguing Sono 4 itinerari che suggeriscono approcci diversi new destinations. e che valorizzano le diverse vocazioni di un territorio poco conosciuto e proprio per questo contraddistinto Four different itineraries that present the varied vocations da una freschezza tutta da scoprire. of a little-known territory just waiting to be discovered. Un turismo intelligente fruibile tutti i giorni dell’anno, Intelligent tourism accessible all year-round in the heart vissuto nel cuore del territorio lombardo, fra pianura, of Lombardy - ranging from the plains to the hills and the colline e Appennino, ideale per scoprire la storia, Appenine Mountains, a voyage into the history, the culture la cultura e la natura a pochi passi da casa. and the natural beauty that lies just around the corner. • VIGEVANO • MEDE • PAVIA • MIRADOLO TERME • MORTARA • LOMELLO -

Robbio (Pv) Via Siberia 11/2 – 27026 – Garlasco (Pv) Tel: 0382-311341 Cellulare: 349-4648190 P.I
VIA MORTARA 51 - 27038 - ROBBIO (PV) VIA SIBERIA 11/2 – 27026 – GARLASCO (PV) TEL: 0382-311341 CELLULARE: 349-4648190 P.I. 02259470181 C.F. PRASFN81S45L750S e-mail: [email protected] pec: [email protected] www.pareistefania.architetto.it INFORMAZIONI PERSONALI Nome: Stefania Cognome: Parei Data di nascita: 5 Novembre 1981 Residenza: Via Mortara n.°51, 27038, Robbio (PV) Domicilio: Via Siberia n.°11/2, 27026, Garlasco (PV) Nazionalità: Italiana Telefono: +39 0382 311341 Cellulare: +39 349 46 48 190 Partita Iva 02259470181 e-mail: [email protected] PEC: [email protected] www.pareistefania.architetto.it Iscrizione Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pavia al numero 1008A dal 22.05.2008 Pag. - 1 - di 8 ISTRUZIONE 2007 Laurea Specialistica nella Classe ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE (4/S) Corso di Laurea Specialistica ARCHITETTURA Facoltà di Architettura II - Politecnico di Torino Voto: 110/110 e lode con pubblicazione su Internet - Titolo: “Il ruolo dei grattacieli nella città sostenibile” Relatore: Prof. Ing. Giuseppe Ferro Indirizzo internet: http://www.architesi.polito.it/pdf/3837_it_abs.pdf Classe delle lauree specialistiche in ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE (4/S) 2007 Frequentazione del Master "Graduate Architecture Studio" presso la University of Texas at San Antonio (U.T.S.A.) allo scopo di ampliare la ricerca sulla tesi di Laurea Specialistica 2005 LAUREA IN ARCHITETTURA PER IL PROGETTO Facoltà di Architettura II - Politecnico di Torino Voto: -

Guida Pratica Alla Raccolta Differenziata
GUIDA PRATICA ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI E ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA Comuni Convenzionati della Bassa Pavese Chignolo Po - Copiano - Corteolona - Filighera - Genzone - Gerenzago LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: RACCOLTA VETRO, LATTINE ISOLE ECOLOGICHE COMUNALI RACCOLTA televisori, monitor pc, Inverno e Monteleone - Santa Cristina e Bissone - Torre dei Negri UNA BUONA ABITUDINE IN ALLUMINIO E RACCOLTA VERDE: (sfalcio dei prati, foglie frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie; QUOTIDIANA CONTENITORI A BANDA secche, potature degli alberi, fi ori appassiti, scarti congelatori, cucine a gas, lampade dell’orto ecc.); STAGNATA PER al neon, batterie per auto esauste, Ci sono tanti materiali riciclabili che si possono recu- RACCOLTA LEGNO Broni Stradella S.p.A. perare a condizione che vengano separati dagli altri ALIMENTI RACCOLTA MATERIALE INGOMBRANTE RACCOLTA RlFIUTI MARCATI T/F rifi uti. (materassi, vecchi mobili, ecc.); Servizi Ambientali La Raccolta Differenziata inizia così, direttamente (scatole tonno, (infi ammabili/bombolette). in casa nostra. RACCOLTA VETRO DI GROSSE DIMEN- pelati, ecc.) SIONI (lastre, damigiane, ecc.): Sono molti i vantaggi della raccolta RACCOLTA MATERIALE FERROSO. Come avviene. Chi non divide i rifi uti Per prenotare il ritiro a domicilio gratuito, telefonare differenziata: Come avviene. al numero 0385 246470 (specifi cando il comune di Con apposite campane di - si riduce sensibilmente il volume dei rifi uti da Come avviene. residenza) oppure telefonare al proprio comune li moltiplica colore verde dislocate sul smaltire in discarica; Il materiale dovrà essere conferito direttamente dai indicando il nominativo e la tipologia di rifi uto da territorio del tuo paese. cittadini nelle apposite isole ecologiche comunali, - si eliminano le parti tossiche dei rifi uti, con ritirare. nelle quali sono situati i vari contenitori. -

Comune Di Santa Cristina E Bissone RER E RETE ECOLOGICA COMUNALE
COMUNE DI SANTA CRISTINA E BISSONE PROVINCIA DI PAVIA PGT Piano di Governo del Territorio ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n 12 DdP 5 Documento di Piano LA RETE ECOLOGICA REGIONALE E Fascicolo LA RETE ECOLOGICA COMUNALE allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. del SINDACO PROGETTISTA Sig. Elio Giovanni Grossi dott. arch. Mario Mossolani COLLABORATORI dott. urb. Sara Panizzari SEGRETARIO dott. Giulia Natale Dott. Angela Barletta dott. ing. Marcello Mossolani geom. Mauro Scano TECNICO COMUNALE STUDI NATURALISTICI Arch. Paolo Bersani dott. Massimo Merati dott. Niccolò Mapelli STUDIO MOSSOLANI urbanistica architettura ingegneria via della pace 14 – 27045 casteggio (pavia) - tel. 0383 890096 - telefax 0383 82423 – www.studiomossolani.it PGT del Comune di Santa Cristina e Bissone RER E RETE ECOLOGICA COMUNALE COMUNE DI SANTA CRISTINA E BISSONE Provincia di Pavia PGT Piano di Governo del Territorio DOCUMENTO DI PIANO RETE ECOLOGICA REGIONALE E RETE ECOLOGICA COMUNALE INDICE 1. RETE ECOLOGICA REGIONALE E PROGRAMMAZIONE ENTI LOCALI .................................................................................................5 1.1. LA RETE ECOLOGICA: IL DOCUMENTO REGIONALE 5 1.1.1. LA RETE ECOLOGICA ED IL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE .................. 6 1.1.2. LA RETE ECOLOGICA REGIONALE ........................................................... 8 1.1.2.1. GLI OBIETTIVI DELLA RER DI SCALA REGIONALE ....................................................... 9 1.1.2.2. CONDIZIONAMENTI ED OPPORTUNITÀ NELLA RER PRIMARIA ..................................... 9 1.1.2.3. RETI ECOLOGICHE E SISTEMA COMPLESSIVO DI RIFERIMENTO ................................ 10 1.1.2.3.1. RETI ECOLOGICHE E PAESAGGIO: LA RETE VERDE REGIONALE ..................... 10 1.1.2.3.2. RER E SISTEMA COMPLESSIVO RURALE-PAESISTICO-AMBIENTALE DEL PTR .... 11 1.1.2.3.3. RER E SISTEMA RURALE .......................................................................................... -

Comune Di Chignolo Po Provincia Di Pavia
COMUNE DI CHIGNOLO PO PROVINCIA DI PAVIA PGT Piano di Governo del Territorio ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n 12 DdP 8 Documento di Piano RELAZIONE ILLUSTRATIVA Fascicolo DEL DOCUMENTO DI PIANO - APPROVAZIONE allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. del SINDACO PROGETTISTA Ing. Antonio Bonati dott. arch. Mario Mossolani SEGRETARIO COLLABORATORI Dott.ssa Margherita Veronesi dott. urb. Sara Panizzari dott. ing. Giulia Natale dott. ing. Marcello Mossolani geom. Mauro Scano UFFICIO TECNICO Geom. Norberto Caffi STUDI NATURALISTICI Geom. Emilio Maria Erici dott. Massimo Merati Arch. Angelo Gualandi dott. Niccolò Mapelli STUDIO MOSSOLANI urbanistica architettura ingegneria via della pace 14 – 27045 casteggio (pavia) - tel. 0383 890096 - telefax 0383 82423 – www.studiomossolani.it Chignolo Po DdP – Relazione illustrativa COMUNE DI CHIGNOLO PO Provincia di Pavia PGT Piano di Governo del Territorio DOCUMENTO DI PIANO Relazione illustrativa APPROVAZIONE INDICE PARTE I RIFERIMENTI NORMATIVI, PROCEDURE E CONTENUTI ......... 5 1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO ........................................................... 6 1.1. PGT DI CHIGNOLO PO ............................................................................ 6 1.2. NUOVA LEGGE URBANISTICA REGIONALE ............................................... 6 1.2.1. DOCUMENTO DI PIANO ............................................................................................. 6 1.2.2. PIANO DEI SERVIZI .................................................................................................. -

PRINCIPALI TIPOLOGIE IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI - Anno 2016
PRINCIPALI TIPOLOGIE IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI - Anno 2016 Cassolnovo Gravellona Lomellina Confienza Siziano Cilavegna Vigevano Casorate Primo Landriano Bascape' Robbio XW Palestro Rognano Alb$+onese Vidigulfo Nicorvo Trovo Parona " A@ ) Giussago Torrevecchia Pia BattudaVellezzo Bellini Bornasco Castelnovetto Trivolzio Zeccone Gambolo' ! Ceranova Rosasco Bereguardo Ceretto Lomellina MarcignagoCertosa di Pavia Marzano Mortara Borgo San Siro Sant'angelo Lomellina ! Borgarello Lardirago San Genesio Ed Uniti Torre d'Arese Castello d'Agogna Roncaro Villanterio Torre d'Isola Sant'alessio Con Vialone Langosco Magherno Zerbolo' Cozzo Tromello Vistarino Olevano di Lomellina Cura Carpignano Garlasco Gerenzago Cergnago Pavia Copiano Inverno E Monteleone Zeme Albuzzano A@*# Filighera Candia Lomellina San Giorgio di Lomellina Gropello Cairoli Carbonara Al Ticino Miradolo Terme Valle Salimbene XW$+ Alagna Villanova d'Ardenghi Corteolon$+a e Genzone Velezzo Lomellina San Martino Siccomario Valle Lomellina Ottobiano Santa Cristina E Bissone Linarolo ! Valeggio Dorno )"* Travaco' Siccomario Chignolo Po BelgioiosoTorre De'Negri Semiana Costa De' Nobili Breme Scaldasole Zinasco Mezzanino Monticelli Pavese Cava Manara Badia Pavese Lomello Sommo Spessa Rea Albaredo Arnaboldi Verrua Po San Zenone Al Po Monticelli Pavese San Cipriano Po Zerbo Sartirana Lomellina Ferrera Erbognone Pieve Albignola Pieve Porto Morone Mezzana Rabattone Mede Sannazzaro De'Burgondi Bastida Pancarana Portalbera Galliavola Pancarana Casanova LonatiCampospinoso Villa Biscossi Silvano -

Attivazioni Per Lo Sviluppo Delle Competenze Di Vita Nella Scuola Primaria Regione Lombardia ATS Pavia
PROGETTO EDUCARE ALLA SALUTE - Attivazioni per lo sviluppo delle competenze di vita nella scuola primaria Regione Lombardia ATS Pavia Progetto avviato nell'anno 2017 - Ultimo anno di attività : 2019 Abstract Obiettivo generale Sviluppare e integrare le competenze degli insegnanti nell'ambito della promozione della salute per facilitare, attraverso l'apprendimento da parte dei bambini, di: comportamenti alimentari e motori salutari, riconoscimento e gestione delle emozioni, relazionali efficaci nei confronti dei pari e degli adulti, relazioni in sicurezza con gli animali. Analisi di contesto L'Organizzazione Mondiale della Sanità identifica le"Life Skills" (LS) come le linee guida per l'attivazione di interventi educativi rivolti ai bambini e agli adolescenti. Le LS sono utilizzate per promuovere e far apprendere le competenze necessarie per la salute ed il benessere, sia fisico che relazionale, ma anche per realizzare nel miglior modo possibile le potenzialità della persona, aiutandola a vivere in armonia con gli altri e con il suo contesto sociale e culturale. Questo programma, sviluppato per le scuole primarie, si prefigge, attraverso lo sviluppo delle LS di portare avanti i principi della Rete delle Scuole che Promuovono Salute (SPS) allo scopo di: rafforzare le capacità degli studenti di intraprendere azioni positive e sostenere scelte responsabili; promuovere clima e relazioni positive; avviare un cambiamento organizzativo; migliorare gli aspetti e le condizioni strutturali/ambientali; rafforzare la collaborazione comunitaria. La scuola è l' ambiente privilegiato in cui le abilità di vita possono essere sperimentate e interiorizzate, in quanto luogo di "educazione" per definizione. L'OMS nel PIANO DI AZIONE UE SULL' OBESITÀ' INFANTILE 2014-2020 -OMS 2014 descrive la scuola come "un ambiente essenziale da considerare per contrastare sovrappeso e obesità nei bambini e nei giovani. -

30.06.2021 Page 1 Powered by Gebietsausdehnung Das
26.09.2021 Karten, Analysen und Statistiken zur ansässigen Bevölkerung Bevölkerungsbilanz, Bevölkerungs- und Familienentwicklung, Altersklassen und Durchschnittsalter, Familienstand und Ausländer Skip Navigation Links ITALIA / Lombardia / Provinz von Pavia / Santa Cristina e Bissone Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHIE WIRTSCHAFT RANGLISTEN SUCHEN ITALIA Gemeinden Powered by Page 2 Nebeneinander anzeigen >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Alagna Fortunago Adminstat logo DEMOGRAPHIE WIRTSCHAFT RANGLISTEN SUCHEN Albaredo FrascaroloITALIA Arnaboldi Galliavola Albonese Gambarana Albuzzano Gambolò Arena Po Garlasco Badia Pavese Gerenzago Bagnaria Giussago Barbianello Godiasco Salice Bascapè Terme Bastida Golferenzo Pancarana Gravellona Battuda Lomellina Belgioioso Gropello Cairoli Bereguardo Inverno e Monteleone Borgarello Landriano Borgo Priolo Langosco Borgo San Siro Lardirago Borgoratto Mormorolo Linarolo Bornasco Lirio Bosnasco Lomello Brallo di Lungavilla Pregola Magherno Breme Marcignago Bressana Marzano Bottarone Mede Broni Menconico Calvignano Mezzana Bigli Campospinoso Mezzana Candia Rabattone Lomellina Mezzanino Canneto Pavese Miradolo Terme Carbonara al Montalto Ticino Pavese Casanova Montebello Lonati della Battaglia Powered by Page 3 Casatisma Montecalvo L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Versiggia Casei Gerola Adminstat logo Montescano DEMOGRAPHIE WIRTSCHAFT RANGLISTEN SUCHEN Casorate Primo ITALIA Montesegale Cassolnovo Monticelli Castana Pavese Casteggio -

Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale Di Pavia Stagione Sportiva 2014-2015
CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO PROVINCIALE DI PAVIA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015 INDIRIZZARIO OPEN A 7 girone “C” Squadra: INVERNO E MONTELEONE Associazione: A.S.D. INVERNO E MONTELEONE Recapito corrispondenza: FORNI MARCO - VIA MIRADOLO 31 - 27010 INVERNO E MONTELEONE (PV) - [email protected] Campo di gara: CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI INVERNO E MONTELEONE VIA VITTORIO VENETO INVERNO E MONTELEONE Dirigenti responsabili: BERTOLOTTI GIANFRANCO 333.7375123 NICHETTI STEFANO 335.5498327 FORNI MARCO 333.4600860 Squadra: ROMAGNESE CALCIO Associazione: ASD ROMAGNESE Recapito corrispondenza: ROCCHI SANDRO - FRAZIONE CASA ROCCHI - 27050 ROMAGNESE (PV) - [email protected] Campo di gara: CAMPO COMUNALE DI ROMAGNESE VIA CASTANA ROMAGNESE Dirigenti responsabili: ROCCHI SIMONE 366.3366544 ROCCHI SANDRO 338.3655360 Squadra: ASD ORATORIO SAN GIUSEPPE Associazione: ASD SANTA CRISTINA E BISSONE Recapito corrispondenza: VIALONI GIORGIO - VIA PILA VECCHIA 3 - 27010 SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) - [email protected] Campo di gara: CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA GRADI SANTA CRISTINA E BISSONE Dirigenti responsabili: ANDRONIO PAOLO 331.1294856 TORCHIO PAOLO 339.8817739 FARCI FABIO 340.6613633 Squadra: ZANARDI TEAM Associazione: ASD ZANARDI TEAM Recapito corrispondenza: ZANARDI PIERLUIGI - VIA XXV APRILE 250 - 27013 CHIGNOLO PO (PV) - [email protected] Campo di gara: CAMPO SPORTIVO COMUNALE “FERRARI” VIA MARCONI 1 CHIGNOLO PO Dirigenti responsabili: RISARI DAVIDE 345.9426276 CAVALLOTTI ALESSANDRO 349.1057604 ZANARDI PIERLUIGI 331.8051809 -

Formato Europeo
F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome Augusto Allegrini Indirizzo 2, via Cicco Simonetta, I-27100 Pavia Telefono +39 0382 571453 Fax +39 0382 571453 E-mail [email protected] – pec: [email protected] Nazionalità italiana Data di nascita 16 agosto 1959 ESPERIENZA LAVORATIVA • Date (da – a) Dicembre 2015 • Nome e indirizzo del datore di Cliente privato lavoro • Tipo di azienda o Settore Edilizia privata • Tipo di impiego ANALISI E VALORIZZAZIONE PPATRIMONIO IMMOBILIARE RESIDENZIALE/COMMERCIALE in Pavia - proprietà privata. PERIZIA. Verifica di consistenza, rilievi puntuali, destinazione d’uso e stima (0,650 mln €); analisi dello stato di conservazione delle strutture. • Principali mansioni e responsabilità Perito • Date (da – a) Settembre 2015 • Nome e indirizzo del datore di Cliente privato lavoro • Tipo di azienda o Settore Edilizia privata • Tipo di impiego ANALISI E VALORIZZAZIONE IMMOBILE RESIDENZIALE in Rivanazzano (PV) - proprietà privata. PERIZIA. Verifica di consistenza, rilievi puntuali, destinazione d’uso e stima (0,204 mln €); analisi dello stato di conservazione delle strutture • Principali mansioni e responsabilità Perito • Date (da – a) Aprile 2015 • Nome e indirizzo del datore di Cliente privato lavoro • Tipo di azienda o Settore Edilizia privata • Tipo di impiego COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO impianto idroelettrico situato in località Chiusa di Batterra. (importo 1,5 mln €). Comune di GARLASCO (PV). • Principali mansioni e responsabilità Collaudatore Pagina 1 - Curriculum vitae di Augusto ALLEGRINI • Date (da – a) Da Aprile a Maggio 2015 • Nome e indirizzo del datore di Comune di MOTTA VISCONTI lavoro • Tipo di azienda o Settore Settore LL.PP. • Tipo di impiego D.L e CONTABILITA’ LAVORI COMPLETAMENTO PL DE GASPERI PER INTERVENTO SOSTITUTIVO COMUNALE PER OO.UU. -

Enti Aderenti 2021
ENTI ADERENTI REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI PAVIA 1. ALAGNA 59. GODIASCO SALICE TERME 2. ALBAREDO ARNABOLDI 60. GRAVELLONA LOMELLINA 3. ALBONESE 61. GROPELLO CAIROLI 4. ALBUZZANO 62. INVERNO E MONTELEONE 5. ARENA PO 63. LANDRIANO 6. BAGNARIA 64. LINAROLO 7. BARBIANELLO 65. LOMELLO 8. BASCAPE' 66. LUNGAVILLA 9. BASTIDA PANCARANA 67. MAGHERNO 10. BATTUDA 68. MARCIGNAGO 11. BELGIOIOSO 69. MARZANO 12. BEREGUARDO 70. MEDE 13. BORGARELLO 71. MENCONICO 14. BORGO SAN SIRO 72. MEZZANA BIGLI 15. BORNASCO 73. MEZZANA RABATTONE 16. BOSNASCO 74. MEZZANINO 17. BRALLO DI PREGOLA 75. MIRADOLO TERME 18. BREME 76. MONTALTO PAVESE 19. BRESSANA BOTTARONE 77. MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 20. BRONI 78. MONTESCANO 21. CAMPOSPINOSO 79. MONTU' BECCARIA 22. CANDIA LOMELLINA 80. MORNICO LOSANA 23. CANNETO PAVESE 81. MORTARA 24. CARBONARA AL TICINO 82. OLEVANO DI LOMELLINA 25. CASANOVA LONATI 83. OTTOBIANO 26. CASATISMA 84. PALESTRO 27. CASEI GEROLA 85. PARONA 28. CASORATE PRIMO 86. PIEVE ALBIGNOLA 29. CASSOLNOVO 87. PIEVE DEL CAIRO 30. CASTANA 88. PIEVE PORTO MORONE 31. CASTEGGIO 89. PINAROLO PO 32. CASTELLETTO DI BRANDUZZO 90. PIZZALE 33. CASTELLO D'AGOGNA 91. PORTALBERA 34. CASTELNOVETTO 92. REA 35. CAVA MANARA 93. REDAVALLE 36. CERANOVA 94. RETORBIDO 37. CERGNAGO 95. RIVANAZZANO TERME 38. CERTOSA DI PAVIA 96. ROBBIO LOMELLINA 39. CHIGNOLO PO 97. ROBECCO PAVESE 40. CIGOGNOLA 98. RONCARO 41. CILAVEGNA 99. ROSASCO 42. CODEVILLA 100. ROVESCALA 43. COLLI VERDI 101. SAN CIPRIANO PO 44. CONFIENZA 102. SAN DAMIANO AL COLLE 45. COPIANO 103. SAN GENESIO ED UNITI 46. CORTEOLONA E GENZONE 104. SAN GIORGIO DI LOMELLINA 47. COSTA DE' NOBILI 105. SAN MARTINO SICCOMARIO 48. -

Comune Di LINAROLO Provincia Di Pavia
Comune di LINAROLO Provincia di Pavia Sindaco: Pietro Scudellari Assessore Lavori Pubblici, Edilizia, Commercio: geom. Fabio Signorelli Segratario comunale: dott. Alfredo Scrivano PIANO DI GOVERNOGOVERNO DEL TERRITTERRITORIO Orientamenti iniziali ed obiettivi generali per lala formazioneformazione deldel PGT Relazione Maggio 2010 Progettista incaricato della redazione del PGT: Arch. Marco Bosi Con la collaborazione dell’Arch. Sara Zorzolo Procedimento Valutazione Ambientale Strategica: Dott. Stefania Anghinelli COMUNE DI LINAROLO Provincia di Pavia PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – PV Orientamenti iniziali ed obiettivi generali per la formazione del PGT Indice ___ Pag. L’IDENTITÀ, L’AMBIENTE E LA VITA 1 CENNI STORICI 1 IL TERRITORIO, GLI INSEDIAMENTI E LE INFRASTRUTTURE 3 Il territorio 3 Lo sviluppo residenziale e produttivo 3 Gli stranieri residenti 4 La ricchezza individuale all’anno 2007 4 I servizi a rete 4 I servizi alla persona 4 Le attività produttive 5 I collegamenti 5 I Nuclei di Antica formazione 5 Gli edifici di valore storico/architettonico ed i Vincoli ambientali 5 LA POPOLAZIONE, LE ABITAZIONI, LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E L’AGRICOLTURA SECONDO L’ISTAT 6 LA POPOLAZIONE 6 LE ABITAZIONI 6 LE ATTIVITA' ECONOMICHE 6 L'AGRICOLTURA 7 VINCOLI PRESENTI SUL TERRITORI 8 a) Vincoli di Legge 8 b) Vincoli che si vogliono inserire nel P.G.T. 8 LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SOVRACOMUNALE 10 1. IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE 10 2. PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE- P.P.R. 11 3. PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO – P.A.I. - DEL BACINO DEL FIUME PO 13 4. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL TICINO 13 5. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL TICINO 13 6.