Senza Titolo-11
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
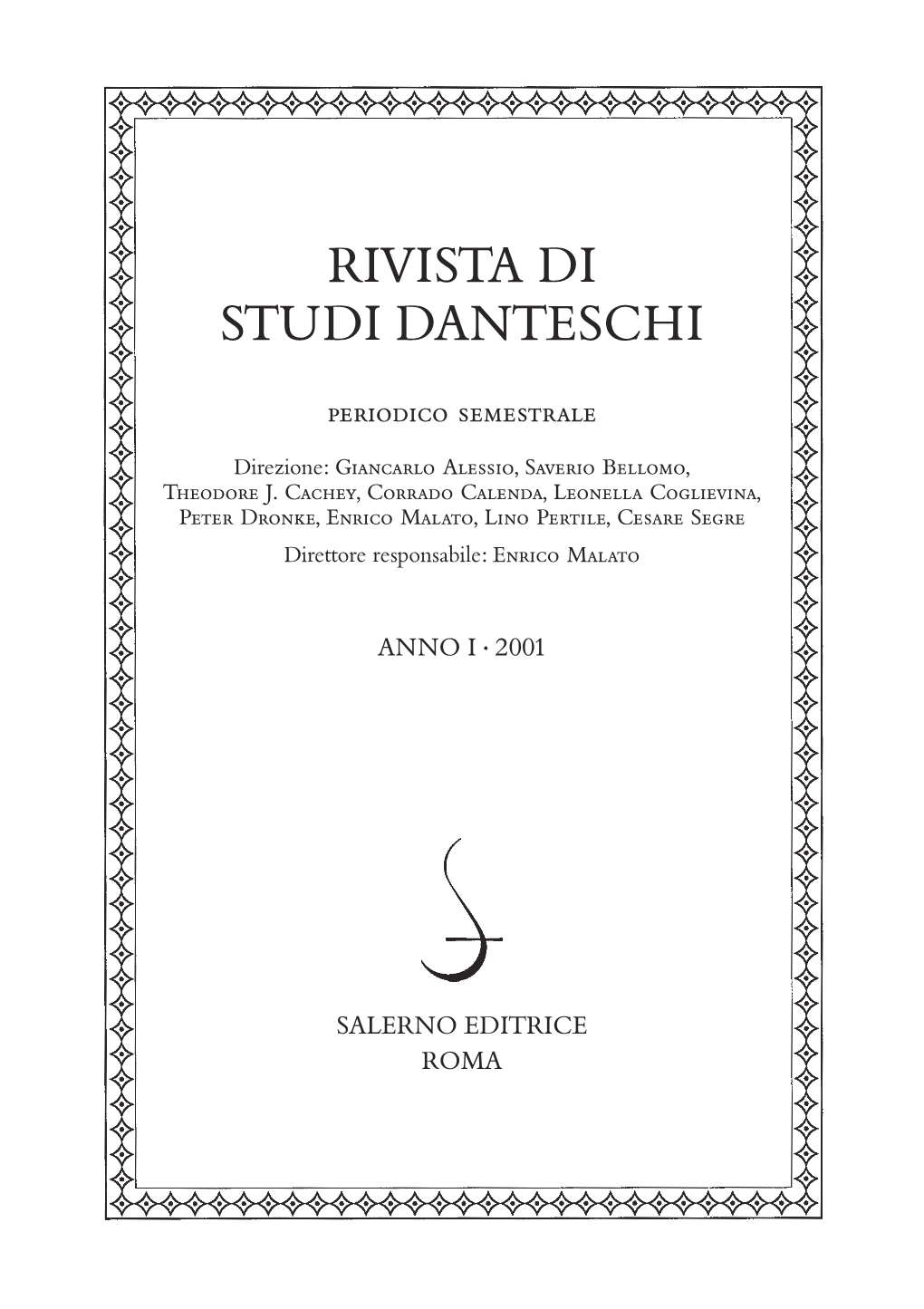
Load more
Recommended publications
-

«Legato Con Amore in Un Volume, Ciò Che Per L'universo Si Squaderna»
FLORILEGIO DI EDIZIONI DANTESCHE «legato con amore in un volume, ciò che per l’universo si squaderna» LIBRERIA PHILOBIBLON - LIBRERIA PREGLIASCO «legato con amore in un volume, ciò che per l’universo si squaderna» (Paradiso XXXIII, 86-87) Et per mia opinione questo commento e di un Jacopo Bolognese, che secondo il medesimo Landino scrisse nella patria lingua: per che ci sono molte parole Bolognesi, et si mostra molto informato delle cose di Bologna. V. B. (Postilla manoscritta di Vincenzo Buonanni apposta all’esemplare dell’edizione di Venezia, Vindelino da Spira, 1477; cfr scheda n. 1) Questo Florilegio dantesco, realizzato in collaborazione tra la Libreria Philobiblon e la Libreria Pregliasco, non è che una scelta dei libri di maggior pregio di una collezione dantesca di oltre mille opere, il cui catalogo completo vedrà senz’altro la luce prima del 690° anniversario della morte del Poeta. Comprenderà quasi tutte le edizioni critiche del Poema e delle opere cosiddette “minori”, nonché quattrocento volumi monografici ed opuscoli in varie lingue sui più variegati aspetti della figura di Dante. N.B. L’illustrazione in copertina si riferisce al n. 32, Suite acquerellata di Zatta. 1 Libreria PHILOBIBLON Libreria Antiquaria PREGLIASCO Piazza S. Simpliciano, 7 Via Accademia Albertina, 3 bis 20121 Milano 10123 Torino Tel. (+39) 02 89076643 Tel. (+39) 011.8177114 - Telefax (+39) Fax (+39) 02 89076644 011.8179214 Palazzo Massimo - Piazza dei Massimi, 3 e-mail: [email protected] 00186 Roma www.preliber.com Tel. (+39) 06 45555970 Fax (+39) 06 45555991 e-mail: [email protected] www.philobiblon.org redazione e responsabilità - Arturo e Umberto Pregliasco - Filippo Rotundo grafica - Francesco Pregliasco stampa - GRAFART CONDIZIONI DI VENDITA I libri sono garantiti completi e in buono stato, salvo indicazione contraria. -

Mental Models in Galileo's Early Mathematization of Nature
Stud. Hist. Phil. Sci. 34 (2003) 229–264 www.elsevier.com/locate/shpsa Mental models in Galileo’s early mathematization of nature Paolo Palmieri UCL London, Department of Science and Technology Studies, Gower Street, London WC1E 6BT, UK Received 21 June 2001; received in revised form 7 May 2002 1. Introduction: the question of Galileo’s early mathematization of nature Distinguishing between the mathematical followers of Archimedes, notably Gali- leo, and the Aristotelians of the late sixteenth century, William R. Shea asserted that ‘[m]athematicians, under the guidance of Euclid and Archimedes, viewed the world in terms of geometric shapes which obeyed mathematically expressible laws’.1 In my judgement, Shea’s view should be accepted, even though it was not only Euclid and Archimedes who escorted Galileo into new territories such as, for instance, Two New Sciences, or the Discourse on Buoyancy. A more complex picture has gradually emerged thanks to a number of studies that have examined in detail Galileo’s accept- ance of the Euclidean theory of proportions (or proportional reasoning) as the langu- age of early mathematized physics.2 Yet no research has so far been devoted to the cognitive mechanisms underlying Galileo’s mathematization of nature. This paper addresses some questions related to this theme by adopting a cognitive history perspective which relies on the theory of mental models (on mental models, see Sect. 2, Pt. I; on cognitive history, see Sect. 2, Pt. II). Moreover, through a discussion of Galileo’s alleged use of thought experi- ments the paper suggests how a cognitive history perspective might complement E-mail address: [email protected] (P. -

Galileo's Construction of Idealized Fall in the Void
Hist. Sci., xliii (2005) GALILEO’S CONSTRUCTION OF IDEALIZED FALL IN THE VOID Paolo Palmieri University of Pittsburgh 1. INTRODUCTION How did Galileo achieve his mathematical natural philosophy? How did he discover the times-squared law, the pendulum isochronism, the parabolic trajectory of projec- tiles — by experiment or by mathematical reasoning? Questions like these have long divided scholars into two camps: the advocates of experiment and the advocates of geometry. Is there an alternative to the two horns of this dilemma? I am convinced that there is indeed a viable alternative. Before substantiating my claim, however, I need to sketch the essential elements characterizing the division. I will do so through the exemplar case which is central to my study here. In 1604 Galileo wrote a letter to Paolo Sarpi, in which he put forward an “errone- ous” principle from which he claimed that he could derive the times-squared law of fall. The principle is as follows: the ratio of the speeds of fall is the same as the ratio of the spaces fallen through. In referring to that “erroneous” principle, Alexandre Koyré argues that Galileo already knew all the details concerning the phenomenon of fall, such as the sameness of ratios between the spaces traversed and the squares of the elapsed times (on sameness of ratios more below, in Section 3).1 What Galileo had long wanted to discover, in Koyré’s view, was a general principle from which he could deduce the law of fall geometrically. In other words, Koyré continues, Galileo sought to fi nd the essence, i.e., the defi nition, or law, of the phenomenon “fall of bodies”. -

Evropa – Dediščina Humanistov Avstrija
EVROPA Dediščina humanistov Humanitas aradi česa smo človeška bitja edinstvena? To vprašanje so razumniki znova Značeli v obdobju renesanse, ob branju spisov rimskega govornika Cicerona (106–43 p. n. št.). o njem se ljudje od drugih živih bitij razlikujemo v razumnosti jezika; upo- Prabljati ga je treba izčiščeno in natančno, saj naj bi negovanje razuma – in ta se izrazi z jezikom – pojilo človeško dostojanstvo (humanitas); humanitas za- objema – širše in globlje od sodobnega izraza »človeštvo« – vidik »človeka, kot ga opredeljuje njegova celovita umnost«. Jezik bi si moral s pravilno uporabo prizadevati k resnici in skupnemu dobru. akšne jezikovne in filozofske misli so se s svojo sodobno noto dotaknile Trenesančnih učenjakov, saj je takratna akademska in kulturna naravnanost jezik omejila na njegov praktični okvir, ki ga je bilo treba strukturirati, klasifi- cirati in opredeliti; miselna svoboda in estetska rast nista bili prednostni vre- dnoti. Skupaj z družbeno-političnimi spremembami se je razmahnilo tudi vpra- šanje človekovega dostojanstva, zlasti v tedanjem obdobju prehoda. Na temelju klasičnega arhetipa so se študij za opredeljevanje Človeka, tako imenovanih studia humanitatis, lotili z daljnosežnimi učinki. Skupaj z razpustitvijo takra- tnih miselnih vzorcev je bil sedaj posameznik poklican, da svoja razum in jezik uporabi za preizpraševanje avtoritete in tradicionalnega znanja, oblikovanje lastnega mnenja, prevzem politične odgovornosti, uveljavitev vrednote osebne izkušnje, zvedavo ustvarjanje lastne predstave o svetu in njeno izražanje ter odpiranje uma na vse mogoče načine, onkraj ustaljenih meja. To so vrednote, na katerih bi morala temeljiti sodobna Evropa. Evropa – zapuščina humanistov Stran 2 od 62 GOETHE-INSTITUT LJUBLJANA IN CANKARJEV DOM Vsebina Čudež Evrope: Hrvaška . 30 Švedska . -

L'homme Et Son Univers Aumoyen Äge
PHILOSOPHES MEDIEVAUX -------- TOME XXVII ----- _ L'HOMME ET SON UNIVERS AUMOYEN ÄGE Actes du septieme congres international de philosophie medievale (30 aoüt - 4 septembre 1982) edites par Christian WEN IN 11 LOUVAIN-LA-NEUVE EDITIONS DE L'INSTITUT SUPERIEUR DE PHILOSOPHIE 1986 FREDERICK PURNELL, JR. HENRY OF GHENT AS MEDIEVAL PLATONIST IN THE PHILOSOPHY OF JACOPO MAZZONI The connections between Renaissance Platonism and medieval Scholasticism have been the object of ongoing scholarly interest for many years. Attention has focused, for example, upon the extent to which medieval Augustinianism provided a paradigm for the Christianized Neoplatonism expounded by Marsilio Ficino and his associates in the Florentine Academyt '). Less attention has been paid to the influence of medieval sources on later Renaissance Platonists, many of whom developed philosophical positions which differed quite notably from those of Ficino and his circle. The present paper will examine the way in which Jacopo Mazzoni of Cesena (1548-98), a philosopher who sought to combine elements of both Platonism and Aristotelianism in his own system, relied for his interpretation of several important Platonic doctrines on the writings of the thirteenth-century secular master of arts and theology at Paris, Henry of Ghent. Jacopo Mazzoni has largely escaped the attentions of modern his- torians of philosophy, although he was an important figure in his own day. His facility in philosophy, first demonstrated in his student days at the University of Padua under the celebrated Aristotelians Federigo Pendasio and Jacopo Zabarella, was augmented by an insatiable appetite for independent study and a capacious memory. At the height of his powers during the last decade of his life Mazzoni held chairs in philosophy successively at the Universities of Macerata, Pisa and Rome, commanding an unprecedented salary at the latter institution as the successor to Francesco Patrizi. -

Barbara Niebelska-Rajca Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin [email protected]
TERMINUS t. 20 (2018), z. 4 (49), s. 523–542 www.ejournals.eu/Terminus http://orcid.org/0000-0003-0525-4547 Barbara Niebelska-Rajca Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin [email protected] O estetyce Jacopa Mazzoniego Jacopo Mazzoni, Della difesa della Comedia di Dante, a cura di Claudio Moreschini e Luigia Businarolo, Società di Studi Romagnoli, Cesena 2017, ss. 641 Abstract On the Aesthetics of Jacopo Mazzoni. Jacopo Mazzoni, Della difesa della Comedia di Dante, a cura di Claudio Moreschini e Luigia Businarolo, Società di Studi Romagnoli, Cesena 2017, 641 pp. Th e study examines Jacopo Mazzoni’s aesthetic thought expressed in his monu- mental, erudite work Della difesa della Comedia di Dante (1587). Th e fi rst critical edition of the opening book of the treatise was published in 2017, with a preface, commentaries and notes by Claudio Moreschini and Luigia Businarolo. Th e edition includes also Introduttione e sommario—an extensive introduction to Della difesa that summarizes Mazzoni’s main aesthetic arguments, more broadly discussed in the subsequent seven books of his treatise. Th e paper briefl y describes the genesis of Della difesa, stemming from the late 16th-century debate on Dante’s Comedy as well as Mazzoni’s main sources, and the interrelation between his aesthetic thought and philosophical ambition to create a synthesis and reconciliation of Platonic and Aristotelian traditions. Mazzoni’s po- etics is based on a reinterpretation of Plato’s doctrine mixed with Aristotle’s concep- 524 Barbara Niebelska-Rajca tion of mimesis. Outlining main directions of the past and recent research on Della difesa, the paper emphasizes the most original and vanguard of Mazzoni’s positions on the nature of poetry. -

La Nouvelle Géométrie De Francesco Patrizi Da Cherso Thomas De Vittori
La nouvelle géométrie de Francesco Patrizi da Cherso Thomas de Vittori To cite this version: Thomas de Vittori. La nouvelle géométrie de Francesco Patrizi da Cherso. 2010. hal-00414155v2 HAL Id: hal-00414155 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00414155v2 Preprint submitted on 3 Jan 2011 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. La nouvelle géométrie de Francesco Patrizi da Cherso Thomas de Vittori ∗ 2010 Résumé Dans son De spacio physico et mathematico, Francesco Patrizi da Cherso (1529-1597) propose une refonte de la philosophie naturelle dans laquelle l’espace devient le premier concept. Annoncée dans ce premier texte, les conséquences de cette mutation sur ce que doit être la géométrie sont importantes et Patrizi propose dans la Nuova Geo- metria une réécriture complète des principes de cette discipline. Dé- véloppées principalement dans les premiers livres autour de réflexions sur le point et la ligne, les thèses proposées par Patrizi sont représenta- tives des changements épistémologiques ayant permis le passage d’une géométrie vue comme science des figures dans l’espace à une science de l’espace. Mots clés : géométrie, espace, lieu, Patrizi, Renaissance ∗Univ Lille Nord de France F-59 000 LILLE, FRANCE UArtois, Laboratoire de Ma- thématiques de Lens EA 2462, Fédération CNRS Nord-Pas-de-Calais FR 2956, Faculté des Sciences Jean Perrin, Rue Jean Souvraz, S.P. -

Enhancing the Research on Sophistry in the Renaissance
Enhancing the Research on Sophistry in the Renaissance Teodoro Katinis Abstract: This contribution introduces the proceedings of The idea of two conferences was shaped on the structure the international conference The Sophistic Renaissance: of my two-year research project that aimed to analyze the Authors, Texts, Interpretations held in Venice on Septem- works of Sperone Speroni degli Alvarotti (Padua 1500– ber 26th, 2016 as part of my Marie Skłodowska-Curie pro- 1588), his re-evaluation of ancient sophistic perspectives and ject Sperone Speroni (1500-1588) and the Rebirth of their legacy in the early modern age. Speroni was one of the Sophistry in the Italian Renaissance at Ca’ Foscari Uni- most important protagonists of the Renaissance debate on versity (2015-2016). This introduction briefly presents the language and logic as well as civil and speculative philoso- status quaestionis and the essays collected herein, dis- phy. Educated as an Aristotelian, he eventually developed a cusses the challenges scholars encounter while exploring distinctive philosophy and was the first to challenge Plato’s the legacy of ancient sophists in early modern culture, and condemnation of sophists. Starting with a focus on Speroni, addresses some promising lines of research for deepening the project proposed an analysis of the 15th-century Latin some aspects of the subject in the future. sources, such as Leonardo Bruni and Marsilio Ficino among others, and the exploration of the debate over sophistry in the Keywords: Sophistry, Latin Renaissance, vernacular Italian 16th-century authors, such as Torquato Tasso, Jacopo Renaissance. Mazzoni, and Gabriele Comanini.3 Considering that Latin lit- erature was the first involved in the rebirth of sophistic tradi- tions, I intended to focus the first conference more on Latin 1. -

The Poetics of Phantasia: Some Remarks on the Renaissance Concepts of Imagination and “Fantastic Imitation”
Zagadnienia Rodzajów Literackich, LXI, z. 1 PL ISSN 0084-4446 DOI: https://doi.org/10.26485/ZRL/2018/61.1/3 BARBARA NIEBELSKA-RAJCA Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II* The Poetics of Phantasia: Some Remarks on the Renaissance Concepts of Imagination and “Fantastic Imitation” Abstract According to the traditional view, the notion of imagination in early modern aesthetics was a rather marginal and subsidiary concept within the classical doctrine of mimesis dominated by rules and reason. The present paper raises some doubts about this well- established opinion. It argues that even if imagination in early modern aesthetics did not play as prominent role as in Romantic poetics, the concept had significant relevance. It presents one important episode from the Renaissance debate on imagination, which arose from the sixteenth century literary quarrel over the artistic quality and the uncertain genre of Dante’s Commedia. Its main distinctive category was “fantastic imitation” — a concept derived from Plato, yet misunderstood and thus transformed. phantasia, imagination, fantastic imitation, Renaissance poetics, Renaissance aesthetics, Jacopo Mazzoni * Instytut Filologii Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II al. Racławickie 14, 20-950 Lublin e-mail: [email protected] la phantasia è la propria potenza delle favole poetiche. (Mazzoni 2017: 547) In his famous 1966 essay Jalons pour une histoire du concept d’imagination, Jean Starobinski asked a vital question: should scholars be content with the stereotypically strong contrast between the hegemony of reason in early modern literature and the flourishing of imagi- nation in Romanticism? (Starobinski 1970). Despite the considerable time that has passed since Starobinski’s observations, the thought-scheme he pointed out seems to remain valid. -

16 Tim.Hankins.Opm.Indd
Plato’s Psychogony in the Later Renaissance: Changing Attitudes to the Christianization of Pagan Philosophy The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Hankins, James. 2005. Plato’s psychogony in the later Renaissance: Changing attitudes to the Christianization of pagan philosophy. In Platons Timaeos als Grundtext der Kosmologie in Spätantike, Mittelalter und Renaissance, ed. Thomas Leinkauf and Carlos Steel, Vol. 34, Ancient and Medieval Philosophy, Series 1, 387-406. Leuven: Leuven University Press. Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:6311230 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA PLATO’S PSYCHOGONY IN THE LATER RENAISSANCE: CHANGING ATTITUDES TO THE CHRISTIANIZATION OF PAGAN PHILOSOPHY JAMES HANKINS (Harvard University) In his Comparatio Platonis et Aristotelis of 597, Jacopo Mazzoni, a pro- fessor of philosophy at Pisa, tells a curious story about Plato in early Greek Christianity: It is also worth observing (Mazzoni writes) a story related to us by Ni- cetas, an ancient scholiast on [St. Gregory] Nazianzenus, while anno- tating [the latter’s] second oration on Easter. He writes that once, when a certain Christian was in the habit of flaying Plato with curses and abuse, calling him the father of all heresies, -

Scholars and Literati at the University of Macerata (1540–1800)
Repertorium Eruditorum Totius Europae - RETE (2021) 2:39–45 39 https://doi.org/10.14428/rete.v2i0/Macerata Licence CC BY-SA 4.0 Scholars and Literati at the University of Macerata (1540–1800) David de la Croix Gaia Spolverini IRES/LIDAM, UCLouvain This note is a summary description of the set of scholars and literati who taught at the University of Macerata from its inception in 1540 to the eve of the Industrial Revolution (1800). 1 The University The University of Macerata, located in the hilltop town of Macerata in the Italian Marches region, was established in 1540 with a bull issued by Pope Paul III, although the rst attempt at founding a university in Macerata dates as far back as 1290. In his book The Universities of the Italian Renais- sance, Paul Grendler (2002) provides a detailed summary of its history. Macerata became the fourth university of the Papal State after Bologna, Rome, and Perugia, and looked closely at the example of Bologna for its statute and organization. It started as a rather small institution; however with time, both the pool of students and the faculty increased signicantly, thereby making Macerata a vibrant intellectual center in the Marches. 2 Sources The book I docenti dell’antica Università di Macerata (1540-1824) by Sandro Serangeli (2010) is a comprehensive biographic collection of the professors emeriti and intellectuals that became part of the faculty of Macerata from its foundation to the beginning of the 19th century. The book is structured in two parts: the rst compiles the lectores by order of rst appointment, while the second sorts them in alphabetical order. -

Galileo's Logic of Discovery and Proof Boston Studies in the Philosophy of Science
GALILEO'S LOGIC OF DISCOVERY AND PROOF BOSTON STUDIES IN THE PHILOSOPHY OF SCIENCE Editor ROBERT S. COHEN, Boston University Editorial Advisory Board ADOLF GRUNBAUM, University of Pittsburgh SYLVAN S. SCHWEBER, Brandeis University JOHN J. STACHEL, Boston University MARX W. WARTOFSKY, Baruch College of the City University ofNew York VOLUME 137 WILLIAM A. WALLACE University of Maryland at College Park GALILEO'S LOGIC OF DISCOVERY AND PROOF The Background, Content, and Use 0/ His Appropriated Treatises on Aristotle's Posterior Analytics SPRINGER-SCIENCE+BUSINESS MEDIA, B.V. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Wallace, William A. Ga I i I eo' slog i c of discovery and of proof : the background, content, and use of his appropriated treatises on Aristotle's Posterior analytics I William A. Wallace. p. cm. -- (Boston studies in the phi losophy of science v. 137. ) Inc I udes index. ISBN 978-90-481-4115-9 ISBN 978-94-015-8040-3 (eBook) DOI 10.1007/978-94-015-8040-3 1. Science--Methodology--History--16th century. 2. Logic, Modern--16th century. 3. Knowledge, Theory of. 4. EVidence -History--16th century. 5. Galilei, Galileo, 1564-1642. 6. Aristotle. Posterior analytics. I. Title. II. Series. 0174.B67 vol. 137 [0174.81 001' .01s--dc20 [501 J 91-45044 Printed on acid-free paper All Rights Reserved @ 1992 by Springer Science+Business Media Dordrecht Originally published by Kluwer Academic Publishers in 1992 Softcover reprint of the hardcover 1st edition 1992 No part of the material protected by this copyright notice may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written permission from the copyright owner.