Letteratura Triestina X Lions
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
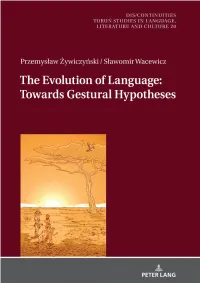
PDF Generated By
The Evolution of Language: Towards Gestural Hypotheses DIS/CONTINUITIES TORUŃ STUDIES IN LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE Edited by Mirosława Buchholtz Advisory Board Leszek Berezowski (Wrocław University) Annick Duperray (University of Provence) Dorota Guttfeld (Nicolaus Copernicus University) Grzegorz Koneczniak (Nicolaus Copernicus University) Piotr Skrzypczak (Nicolaus Copernicus University) Jordan Zlatev (Lund University) Vol. 20 DIS/CONTINUITIES Przemysław ywiczy ski / Sławomir Wacewicz TORUŃ STUDIES IN LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE Ż ń Edited by Mirosława Buchholtz Advisory Board Leszek Berezowski (Wrocław University) Annick Duperray (University of Provence) Dorota Guttfeld (Nicolaus Copernicus University) Grzegorz Koneczniak (Nicolaus Copernicus University) The Evolution of Language: Piotr Skrzypczak (Nicolaus Copernicus University) Jordan Zlatev (Lund University) Towards Gestural Hypotheses Vol. 20 Bibliographic Information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data is available in the internet at http://dnb.d-nb.de. The translation, publication and editing of this book was financed by a grant from the Polish Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland within the programme Uniwersalia 2.1 (ID: 347247, Reg. no. 21H 16 0049 84) as a part of the National Programme for the Development of the Humanities. This publication reflects the views only of the authors, and the Ministry cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Translators: Marek Placi ski, Monika Boruta Supervision and proofreading: John Kearns Cover illustration: © ńMateusz Pawlik Printed by CPI books GmbH, Leck ISSN 2193-4207 ISBN 978-3-631-79022-9 (Print) E-ISBN 978-3-631-79393-0 (E-PDF) E-ISBN 978-3-631-79394-7 (EPUB) E-ISBN 978-3-631-79395-4 (MOBI) DOI 10.3726/b15805 Open Access: This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial No Derivatives 4.0 unported license. -

Catalogo Della Biblioteca Di Ada Ed Ernesto Rossi
Catalogo della biblioteca di Ada ed Ernesto Rossi collocazioneAutore/i e Titolo Luogo/Editore Anno, Ediz. ABB Abba, Giusepppe Cesare - Da Quarto al Volturno, Noterelle d'uno dei Mille Milano, Mondadori ABO <L'>aborto - <L'>aborto Roma, Movimento Gaetano Salvemini 1973 ACQ Acquaviva, Sabino S. - <L'> eclissi del sacro nella civiltà industriale Milano, Comunità 1961, 01 ACT Acton, Harry B. - <L'>illusione dell'epoca, Il marxismo-leninismo come filosofia Milano, Comunità 1961 AGA Aga Rossi, Elena - Dal partito popolare alla democrazia cristiana Bologna, Cappelli 1969 AGA Rossi, ElenaAga - <Il> movimento repubblicano Giustizia e Libertà e il Partito d'Azione Bologna, Cappelli 1969 AGE Ageno, Mario - Elementi di fisica Torino, Einaudi 1956 AGN Agnelli, Susanna - Vestivamo alla marinara Milano, Mondadori 1975, 01 AGN Agnello, Giuseppe - <La> mia vita nel ventennio Siracusa, Mascali 1962 AGO Agosti, Aldo - Rodolfo Morandi, Il pensiero e l'azione politica Bari, Laterza 1971, 01 AGO Agostini, Amedeo, Bortolotti, Enea - Esercizi di Geometria Analitica Bologna, Zanichelli 1925, 01 AIC Aicard, Jean - Maurin des Maures Paris, Nelson 193?, 01 AJA Ajar, Emile, Bogliolo, Giovanni - La vita davanti a sé, Traduzione di Giovanni Bogliolo Milano, Rizzoli 1978, 01 ALA Alarcòn, Pedro de - <Il> cappello a tre punte Milano, Rizzoli 1950, 01 ALA Alatri, Paolo - <Le> origini del fascismo Torino, Einaudi 1956, 01 ALA Alarcon, Pedro De, Berra, Camillo - <Il> cappello a tre punte, A cura di Camillo Berra Torino, Torinese 1933, 01 ALB Albertini, Mario, Chiti-Batelli, -

La Biblioteca Di Adriano Olivetti
(prefazione di) Laura Olivetti LA BIBLIOTECA DI ADRIANO OLIVETTI Fondazione Adriano Olivetti Adriano aveva amato, nella sua giovinezza, un solo romanzo: I sognatori del Ghetto di Israel Zangwill. Tutti gli altri che aveva letto dopo non l’avevano scosso. Mostrava gran rispetto per i romanzieri e i poeti, ma non li leggeva; e le sole cose che lo attraevano al mondo erano l’urbanistica, la psicanalisi, la filosofia e la religione. da Lessico Famigliare di Natalia Ginzburg Collana Intangibili 21 La Biblioteca di Adriano Olivetti Collana Intangibili, Fondazione Adriano Olivetti, n. 21, 2012 ISBN 978 88 96770 15 3 La Collana Intangibili è un progetto della: Fondazione Adriano Olivetti Direzione editoriale Francesca Limana Redazione Beniamino de’ Liguori Carino, Viviana Renzetti, Matilde Trevisani Fondazione Adriano Olivetti Sede di Roma Via Giuseppe Zanardelli, 34 - 00186 Roma tel. 06 6877054 fax 06 6896193 Sede di Ivrea Strada Bidasio, 2 - 10015 Ivrea (TO) tel./fax 0125 627547 www.fondazioneadrianolivetti.it Tutto il materiale edito in questa pubblicazione, ad esclusione delle appendici docu- mentali per le quali si prega di fare riferimento alle fonti citate nel testo, è disponi- bile sotto la licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia. Significa che può essere riprodotto a patto di citare la fonte, di non usarlo per fini commerciali e di condividerlo con la stessa licenza. Questo volume è stato realizzato con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore La Biblioteca di Adriano Olivetti Indice Prefazione di Laura Olivetti, Presidente Fondazione Adriano Olivetti pag. -

Les Institutions Caritatives De Rome Et Turin
Préparée à l’École Pratique des Hautes Études Dans le cadre d’une cotutelle avec l’Université de Bologne Modèles féminins comparison de bienfaisance à l'epoque de l'émancipatione juive: les institutions caritatives de Rome et Turin Female charity models compared in the age of Jewish emancipation: the pious works of Rome and Turin Composition du jury : Soutenue par Maria Cadelo Mme Francesca, SOFIA Le 25 mars 2020 Professeur des universités, Université de Bologne Presidente École doctorale n° 472 Mme Giovanna, D’AMICO Professeur des universités, Université de École doctorale de l’École Messine Examinateur Pratique des Hautes Études Mme Alessandra, VERONESE Professeur des universités, Examinateur Université de Pise Spécialité Langues, littératures et M. Philippe, PORTIER Directeur d’études, civilisation juives École Pratique des Hautes Études Examinateur Mme Antonella, SALOMONI Professeur des universités, Université de Calabre Co-Directeur de thèse Mme Judith, OLSZOWY-SCHLANGER Directeur d’études, École Pratique des Hautes Études Directeur de thèse MODÈLES FÉMININS COMPARAISON DE BIENFAISANCE À L'EPOQUE DE L'ÉMANCIPATION JUIVE: LES INSTITUTIONS CARITATIVES DE ROME ET TURIN (Maria Cadelo) Introduction: notes méthodologiques et nouvelles pistes de recherche Ce travail découle d'une enquête menée dans le domaine de l'assistance et de la charité, notamment sur le rôle des femmes juives à Rome et Turin, à partir de l'âge d'émancipation des minorités. Le but que je me suis fixé était de comprendre dans quelle mesure leur participation a contribué à créer de nouveaux espaces d'intervention, à la fois au sein de la communauté juive et dans la réalité sociale au sens large. -

SB Stanza Studio Bobbio 1926 - 2003
Archivio Norberto Bobbio – Stanza Studio Bobbio SB Stanza Studio Bobbio 1926 - 2003 La documentazione collocata nella Stanza Studio Bobbio era contenuta in parte in scatole rosse con etichetta cartacea manoscritta, in parte in faldoni chiusi con bottone metallico, in parte in contenitori aperti agganciati ad una struttura girevole denominata Rotor posta accanto alla scrivania, in parte in fascicoli posti sulla libreria, accanto e sopra a libri relativi all'argomento, sul piano e nei cassetti della scrivania. Inoltre è stata ricondotta allo Studio la documentazione che, per motivi di spazio o di lavorazione, era migrata prevalentemente nelle stanze di più recente costituzione, Laboratorio e Archivio, e in misura minore nella Stanza Valeria e nella soffitta della casa di via Sacchi. Parte della documentazione dalla soffitta era stata già trasferita presso il Centro studi Piero Gobetti. I titoli attribuiti ai Contenitori in cui è articolata la Stanza Studio Bobbio derivano, per la maggior parte, dalla denominazione originale dei contenitori fisici (scatole, faldoni, contenitori aperti Rotor, fascicoli). L'ordine di elencazione dei Contenitori rispecchia a grandi linee la disposizione originaria nella stanza a partire dalle scatole rosse sistemate nella parte bassa, chiusa, della libreria sulla parete con gli ingressi verso la Stanza Laboratorio e la Stanza Corridoio proseguendo poi in senso orario. Accanto ai faldoni del Contenitore “SB.25 Interviste” ve ne erano alcuni denominati “Articoli per la Stampa” contenenti ritagli di giornale, -
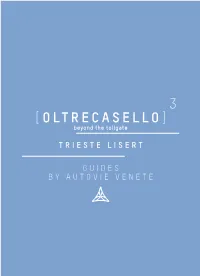
Duino- Aurisina
3 [ OLTRECASELLO] beyond the tollgate TRIESTE LISERT GUIDES BY AUTOVIE VENETE Autovie Venete 0432 925111 - 040 3189235 www.autovie.it Design and implementation: © Echo Comunicazione d’Impresa Milano [email protected] - www.echocom.it Editorial coordination: Alessia Spigariol Graphics design: Lorenzo Paolo Sdraffa Interactive english version: Altrementi Adv Illustrations: Enrico Gisana Translations: Rossella Mainardis/RB First issue: November 2014 In consideration of the particular characteristics of the Internet, the publisher shall not be held responsible for any changes of addresses and contents of the sites mentioned herein. Editors: Mara Bon (Food, Wine and Typical produce, Lunches and dinners, Shopping) is a journalist, with a passion for art and food. She has published several articles on the culture of food and wine for daily, weekly, monthly and field guide magazines and has edited studies of social-economic surveys, tour- ist marketing and geographical analysis for various boards. Christian Seu (The Land, Historical and artistic routes) is a freelance jour- nalist, ANSA correspondent for Gorizia Province and collaborates with daily newspaper Messagero Veneto. He has been Press officer in Gorizia and communications manager of nu- merous cultural events in the capital town of this area. In the past, he col- laborated with the daily newspaper Il Piccolo and Radio Gorizia 1 and is co- owner of the communications Studio Area12. We thank Turismo FVG and Autovie Venete Press Office for their collabora- tion. All photos in this Guide are courtesy of Turismo FVG Archives, except those on pages 72-73, 87, 103, which are courtesy of Autovie Venete archives. Information office Trieste Turismo FVG: Infopoint FVG Piazza Orologio 1, angolo Piazza Unità d’Italia 34121 Trieste Tel. -

Language Origins: from Mythology to Science
Language Origins: From Mythology to Science Przemysław Żywiczyński This a pre-print of the book Language Origins, 2018, pub. Peter Lang Acknowledgements This book owes a great deal to a great many people. I am deeply indebted to Prof. Piotr Stalmaszczyk and Prof. Aleksander Szwedek, who took on the burden of reviewing the book and whose numerous comments significantly improved its quality. My warm thanks go to friends and colleagues – Prof. Rafał Michalski, Dr. Maciej Pokornowski, Dr. Rafał Toczko, Marta Sibierska and Dr. Sławomir Wacewicz – who familiarised themselves with the manuscript and generously offered advice. I thank Dr. John Kearns for untiring proofreading and expert editorial guidance. I want to express gratitude to Prof. Mirosława Buchholtz, Editor of Peter Lang’s series Dis/Continuties and Head of the Department of English at the Nicolaus Copernicus University, who kindly agreed for this book to appear in the series and enthusiastically supported the writing and publication process. I also would like to acknowledge Prof. Przemysław Nehring for the financial support that made its publication possible. I owe the greatest debt to Monika Boruta, without whose careful reading and editorial help the completion of this work would have been difficult, if not impossible. Contents Introduction 0.1. Motivation for the book 0.2. Organisation of the material 0.3. Methodological problems 0.4. Main sources Chapter 1. Divine origins of language and 1.1. Glottogononic myths 1.2. Glossogenetic myths Chapter 2. The problem of the Adamic language 2.1. Definition of the Adamic problem and its textual basis 2.2. The Kabbalah 2.3. -

Ekaterina Velmezova Kalevi Kull Stephen J. Cowley Editors Biosemiotic Perspectives on Language and Linguistics Biosemiotics
Biosemiotics 13 Ekaterina Velmezova Kalevi Kull Stephen J. Cowley Editors Biosemiotic Perspectives on Language and Linguistics Biosemiotics Volume 13 Series editors Jesper Hoffmeyer, Professor emeritus in biochemistry, University of Copenhagen Kalevi Kull, Professor in biosemiotics, University of Tartu Alexei Sharov, National Institute of Aging, Baltimore Aims and Scope of the Series Combining research approaches from biology, semiotics, philosophy and linguistics, the fi eld of biosemiotics studies semiotic processes as they occur in and among living systems. This has important implications and applications for issues ranging from natural selection to animal behaviour and human psychology, leaving biosemiotics at the cutting edge of the research on the fundamentals of life. The Springer book series Biosemiotics draws together contributions from lead- ing scholars in international biosemiotics, producing an unparalleled series that will appeal to all those interested in the origins and evolution of life, including molecular and evolutionary biologists, ecologists, anthropologists, psychologists, philoso- phers and historians of science, linguists, semioticians and researchers in artifi cial life, information theory and communication technology More information about this series at http://www.springer.com/series/7710 Ekaterina Velmezova • Kalevi Kull Stephen J. Cowley Editors Biosemiotic Perspectives on Language and Linguistics Editors Ekaterina Velmezova Kalevi Kull Centre for Linguistics and Language Department of Semiotics Sciences / Department -

Catalogo Della Monografie E Degli Opuscoli Della Biblioteca Privata Di Guido De Ruggiero
Catalogo della monografie e degli opuscoli della biblioteca privata di Guido De Ruggiero ABBAGNANO, NICOLA La nozione del tempo secondo Aristotele / Nicola Abbagnano. - Lanciano : G. Carabba, stampa 1933. - 116 p. ; 20 cm. AHRENS, HEINRICH Cours de droit naturel ou de philosophie du droit, fait d’après l’état actuel de cette science en Allemagne / par H. Ahrens. - 3. ed. revue et augmentée. - Bruxelles : Meline, Cans et C. 1848. - IX, 520 p. ; 23 cm. Enciclopedia giuridica, ovvero Esposizione organica della scienza del diritto e dello Stato fondata sui principii di una filosofia etico-legale / del professore H. Dr. Ahrens ; prima versione italiana pei dottori in legge Eisner e Marenghi. - Milano ; Verona : Civelli Giuseppe. - 2 v. ; 23 cm. (Temi alemanna contemporanea) - Posseduto: Vol. 1: 359 p. ALBANESE, CLODOMIRO Studi su la filosofia di G. Duns Scoto : la teoria del conoscere / Clodomiro Albanese. - Roma : Libreria di scienze e lettere, 1923. - 208 p. ; 20 cm. ALBEGGIANI, FERDINANDO Arte e vita / Ferdinando Albeggiani. - Firenze : La Voce, 1921. - 77 p. ; 18 cm. (Scuola e vita ; 36) ALBÈRGAMO, FRANCESCO Le basi teoretiche della fisica nuova / Francesco Albergamo. - Padova : Cedam, stampa 1940. - 139 p. ; 26 cm. (Problemi d’oggi : collana di filosofia e storia della filosofia ; 4) Lo spirito come libertà creatrice / Francesco Albèrgamo. - Firenze : La nuova Italia, 1941. - 117 p. ; 20 cm. Storia della logica delle scienze esatte / Francesco Albergamo. - Bari : G. Laterza & Figli, 1947. - XV, 366 p. ; 21 cm. - (Biblioteca di cultura moderna ; 432) ALBERINI, CORIOLANO Die deutsche Philosophie in Argentinien / von Coriolano Alberini ; mit einem Geleitwort von Albert Einstein. - Berlin : Einrich Wilhelm Hendriock, 1930. - 83 p., [1] c. -

Download PDF (933.4
Chapter 1 The Beginnings of Language and Language Origins The history of enquiry into language origins shows how the emergence of language was regarded as a key issue from the earliest times – one that is crucial for understanding of what makes us human. Interest in the gen- esis of language is universal – it appears in various cultural and histor- ical periods, inspiring thinkers to construct scenarios of language creation based on contemporary evidence and ideas. In addition to emphasising the element of universality, this line of enquiry provides inspiration for con- temporary researchers: questions posed in the distant past continue to at- tract the attention of scholars. These include, for example, whether in the initial phase of its development, language imitated the sounds of nature or what the original modality of language was. Our reconstruction also has another, equally important goal, which is to raise awareness of the qual- itative difference between speculations about the beginnings of language in even the recent past, and the strictly scientific approach adopted by the contemporary research on language evolution, the modern field of knowl- edge that deals with the problem of language origins. This chapter is divided into two parts. In Section 1.1, “Religious beginnings”, we discuss religious reflections on the beginnings of language, particularly the divine origin of language. Drawing on examples from both the occidental Christian and Jewish traditions, as well as that of India, we illustrate the universality of ideas about the origins of language and its diversification. Section 2.1, “Glottogenetic thought”, is devoted to natu- ralistic scenarios of the emergence of language, which were formulated by European thinkers with the advent of the modern era. -

Catalogo Delle Monografie Della Biblioteca Privata Di Franco Lombardi Con La Cura Editoriale Di Melissa Tiberi
Catalogo delle monografie della biblioteca privata di Franco Lombardi con la cura editoriale di Melissa Tiberi A SESSANT’ANNI DALLA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE – A sessant’anni dalla Rivoluzione d’Ottobre : Speciale TG1. - [Roma] : Ufficio stampa RAI radiotelevisione italiana, stampa 1977. - 227 p. ; 18 cm. - Testi di quattro puntate del programma Speciale TG1 in onda nell’ottobre 1977, a cura di Pierantonio Graziani e Bruno Vespa. - (Appunti dell’Ufficio stampa ; 80). ABBAGNANO, NICOLA – La fisica nuova : fondamenti di una teoria della scienza / Nicola Abbagnano. - Napoli : Guida, stampa 1934. - 125 p. ; 19 cm. – Il nuovo idealismo inglese ed americano / Nicola Abbagnano. - Napoli : F. Perrella, 1927. - VII, 281 p. ; 24 cm. - (Biblioteca di filosofia). – Il principio della metafisica / Nicola Abbagnano. - Napoli : Morano, 1936. - 133 p. ; 22 cm. – Sommario di Filosofia e pedagogia, per gli Istituti magistrali / Nicola Abbagnano. - Napoli : A. Morano, 1937. - 316. p. ; 29 cm. – La struttura dell’esistenza / Nicola Abbagnano. - Torino [etc.] : G. B. Paravia, stampa 1939. - XII, 201 p. ; 26 cm. - (Pubblicazioni della Facoltà di magistero ; 6). – L’uomo progetto duemila : dialogo con Giuseppe Grieco / Nicola Abbagnano. - Roma : Dino Editori, 1980. - 269 p. ; 22 cm. - (Ragione e tempo). THE ABDICATION OF PHILOSOPHY – The abdication of philosophy : philosophy and the public good : essays in honor of Paul Arthur Schilpp / edited by Eugene Freeman. - La Salle : Open Court, 1976. - 328 p. : tav. ; 21 cm. ACCATTINO, PAOLO – Società e valori nel pensiero greco / Di Paolo Accattino. - Torino : Loescher, 1980. - 281 p. ; 19 cm. - (Collezione di testi e di studi. Filosofia ; 21). ACHMINOW, GERMAN FEDOR – Die Macht im Hintergrund : Totengraber des Kommunismus / G. F. -

Susan Petrilli and Augusto Ponzio
SEMIOTICS UNBOUNDED: INTERPRETIVE ROUTES THROUGH THE OPEN NETWORK OF SIGNS This page intentionally left blank Semiotics Unbounded Interpretive Routes through the Open Network of Signs Susan Petrilli and Augusto Ponzio UNIVERSITY OF TORONTO PRESS Toronto Buffalo London © University of Toronto Press Incorporated 2005 Toronto Buffalo London Printed in Canada ISBN 0-8020-8765-5 Printed on acid-free paper Toronto Studies in Semiotics and Communication Editors: Marcel Danesi, Umberto Eco, Paul Perron, Peter Schultz, and Roland Posner Library and Archives Canada Cataloguing in Publication Petrilli, Susan Semiotics unbounded : interpretive routes through the open network of signs / Susan Petrilli and Augusto Ponzio. (Toronto studies in semiotics and communication) ISBN 0-8020-8765-5 I. Ponzio, Augusto II. Title. III. Series. P99.P48 2005 1219.68 C2004-904768-X University of Toronto Press acknowledges the financial assistance to its publishing program of the Canada Council for the Arts and the Ontario Arts Council. University of Toronto Press acknowledges the financial support for its publishing activities of the Government of Canada through the Book Publishing Industry Development Program (BPIDP). This book was conceived and completed in the fertile context of constant intellec- tual exchanges with the seminal semiotician Thomas A. Sebeok. He approved the general plan and suggested the title. Parts were e-mailed to him for his perusal and final approval, and he was keen to receive the complete manuscript, whose publication he was committed to promoting with University of Toronto Press as a volume in the series Toronto Studies in Semiotics. Our great master of signs and beloved friend died unexpectedly, although peacefully, on 21 December 2001 at his home in Bloomington, Indiana.