Dal Gioco Al Game Show: Tra Regole E Strategie Televisive
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rai, Lo Vuoi Un Calcio?
19 sabato 24 settembre 2005 IN SCENA «LIVING UTOPIA», UN FILM CON UN MESSAGGIO profondamente l’identità e la storia italiane - spiega il CAMBIARE LE COSE È POSSIBILE giovane cineasta, già premiato al Cinemaster 2004 per il precedente cortometraggio Chloe Travels Time - attraverso L’esperienza di fratellanza e ribellione di una comunità percorsi umani segnati dalla consapevolezza che il mondo si hippy, il percorso artistico del teatro anarchico e pacifista può cambiare». Ecco l’invocazione «Paradise now» della Living Theatre, la lotta di liberazione del comandante comune hippy nata sul monte Colma tra il 1968 e il 1973, partigiano Carlo: tre storie diverse, spesso in contrasto, ma Ecco la sperimentazione artistica del Living Theatre di unite dal forte legame con il territorio dell’appenino Judith Malina, gruppo anarchico teatrale nato negli Stati piemontese e dalla medesima ricerca di una libertà dai Uniti e stabilitosi in Italia negli anni ‘70 a Rocchetta Ligure. contorni utopici, «più bussola e ragione di vita che sogno Ecco, infine, la storia di Gianbattista Lazagna, alias il compiutamente realizzabile». È Living Utopia, il nuovo comandante Carlo della divisione Pinan Cichero, e dei film-documentario del 26enne torinese Gigi Roccati partigiani che con lui condivisero la lotta di liberazione presentato venerdì a Gavi al Festival internazionale nazionale. Lavagnino.«Racconti da una terra che ha segnato Luigina Venturelli ARIA DI CRISI Bonolis delude le attese, Mentana anche. Per- sino la fiction perde il confron- to. Benché avesse tutte le carte in mano, Mediaset fa ora i conti con investitori e inserzionisti perplessi dopo una stagione in cui ha speso tutto il possibile.. -

Micro-Costs: Inertia in Television Viewing∗
Micro-costs: Inertia in television viewing∗ Constan¸caEsteves-Sorenson Fabrizio Perretti Yale University Bocconi University January 2012 Abstract We document substantial default effects despite negligible switching costs in a novel setting: television program choice in Italy. Despite the low costs of clicking the remote and of searching across only six channels and despite viewers extensive experience with the decision, show choice depends strongly on whether viewers happened to watch the previous programme on the channel. Specifically, (i) male and female viewership of the news depends on whether the preceding programme appealed to men or women, and (ii) a show's audience increases by 2-4% with an increase of 10% in the demand for the preceding program. These results are robust to endogenous scheduling. This behaviour appears most consistent with procrastination in switching, which stations fully exploit in their scheduling. ∗Corresponding author: Constan¸caEsteves-Sorenson, Yale School of Management, 135 Prospect Street, New Haven, CT, 06520 ([email protected]). We thank Stefano DellaVigna, Steven Tadelis and Catherine Wolfram for their valuable advice. We also thank Gregorio Caetano, Arthur Campbell, Urmila Chat- terjee, Keith Chen, Judy Chevalier, Liran Einav, Pedro Gardete, Jeff Greenbaum, Rachita Gullapalli, Ahmed Khwaja, Botond K}oszegi,Kory Kroft, Rosario Macera, Alex Mas, Amy Nguyen-Chyung, Miguel Palacios, Gisela Rua, Rob Seamans, Olav Sorenson, Betsy Stevenson, Justin Wolfers and participants in the Berkeley Psychology & Economics, Berkeley Haas School of Business, Emory Goizueta Business School, Melbourne Business School, University of Pennsylvania Wharton School, University of Toronto Rotman School of Management, and Yale School of Management seminars for valuable suggestions at different stages of this project. -

Mediaset Group 2017 Consolidated Annual Report
Annual Report 2017 MEDIASET S.p.A. - via Paleocapa, 3 - 20121 Milan Share Capital Euros 614,238,333.28 fully paid up Tax Code, VAT number and inscription number in the Milan Enterprises Register: 09032310154 Website: www.mediaset.it Table of Contents Consolidated Financial Statements 2017 Directors’ report on operations Corporate Boards ..................................................................................................... 1 Financial Highlights .................................................................................................. 2 Directors’ Report on Operations ................................................................................ 5 General economic trends ........................................................................................... 8 Development in the legislative framework in the television sector ................................. 9 Mediaset shares ..................................................................................................... 11 Significant Events and Key Corporate Transaction for the year ................................... 13 The Main Group companies ...................................................................................... 16 Group Profile and Performance Review by Business Segment ..................................... 17 Consolidated Performance by Geographical Area and Business Segment Economic Results ............................................................................................. 51 Balance Sheet and Financial Position ................................................................. -

Mediaset Group
MEDIASET GROUP Report on operations in the first quarter of 2000 MEDIASET S.P.A. - VIA PALEOCAPA, 3 - 20121 MILAN SHARE CAPITAL ITL 1,180,320,964,000 WHOLLY PAID-UP REGISTERED IN MILAN NO. 276785 (MILAN COURT) TAX CODE – VAT NUMBER: 09032310154 Officers of the Company Board of Directors Chairman Fedele Confalonieri Executive Vice President Pier Silvio Berlusconi Managing Director Giuliano Adreani Directors Franco Amigoni Tarak Ben Ammar Marina Berlusconi Pasquale Cannatelli Enzo Concina Maurizio Costa Mauro Crippa Gilberto Doni Adriano Galliani Alfredo Messina Jan Mojto Gina Nieri Michele Preda Roberto Ruozi Claudio Sposito Michel Thoulouze Board of Statutory Auditors Chairman Achille Frattini Statutory Auditors Francesco Antonio Giampaolo Riccardo Perotta Acting Auditors Gianfranco Polerani Francesco Vittadini Independent Auditors Deloitte & Touche S.p.A. Contents REPORT ON OPERATIONS IN THE FIRST QUARTER OF 2000 1 MEDIASET GROUP - ECONOMIC AND FINANCIAL RESULTS 2 GENERAL CRITERIA 2 ECONOMIC RESULTS 2 BALANCE SHEET AND FINANCIAL STRUCTURE 10 ANALYSIS OF THE VARIOUS AREAS 14 ADVERTISING 14 COMMERCIAL TV NETWORKS ITALY 14 TELEVISION ABROAD 16 DIVERSIFICATION AND DEVELOPMENT 20 SIGNIFICANT EVENTS AFTER 31 MARCH 2000 22 FORESEEABLE DEVELOPMENTS 22 MEDIASET GROUP REPORT ON OPERATIONS IN THE FIRST QUARTER OF 2000 Dear Shareholders, This is the first quarterly report drafted by the Group heading your Company in compliance with the obligation introduced as of 1 January 2000, for the groups floated at the Stock Exchange, by Art. 82 of the Consob deliberation no. 11971 of 14 May 1999. After the exceptional results obtained in 1999, the economic situation in the first quarter 2000 augurs extremely well for achieving equally significant objectives in this year, as is Mediaset’s intention. -

Sul Ponte Di Comando
zione della struttura societaria, con l’obiettivo di creare un gruppo in- GIULIANO ADREANI tegrato nel campo televisivo e delle comunicazioni, capace di crescere II autonomamente, di attrarre investi- menti azionari di partner strategici SUL PONTE DI COMANDO e finanziari e di quotarsi in Borsa: iuliano Adreani è dal 1994 fraintendimenti, di giochi imper- Significa anche che la tv generali- VENT’ANNIVENT’ANNI Mediaset è il frutto di questo pro- amministratore delegato scrutabili della politica e della giu- sta, contrariamente alle previsioni getto. della concessionaria di stizia. Ma in definitiva, proprio co- dei profeti di sventure, gode ottima Tra il ‘94 e il ‘95 Mediaset rileva Mediaset per la raccolta me dice Adreani stesso, sono i fatti salute, visto che la stessa Internet, DIDI il controllo di Publitalia ‘80, non- pubblicitaria delle tre reti; che contano più delle opinioni, e i per comunicare se stessa su vasta ALIA chè di R.T.I., concessionaria delle dal 1996 ne ha assunto fatti, andando a ritroso nel tempo, scala, non può assolutamente farne ALIA tre concessioni televisive, di Vi- anche la carica di presi- dicono ad esempio che nel 1995 Pu- a meno. In altre parole, come con- PUBLITPUBLIT deotime, di RTI Music e di Elettro- dente. E’ uno dei principa- blitalia fatturava 2.700 miliardi e ne ferma lo stesso Adreani, si è inne- nica Industriale. li artefici di una escalation senza perdeva 25. Le cifre degli anni suc- scato un circolo virtuoso nel quale Gprecedenti nella storia della pubbli- cessivi, sempre relative ai ricavi to- si fa pubblicità sui mezzi tradiziona- cità: è riuscito perfino a superare i tali lordi pubblicitari (fonte: bilanci li per attirare pubblicità sui new record da lui stesso conquistati in Publitalia ‘80), ci dicono che nel media.. -

Mediaset Group
Report on Operations as at 30th September 2002 MEDIASET GROUP MEDIASET S.p.A. - via Paleocapa, 3 - 20121 Milan Share capital EUR 614,238,333.28 wholly paid-up Taxpayer’s code, VAT number and registration number in the register of companies in Milan: 09032310154 BOARD MEMBERS Board of directors Chairman (*) Fedele Confalonieri Deputy Chairman (*) Pier Silvio Berlusconi Managing Director (*) Giuliano Adreani Directors Franco Amigoni Tarak Ben Ammar Marina Berlusconi Pasquale Cannatelli Enzo Concina Maurizio Costa Mauro Crippa Gilberto Doni Bruno Ermolli Adriano Galliani (1) Marco Giordani Alfredo Messina Jan Mojto (*) Gina Nieri Roberto Ruozi (*) Claudio Sposito Board of statutory auditors Chairman Achille Frattini Regular Auditors Francesco Antonio Giampaolo Riccardo Perotta Alternate Auditors Gianfranco Polerani Francesco Vittadini Independent Auditors Deloitte & Touche S.p.A. (*) Members of the Executive Committee (1) Resigned on 10 July 2002 CONTENTS Report on operations in the third quarter of 2002.......................................................................... 1 Financial and economic results of the Mediaset Group............................................................................ 3 Drafting criteria................................................................................................................................... 3 Economic results................................................................................................................................. 3 Balance sheet and financial position -

Mediaset Group
MEDIASET GROUP Report on operating performance in the first half of 2002 Interim Report 2002 MEDIASET S.p.A. - via Paleocapa, 3 - 20121 Milan Share capital EUR 614,238,333.28 wholly paid-in Taxpayer’s code, VAT number and registration number in the register of companies in Milan: 09032310154 Report on operating performance in the first half of 2002 Interim Report 2002 BOARD MEMBERS Board of Directors Chairman (*) Fedele Confalonieri Deputy Chairman (*) Pier Silvio Berlusconi Managing Director (*) Giuliano Adreani Directors Franco Amigoni Tarak Ben Ammar Marina Berlusconi Pasquale Cannatelli Enzo Concina Maurizio Costa Mauro Crippa Gilberto Doni Bruno Ermolli Adriano Galliani (1) Marco Giordani Alfredo Messina Jan Mojto (*) Gina Nieri Roberto Ruozi (*) Claudio Sposito Board of Statutory Auditors Chairman Achille Frattini Regular Auditors Francesco Antonio Giampaolo Riccardo Perotta Supplementary Auditors Gianfranco Polerani Francesco Vittadini Independent Auditors Deloitte & Touche S.p.A. (*) Members of the Executive Committee (1) Resigned on 10 July 2002 CONTENTS Report on operations in the first half of 2002................................................................................... 1 The general economic situation................................................................................................................ 5 Financial and economic results of the Mediaset Group............................................................................ 6 Drafting criteria.................................................................................................................................. -

Mediaset Group
Report on Operations as at 30th September 2000 MEDIASET GROUP MEDIASET S.p.A. - via Paleocapa, 3 - 20121 Milan Share Capital ITL 1,181,227,564,000 wholly paid-up Registered in Milan no. 276785 (Milan Court) Tax Code – VAT Number: 09032310154 OFFICERS OF THE COMPANY Board of Directors Chairman (*) Fedele Confalonieri Executive Vice President (*) Pier Silvio Berlusconi Managing Director (*) Giuliano Adreani Directors Franco Amigoni Tarak Ben Ammar Marina Berlusconi Pasquale Cannatelli Enzo Concina Maurizio Costa Mauro Crippa Gilberto Doni Adriano Galliani Alfredo Messina Jan Mojto (*) Gina Nieri Roberto Ruozi (*) Claudio Sposito Michel Thoulouze Board of Statutory Auditors Chairman Achille Frattini Statutory Auditors Francesco Antonio Giampaolo Riccardo Perotta Acting Auditors Gianfranco Polerani Francesco Vittadini Independent Auditors Deloitte & Touche S.p.A. (*) Members of the Executive Committee CONTENTS Report on operations as at 30th September 2000.................................................................... 1 Mediaset Group – Economic and Financial Results............................................................................. 3 General Criteria .......................................................................................................................... 3 Economic Results ........................................................................................................................ 3 Balance sheet and financial structure........................................................................................11 -

UC Berkeley UC Berkeley Electronic Theses and Dissertations
UC Berkeley UC Berkeley Electronic Theses and Dissertations Title Inertia and Earnings gaps: Essays in Behavioral and Labor Economics Permalink https://escholarship.org/uc/item/2jj2888p Author Esteves-Sorenson, Constanca Medeiros Publication Date 2009 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California Inertia and Earnings gaps: Essays in Behavioral and Labor Economics by Constanca Medeiros Esteves-Sorenson A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Business and Administration in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Steven Tadelis, Chair Professor Stefano DellaVigna Professor Catherine Wolfram Fall 2009 Abstract Inertia and Earnings Gaps: Essays in Behavioral and Labor Economics by Constanca Medeiros Esteves-Sorenson Doctor of Philosophy in Business Administration University of California, Berkeley Professor Steven Tadelis, Chair Abstract for first essay: Micro-costs, inertia in television viewing. Inertia, defined as the persistent choice for the default option, affects outcomes from organ donations to enrollment in retirement plans. A leading explanation for inertia is the cost of switching to an alternative option. Can consumers display inertia in a setting where this cost is negligible? If so, is this behavior systematic and significant enough to affect the profit- maximizing strategies of firms? This paper finds inertia in a setting in which the switching cost is extremely small: a click of the remote in the choice of television programs. In the absence of a significant switching cost, the audience of a program should not depend on the audience of the prior show on the same channel, controlling for the non-random assignment of programs. -

MEDIASET GROUP MEDIASET S.P.A
Report on Operations in the third Quarter of 2001 MEDIASET GROUP MEDIASET S.p.A. - via Paleocapa, 3 - 20121 Milan Share Capital EUR 614.238.333,28 wholly paid-up Tax Code, VAT Number and registration number in the register of companies in Milan: 09032310154 BOARD MEMBERS Board of Directors Chairman (*) Fedele Confalonieri Deputy Chairman (*) Pier Silvio Berlusconi Managing Director (*) Giuliano Adreani Directors Franco Amigoni Tarak Ben Ammar Marina Berlusconi Pasquale Cannatelli Enzo Concina Maurizio Costa Mauro Crippa Gilberto Doni Bruno Ermolli Adriano Galliani Marco Giordani Alfredo Messina Jan Mojto (*) Gina Nieri Roberto Ruozi (*) Claudio Sposito Board of Statutory Auditors Chairman Achille Frattini Statutory Auditors Francesco Antonio Giampaolo Riccardo Perotta Supplementary Auditors Gianfranco Polerani Francesco Vittadini IndependentIndependent Auditors Deloitte & Touche S.p.A. (*) Members of the Executive Committee CONTENTS Report on operations as of September 30, 2001……………………………………………. 1 Economic and financial results of the Mediaset Group ................................................. 3 Drafting criteria ......................................................................................................... 3 Economic results ........................................................................................................ 4 Balance sheet and financial position ……………….. .................................................. 12 Analysis of the various operating areas ........................................................................ -
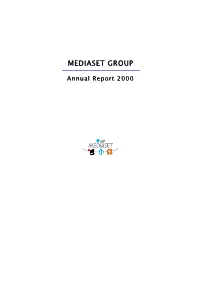
Mediaset Group Mediaset Group (Net of the Epsilon Group)
MEDIASET GROUP Annual Report 2000 MEDIASET S.p.A. - via Paleocapa, 3 - 20121 Milan Share capital ITL 1,181,227,564,000 wholly paid-in. Taxpayer’s code, VAT number and registration number in the register of companies in Milan: 09032310154 MEDIASET GROUP 2001 Ordinary and Extraordinary General Meeting Report, Consolidated Financial Statements and Annual Financial Statements for the year ended December 31, 2000 BOARD MEMBERS Board of Directors Chairman Fedele Confalonieri Deputy Chairman Pier Silvio Berlusconi Managing Director Giuliano Adreani Directors Franco Amigoni Tarak Ben Ammar Marina Berlusconi Pasquale Cannatelli Enzo Concina Maurizio Costa Mauro Crippa Gilberto Doni Bruno Ermolli Adriano Galliani Marco Giordani Alfredo Messina Jan Mojto Gina Nieri Roberto Ruozi Claudio Sposito Board of Statutory Auditors Chairman Achille Frattini Statutory auditors Francesco Antonio Giampaolo Riccardo Perotta Alternate auditors Gianfranco Polerani Francesco Vittadini IndependentIndependent AuditingAuditing FirmFirm Deloitte & Touche S.p.A. NOTICE OF MEETING The shareholders are called to attend the ordinary and extraordinary general meeting to be held in Via Cinelandia 5, Cologno Monzese (Milan), on April 9, 2001, at 10:00 a.m., for the first call and, should it be required, on April 17, 2001, at the same time and venue, for the second call, to decide upon the following agenda: 1) appointment of Directors; 2) annual and consolidated financial statements as of December 31, 2000; Report on operations of the Board of Directors; Report of the Statutory Auditors; consequent resolutions; 3) authorization to the Board of Directors for the purchase and disposal of own shares, following revocation of the current authorization; consequent resolutions; 4) conversion of the share capital in Euro; consequent resolutions; 5) modification of art. -

Mediaset Group
MEDIASET GROUP Interim Report 2000 Report on operating performance for the First half of 2000 MEDIASET S.p.A. - via Paleocapa, 3 - 20121 Milano Share Capital Itl. 1,181,227,564,000 entirely paid in Registered with the Commercial Register of Milan with n. 276785 (Trib. of Milan) Fiscal Code and VAT Number: 09032310154 Interim Report 2000 Report on operating performance for the First half of 2000 THE COMPANY’S STRUCTURE Board of Directors Chairman (*) Fedele Confalonieri Deputy-Chairman (*) Pier Silvio Berlusconi Managing Director (*) Giuliano Adreani Directors Franco Amigoni Tarak Ben Ammar Marina Berlusconi Pasquale Cannatelli Enzo Concina Maurizio Costa Mauro Crippa Gilberto Doni Adriano Galliani Alfredo Messina Jan Mojto (*) Gina Nieri Roberto Ruozi (*) Claudio Sposito Michel Thoulouze Board of Auditors Chairman Achille Frattini Statutory Auditors Francesco Antonio Giampaolo Riccardo Perotta Alternate Auditors Gianfranco Polerani Francesco Vittadini Independent Auditing Firm Deloitte & Touche S.p.A. (*) Members of the Executive Committee CONTENTS Board of Directors’ Report on the First half of 2000.................................................. 1 General economic trends and outlook..................................................................................... 5 The Mediaset Group’s financial results.................................................................................... 7 Drawing up criteria....................................................................................................... 7 Financial results.............................................................................................................