27-Laganara.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Northern Puglia & the Gargano Promontory
© Lonely Planet Publications 84 www.lonelyplanet.com 85 Northern Puglia & the Gargano Promontory Crowning Italy’s boot, the northern province of Foggia (the capitanata) is an attractive NORTHERN PUGLIA & THE NORTHERN PUGLIA & THE land of contrasting geographical bands, from the mountainous rocky spur of the Gargano GARGANO PROMONTORY Promontory to the vast flat tablelands of the Tavoliere and the gentle rolling hills of the Daunia Pre-Apennines. The Tavoliere is the wheatbowl of southern Italy, covering half of the capitanata in a 3000-sq-km geometric chequerboard of golden fields. Tracks across the plains bear witness to the centuries-old transhumance routes, the ancient droving trails or tratturi along which sheep and cattle were moved from Abruzzo to Puglia. The wheatfields surrounding the provincial capital of Foggia gently give way to the wetlands and salt works of Margherita di Savoia on the southeast coast, a region famous for its prolific birdlife. To the west, the Tavoliere merges into the undulating foothills, shallow valleys and wooded slopes of the beautiful Daunia mountains. Here, castles and towers of the medieval hilltop towns watch over Foggia’s Pre-Apennine border. Puglia’s only mountainous zone is the stunning Gargano Promontory, a blunt spur of limestone cliffs and dense forest jutting into the blue Adriatic Sea. Its landscape, flora and fauna are a geographical anomaly in Puglia’s Mediterranean mezzogiorno, more Croatian than southern Italian. Millions of years ago the Gargano was separated from the mainland by a thin strip of ocean. Now its unique beauty and summer seaside resorts are a favourite with Italian and German tourists. -

Francesco Violante Organizzazione Del Territorio E Strutture Produttive Tra XI E XVI Secolo
Francesco Violante Organizzazione del territorio e strutture produttive tra XI e XVI secolo [A stampa in Storia di Manfredonia, dir. S. Russo, I, Il Medioevo, a cura di R. Licinio, Edipuglia, Bari 2008, pp. 101-123 © dell’autore e dell’editore - Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”, www.biblioteca.retimedievali.it]. ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E STRUTTURE PRODUTTIVE TRA XI E XVI SECOLO di Francesco Violante Siponto-Manfredonia: il territorio Nella vicenda storica della città di Siponto e, in seguito, di Manfredonia, un ruolo peculiare e originale svolgono le caratteristiche geo-morfologiche, litologiche e idro- logiche del territorio e le loro dinamiche. Siponto sorgeva infatti sul mare, nell’ansa formata dalla costa pugliese a sud del Gargano, in un territorio costituito in preva- lenza, dal punto di vista geologico e litologico, da calcari di piattaforma risalenti al Cretacico alternati ad argille e calcareniti pleistoceniche e plioceniche e a detriti di falda e depositi alluvionali databili all’Olocene e continuamente accresciuti, in epoca storica, dal corso dei fiumi Candelaro, Cervaro, Carapelle e affluenti minori, attualmente so- pravviventi in forma torrentizia 1. L’evoluzione delle forme insediative e del paesaggio agrario sono state strettamente legate a questa conformazione geofisica. Il progressivo impaludamento dell’insenatura che ospitava Siponto nel corso del XIII secolo, processo definitivamente concluso alla fine del XVI secolo, è dovuto infatti all’azione dei depo- siti alluvionali di corsi d’acqua dotati di una portata maggiore rispetto all’attuale, fe- nomeno probabilmente causato da condizioni climatiche generalmente più calde, mentre il paesaggio agrario si strutturava nelle forme dello sfruttamento cerealicolo- pastorale nelle zone argillose pedemontane e della piana del Tavoliere 2. -

St. Lawrence Majoranus
aint Lawrence Majoranus S U U V-VI Century Saint Lawrence was appointed to be Bishop of Siponto, but his fame is due to the three appari- 1 tions that indicated the birth of the Sanctuary Shrine dedicated to the Archangel Michael, which was constructed in a grotto on Mount Gargano, Italy. In 490, a rich gentleman was letting Archangel appeared to the Bishop and predicted his herds graze on the mountain of Gargano. a sure and total victory. This message filled Suddenly his best bull disappeared and was with hope the hearts of the besieged people. found kneeling at the opening of a cave. The defenders came out of the city and Overcome with anger, he shot an arrow towards started a furious battle, accompanied by strikes, the rebellious animal, but in an inexplicable thunderous blasts, and arrows with lightening way, instead of striking the bull, the arrow speed and extraordinary intensity. The victory injured the foot of the rich gentleman. of the Sipontines was resounding. Troubled by the event, he went to In the third apparition, which took Bishop Lawrence, who, after listening to the place in the year 493, Saint Lawrence had by now story of the extraordinary adventure, ordered decided to execute the order of Saint Michael to three days of prayer and penitence. At the end of consecrate the grotto to him as a sign of recog- the third day, the Archangel Michael appeared nition, comforted also by the positive opinion of to the Bishop and said this to him: “I am the Pope Gelasius I, but again the Archangel appeared Archangel Michael and I am always in the to him and announced that He himself had presence of God. -

Schede Degli Ambiti Pesaggistici
Elaborato n. 5: Schede degli Ambiti Pesaggistici A. DESCRIZIONI STRUTTURALI DI SINTESI B. INTERPRETAZIONE IDENTITARIA E STATUTARIA C. SCENARIO STRATEGICO Ambito 3/ TAVOLIERE Piano Paesaggistico Territoriale Regionale http//:www.paesaggio.regione.puglia.it INDICE DELLA SCHEDA DI AMBITO SEZIONE A - SEZONE B - SEZIONE C - DESCRIZIONI STRUTTURALI DI SINTESI INTERPRETAZIONE IDENTITARIA E STATUTARIA LO SCENARIO STRATEGICO A0_ B1. C1. INDIVIDUAZIONE DELL’AMBITO INTERPRETAZIONE STRUTTURALE DI SINTESI OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA E TERRITORIALE A1_ B2. C2. RAPPRESENTAZIONE IDENTITARIA: STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA AZIONI, POLITICHE, PROGETTI - Estratto della carta del patrimonio A2_ - Le figure territoriali dell’ambito STRUTTURA ECOSISTEMICO - AMBIENTALE B3. LE REGOLE STATUTARIE: A3_ STRUTTURA ANTROPICA E STORICO CULTURALE - Descrizione delle invarianti strutturali (rilevanza) - Stato di conservazione delle invarianti (integrità) A3.1 Lettura identitaria e patrimoniale di lunga durata - Regole di riproducibilità delle invarianti A3.2 I paesaggi rurali A3.3 Caratteri agronomici e colturali A3.4 I paesaggi urbani A3.5 I paesaggi costieri A3.6 Struttura percettiva e valori della visibilità sezione A - descrizioni strutturali di sintesi SEZ. A0 - INDIVIDUAZIONE DELL’AMBITO REGIONI FIGURE TERRITORIALI E AMBITI DI LIMITe deLL’ aMbITo GEOGRAFICHE PAESAGGISTICHE PAESAGGIO A STORICHE (UNITa’ MINIMe dI PaeSaGGIo) L’articolata bassezza del Tavoliere, 3.1 La piana foggiana della riforma ora piatta, ora leggermente ondula- ta, trova nel rilevo unitario e uniforme 3.2 Il mosaico di San Severo 3.2 del Gargano uno sfondo, un ulteriore 3.3 Il mosaico di Cerignola orizzonte più elevato. Le montagne B Puglia grande del Subappennino costituiscono l’al- Tavoliere 3.4 Le saline di Margherita di (tavoliere 2° liv) Savoia tro recapito visivo, più consueto, più normale e rassicurante. -

Glass Making in the Greco-Roman World Studies in Archaeological Sciences 4
Glass Making in the Greco-Roman World Studies in Archaeological Sciences 4 The series Studies in Archaeological Sciences presents state-of-the-art methodological, technical or material science contributions to Archaeological Sciences. The series aims to reconstruct the integrated story of human and material culture through time and testifies to the necessity of inter- and multidisciplinary research in cultural heritage studies. Editor-in-Chief Prof. Patrick Degryse, Centre for Archaeological Sciences, KU Leuven, Belgium Editorial Board Prof. Ian Freestone, Cardiff Department of Archaeology, Cardiff University, United Kingdom Prof. Carl Knappett, Department of Art, University of Toronto, Canada Prof. Andrew Shortland, Centre for Archaeological and Forensic Analysis, Cranfield University, United Kingdom Prof. Manuel Sintubin, Department of Earth & Environmental Sciences, KU Leuven, Belgium Prof. Marc Waelkens, Centre for Archaeological Sciences, KU Leuven, Belgium Glass Making in the Greco-Roman World Results of the ARCHGLASS Project Edited by Patrick Degryse Leuven University Press Published with support of © 2014 by Leuven University Press / Presses Universitaires de Louvain / Universitaire Pers Leuven. Minderbroedersstraat 4, B-3000 Leuven (Belgium). All rights reserved. Except in those cases expressly determined by law, no part of this publication may be multiplied, saved in an automated datafile or made public in any way whatsoever without the express prior written consent of the publishers. ISBN 978 94 6270 007 9 D / 2014 / 1869 / 86 NUR: 682/933 Lay-out: Friedemann Vervoort Cover: Jurgen Leemans 5 Preface The ARCHGLASS “Archaeometry and Archaeology of Ancient Glass Production as a Source for Ancient Technology and Trade of Raw Materials” project, is a Seventh Framework Programme “Ideas” project funded under the European Research Council Starting Grant scheme. -

Manfredonia Μανφρεντόνια Barletta Μπαρλέττα Bari Μπάρι Monopoli Μονόπολι Brindisi Μπρίντιζι
THEMIS PORTS I PORTI DI THEMIS ΤΑ ΛΙΜΕΝΑ Manfredonia Μανφρεντόνια Barletta Μπαρλέττα Bari Μπάρι Monopoli Μονόπολι Brindisi Μπρίντιζι Gallipoli Γκαλίπολι Corfu Κέρκυρα Paxos Παξοί LEAD BENEFICIARY ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ SOUTHERN ADRIATIC SEA PORTS AUTHORITY AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ piazzale Cristoforo Colombo, 1 - 70122 Bari +39 080 578 8511 [email protected] www.adspmam.it PARTNER BENEFICIARIES ΕΤΑΙΡΟΙ MUNICIPALITY OF GALLIPOLI CHAMBER OF COMMERCE OF BARI COMUNE DI GALLIPOLI CAMERA DI COMMERCIO DI BARI ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΓΚΑΛΛΙΠΟΛΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΠΑΡΙ via Antonietta De Pace, 78 - 73014 Gallipoli (LE) corso Cavour, 2 - 70121 Bari +39 0833 275501 +39 0802174252 [email protected] [email protected] www.comune.gallipoli.le.it www.ba.camcom.it themis.adspmam.it PORT AUTHORITY OF CORFU MUNICIPALITY OF PAXOS AUTORITÀ PORTUALE DI CORFÙ COMUNE DI PAXOS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ Corfu, New Port - New terminal - 49100 Greece 49082 Greece +30 2661045551 +30 26623-60300 / 26620-32100/207 [email protected] [email protected] www.corfuport.gr www.paxi.gr @interregthemis MANFREDONIA TERRITORIAL AND MARITIME NETWORK SUPPORTING THE SMALL CRUISES DEVELOPMENT DA SOSTITUIRE themis.adspmam.it @interregthemis MANFREDONIAΜανφρεδονίας COMUNE DI GALLIPOLI Project co-funded by European Union, European Regional Development Funds (E.R.D.F.) and by National Funds of Greece and Italy Discover the experience of exclusive journeys Charming experiences and exclusive tours meant for luxury cruise tourism, around the territories of Puglia and Greece. The Interregional Project Themis is aimed at supporting and enhancing the minor ports and at consolidating the connections with the main ports and the local businesses. -

La “Via Francigena Della Capitanata” Studio Per Un Progetto Di Valorizzazione Turistica Ed Economica Del Territorio Della Provincia Di Foggia
Dipartimento di Scienze Economiche, Matematiche e Statistiche Università degli Studi di Foggia ____________________________________________________________________ LA “VIA FRANCIGENA DELLA CAPITANATA” STUDIO PER UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TURISTICA ED ECONOMICA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA Vincenzo Vecchione, Pasquale Pazienza, Massimo Russo, Renzo Infante, Luigi Longo, Michele Del Giudice e Raffaele Guglielmi Quaderno n. 14/2008 “Esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004 n. 106” Quaderno riprodotto al Dipartimento di Scienze Economiche, Matematiche e Statistiche nel mese di settembre 2008 e depositato ai sensi di legge Authors only are responsible for the content of this preprint. _______________________________________________________________________________ Dipartimento di Scienze Economiche, Matematiche e Statistiche, Largo Papa Giovanni Paolo II, 1, 71100 Foggia (Italy), Phone +39 0881-75.37.30, Fax +39 0881-77.56.16 LA “VIA FRANCIGENA DELLA CAPITANATA” STUDIO PER UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TURISTICA ED ECONOMICA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA di Vincenzo VECCHIONE – Pasquale PAZIENZA – Massimo RUSSO – Renzo INFANTE – Luigi LONGO – Michele DEL GIUDICE – Raffaele GUGLIELMI Dossier preparato dal gruppo di lavoro costituito presso l’Osservatorio Turistico del Dipartimento di Scienze Economiche Matematiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Foggia per Opera Romana Pellegrinaggi Componenti del gruppo di lavoro: Michele DEL GIUDICE (Club Alpino Italiano – Gruppo Terre Alte), Raffaele GUGLIELMI (GTours – Tour Operator), Renzo INFANTE (Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Foggia), Luigi LONGO (Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia), Pasquale PAZIENZA (Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia), Massimo RUSSO (Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia), Vincenzo VECCHIONE (Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia). -

Download PDF Datastream
A Dividing Sea The Adriatic World from the Fourth to the First Centuries BC By Keith Robert Fairbank, Jr. B.A. Brigham Young University, 2010 M.A. Brigham Young University, 2012 Submitted in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the Program in Ancient History at Brown University PROVIDENCE, RHODE ISLAND MAY 2018 © Copyright 2018 by Keith R. Fairbank, Jr. This dissertation by Keith R. Fairbank, Jr. is accepted in its present form by the Program in Ancient History as satisfying the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy. Date _______________ ____________________________________ Graham Oliver, Advisor Recommended to the Graduate Council Date _______________ ____________________________________ Peter van Dommelen, Reader Date _______________ ____________________________________ Lisa Mignone, Reader Approved by the Graduate Council Date _______________ ____________________________________ Andrew G. Campbell, Dean of the Graduate School iii CURRICULUM VITAE Keith Robert Fairbank, Jr. hails from the great states of New York and Montana. He grew up feeding cattle under the Big Sky, serving as senior class president and continuing on to Brigham Young University in Utah for his BA in Humanities and Classics (2010). Keith worked as a volunteer missionary for two years in Brazil, where he learned Portuguese (2004–2006). Keith furthered his education at Brigham Young University, earning an MA in Classics (2012). While there he developed a curriculum for accelerated first year Latin focused on competency- based learning. He matriculated at Brown University in fall 2012 in the Program in Ancient History. While at Brown, Keith published an appendix in The Landmark Caesar. He also co- directed a Mellon Graduate Student Workshop on colonial entanglements. -

Map 45 Tarentum Compiled by I.E.M
Map 45 Tarentum Compiled by I.E.M. Edlund-Berry and A.M. Small, 1997 Introduction The landforms of South Italy have changed in many respects since the classical period. On both the Tyrrhenian and Adriatic coasts the sea level has risen in relation to the landmass, submerging the Oenotrides islands which once provided anchorage off the west coast at Velia, and drowning Roman coastal installations on the Adriatic (Michaelides 1992, 21). As elsewhere in the peninsula, the increase in human population has led to deforestation of the hills, with consequent erosion of the slopes and sedimentation in the valley bottoms (Boenzi 1989; Campbell 1994; Barker 1995, 62-83). Increased silting in the lower courses of the rivers created marshy conditions in the coastal plains, which were only drained and rendered safe from malaria in the mid-twentieth century. The alluvial deposits have pushed out the coastline along the Ionian Gulf and the Gulf of Paestum, so that the remains of the ancient ports there now lie a considerable distance inland. Deforestation has also led to flash flooding, which in turn has caused rivers to change their courses. Such change is vividly illustrated by the Via Traiana, which crossed the Cerbalus and Carapelle (ancient name unknown) rivers by bridges that now straddle dry land. Other changes have been brought about by more deliberate human intervention. Several inland lakes have been drained since Roman times to provide arable land or relieve malaria. We have reconstructed these on the map where the evidence is reasonably clear, as it is at Forum Popili on the R. -
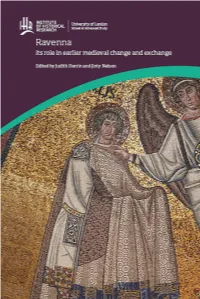
Download Free at ISBN 978‑1‑909646‑72‑8 (PDF Edition) DOI: 10.14296/917.9781909646728
Ravenna its role in earlier medieval change and exchange Ravenna its role in earlier medieval change and exchange Edited by Judith Herrin and Jinty Nelson LONDON INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH Published by UNIVERSITY OF LONDON SCHOOL OF ADVANCED STUDY INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH Senate House, Malet Street, London WC1E 7HU First published in print in 2016 (ISBN 978‑1‑909646‑14‑8) This book is published under a Creative Commons Attribution‑ NonCommercial‑NoDerivatives 4.0 International (CC BY‑ NCND 4.0) license. More information regarding CC licenses is available at https://creativecommons.org/licenses/ Available to download free at http://www.humanities‑digital‑library.org ISBN 978‑1‑909646‑72‑8 (PDF edition) DOI: 10.14296/917.9781909646728 iv Contents Acknowledgements vii List of contributors ix List of illustrations xiii Abbreviations xvii Introduction 1 Judith Herrin and Jinty Nelson 1. A tale of two cities: Rome and Ravenna under Gothic rule 15 Peter Heather 2. Episcopal commemoration in late fifth‑century Ravenna 39 Deborah M. Deliyannis 3. Production, promotion and reception: the visual culture of Ravenna between late antiquity and the middle ages 53 Maria Cristina Carile 4. Ravenna in the sixth century: the archaeology of change 87 Carola Jäggi 5. The circulation of marble in the Adriatic Sea at the time of Justinian 111 Yuri A. Marano 6. Social instability and economic decline of the Ostrogothic community in the aftermath of the imperial victory: the papyri evidence 133 Salvatore Cosentino 7. A striking evolution: the mint of Ravenna during the early middle ages 151 Vivien Prigent 8. Roman law in Ravenna 163 Simon Corcoran 9. -

Il Consorzio Per La Bonifica Della Capitanata: Attività E Territorio
Il territorio della Capitanata e della Bonifica Un territorio umido, paludoso e malsano ove stituendo una reale risorsa per la collettività, prosperavano le zanzare e malattie come la ma- alla quale il Consorzio per la bonifica della laria. Capitanata ha offerto un notevole patrimonio All’inizio del ventesimo secolo la Capitana- tecnico e di consolidata esperienza per affron- ta era una grande pianura di 400.000 ettari, tare problemi ed emergenze di vario tipo. caratterizzata da numerosi fiumi e torrenti senza Le condizioni di salubrità, di fruibilità e di regime e pestilenziali, da due estese lagune, Le- sviluppo raggiunte dal nostro territorio in se- sina di 7.000 e Varano di 5.500 ettari, dai la- guito all’attività svolta dal Consorzio non sono ghi di Versentino, Salso e Salpi che occupava- state definitivamente acquisite, ma devono es- no 6.200 ettari in una più vasta area di acqui- sere conservate provvedendo alla manutenzio- trini e stagni. ne, gestione, custodia, rinnovamento e ammo- Così si presentava il Tavoliere prima del- dernamento delle opere di bonifica. l’avvento della bonifica. È quindi necessario svolgere una permanente Da attività finalizzata esclusivamente al ri- attività di bonifica, la quale, quindi, non potrà scatto delle terre, la bonifica con il tempo è di- mai dirsi esaurita. venuta attività di difesa e valorizzazione del Per conoscerci un po’ di più, rispondiamo a territorio nel senso più ampio del termine, co- dieci domande sul consorzio di bonifica. Che cos’è e cosa fa Che cosa è un comprensorio un consorzio di bonifica? di bonifica? Un Ente pubblico che ha il compito di Un’area del territorio, idraulicamente progettare, eseguire, mantenere e gestire le omogenea, classificata di bonifica e opere di bonifica. -

Durham E-Theses
Durham E-Theses What was the Investiture Controversy a controversy about? Knight, Emma How to cite: Knight, Emma (2005) What was the Investiture Controversy a controversy about?, Durham theses, Durham University. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/2764/ Use policy The full-text may be used and/or reproduced, and given to third parties in any format or medium, without prior permission or charge, for personal research or study, educational, or not-for-prot purposes provided that: • a full bibliographic reference is made to the original source • a link is made to the metadata record in Durham E-Theses • the full-text is not changed in any way The full-text must not be sold in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. Please consult the full Durham E-Theses policy for further details. Academic Support Oce, Durham University, University Oce, Old Elvet, Durham DH1 3HP e-mail: [email protected] Tel: +44 0191 334 6107 http://etheses.dur.ac.uk What was the Investiture Controversy a Controversy About? A copyright of this thesis rests with the author. No quotation ғ.ттүไЯ ไՀ^Tาio•Ьł• ք*՛*՛™ it should be published ᄂᄂrsjugiu without his prior written consent and information derived from it should be acknowledged. MA by Research University of Durham Department of Politics 2005 I 7 纖 200B Abstract What was the Investiture Controversy a Controversy About? The ШУЄЗІІШГЄ Controversy between Pope Gregory vn and Emperor Henry rv of Germany presents us with a wide variety of issues that are not immediately discernable at first sight.