ZAMPERINI, Giulio Della Torre Studi Veronesi
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ritratto Del Marchese Gian Francesco Gonzaga
SIRBeC scheda OARL - C0050-00706 Ritratto del marchese Gian Francesco Gonzaga Bonsignori Francesco Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/C0050-00706/ Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede-complete/C0050-00706/ SIRBeC scheda OARL - C0050-00706 CODICI Unità operativa: C0050 Numero scheda: 706 Codice scheda: C0050-00706 Visibilità scheda: 3 Utilizzo scheda per diffusione: 03 Tipo scheda: OA Livello ricerca: P CODICE UNIVOCO Codice regione: 03 Numero catalogo generale: 02024468 Ente schedatore: R03/ Accademia Carrara Ente competente: S27 RELAZIONI RELAZIONI CON ALTRI BENI Tipo relazione: è compreso Tipo scheda: COL Codice bene: 03 Codice IDK della scheda correlata: COL-LMD30-0000013 OGGETTO Gruppo oggetti: pittura OGGETTO Definizione: dipinto Disponibiltà del bene: reale SOGGETTO Categoria generale: ritratto Identificazione: Ritratto del marchese Gian Francesco Gonzaga Pagina 2/28 SIRBeC scheda OARL - C0050-00706 LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE Stato: Italia Regione: Lombardia Provincia: BG Nome provincia: Bergamo Codice ISTAT comune: 016024 Comune: Bergamo COLLOCAZIONE SPECIFICA Tipologia: museo Denominazione: Accademia Carrara Denominazione spazio viabilistico: Piazza Giacomo Carrara Denominazione struttura conservativa - livello 1: Accademia Carrara Tipologia struttura conservativa: museo Collocazione originaria: SC ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE Tipo di localizzazione: luogo di provenienza LOCALIZZAZIONE -

4. Dressing and Portraying Isabella D'este
Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/33552 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Dijk, Sara Jacomien van Title: 'Beauty adorns virtue' . Dress in portraits of women by Leonardo da Vinci Issue Date: 2015-06-18 4. Dressing and portraying Isabella d’Este Isabella d’Este, Marchioness of Mantua, has been thoroughly studied as a collector and patron of the arts.1 She employed the finest painters of her day, including Bellini, Mantegna and Perugino, to decorate her studiolo and she was an avid collector of antiquities. She also asked Leonardo to paint her likeness but though Leonardo drew a preparatory cartoon when he was in Mantua in 1499, now in the Louvre, he would never complete a portrait (fig. 5). Although Isabella is as well known for her love of fashion as her patronage, little has been written about the dress she wears in this cartoon. Like most of Leonardo’s female sitters, Isabella is portrayed without any jewellery. The only art historian to elaborate on this subject was Attilio Schiaparelli in 1921. Going against the communis opinio, he posited that the sitter could not be identified as Isabella d’Este. He considered the complete lack of ornamentation to be inappropriate for a marchioness and therefore believed the sitter to be someone of lesser status than Isabella.2 However, the sitter is now unanimously identified as Isabella d’Este.3 The importance of splendour was discussed at length in the previous chapter. Remarkably, Isabella is portrayed even more plainly than Cecilia Gallerani and the sitter of the Belle Ferronnière, both of whom are shown wearing at least a necklace (figs. -

Mantegna 1506-2006
Ministero per i Beni e le Attività Culturali Comitato Nazionale per le Celebrazioni del quinto centenario della morte di Andrea Mantegna Ministero per i Beni e le Attività Culturali Comitato Nazionale per le Celebrazioni del quinto centenario della morte di Andrea Mantegna Il Comitato Nazionale per le celebrazioni del quinto centenario MANTEGNA della morte di Andrea Mantegna (Isola di Carturo, 1431 c. – Mantova, 1506), istituito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e composto dai più importanti studiosi del primo Rinascimento italiano, affiancati dai rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali 1506-2006 e degli altri Enti interessati, celebra il grande artista attraverso una mostra in ognuna delle città nelle quali la presenza del maestro e delle sue opere è documentata. COMUNE DI PADOVA COMUNE DI MANTOVA Centro Internazionale d’Arte e di Cultura di Palazzo Te Padova Padova Verona Mantova Musei Civici e Biblioteche Museo di Castelvecchio Centro Internazionale d’Arte e di Cultura Musei Civici agli Eremitani Via Porciglia, 35 – 35123 Padova Corso Castelvecchio, 2 – 37121 Verona di Palazzo Te Tel. 049 8204508 – fax 049 8204566 Tel 045 8062611 – fax 045 8010729 Viale Te, 19 – 46100 Mantova e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] Tel. 0376 369198 – fax 0376 220943 e-mail: [email protected] Verona Palazzo della Gran Guardia www.andreamantegna2006.it Mantova Palazzo Te Pubblicazione a cura di Tekne 16 settembre 2006 14 gennaio 2007 l Comitato Nazionale per le celebrazioni pubblicazione fra il 1450 e il 1457 di tre del quinto centenario della morte di grandi opere, uscite dalle botteghe di uno I Andrea Mantegna (Isola di Carturo, 1431 scultore fiorentino, Donatello, e di un pittore c. -

Venetian Painting in America; the Fifteenth Century
BOUGHT WITH THE INCOME OF THE • _ „ SAGE ENDOWMENT FUND ; THE GIFT OF HenviS M. Sage 1891 B.3.wyife3 "IaH-o-. DATE DUE hjm^^^ MArfrmfi-Ki^ - t¥iC 9n?i)8g. ,fr 'i- GAYLORD INU.S.A. '"7 , Cornell University Library The original of tiiis book is in the Cornell University Library. There are no known copyright restrictions in the United States on the use of the text. http://www.archive.org/details/cu31924008640496 VENETIAN PAINTING IN AMERICA GiovAHKi Bellini: Madomna Collection or the late Mr. Theodore M. Davis VENETIAN PAINTING IN AMERICA THE FIFTEENTH CENTURY BY BERNARD BERENSON NEW YORK FREDERIC FAIRCHILD SHERMAN MCMXVI 5 Copyright, 1916, by Frederic Fairchild Sherman PREFACE "Now that we are on the subject of Venetian Paint- ing," that would be a more exact title for this book. For, in fact, I have made the stray pictures in our col- lections the pretext for saying what I wanted to say about their authors in general. In some ways this form suits me as it suited my master, Giovanni Morelli. Like him, I have a dis- taste for including in my own writing questions that do not vividly interest me at the moment, no matter how important in themselves ; and like him, I prefer to avoid such systematic treatment as entails dealing with ma- terials either at second hand, or out of dimmed and at- tenuated recollection. It goes against the grain to write about anything that does not fascinate and absorb me. For the last few years it has been the painters of Venice, and Giovanni Bellini in particular, that have preoccupied my leisure and occupied my working hours. -

Van Ham Kunstauktionen
Van Ham Kunstauktionen Los 1019 Auction Title Fine Art Date 19.11.2020 - 14:00:00 Preview 13.11.2020 - 10:00:00 bis 16.11.2020 - 18:00:00 MANTEGNA, ANDREA 1431 Isola di Carturo - 1506 Mantua Werkstatt Titel: Martyrium des Heiligen Johannes des Täufers. Technik: Tempera und Öl auf Holz. Montierung: Parkettiert. Maße: 36 x 52cm. Rahmen/Sockel: Rahmen. Rückseitig: Auf der Tafel Sammler- und Restauratorenetiketten. Literatur: U. B. Schmitt, Francesco Bonsignori, München 1961, S.130 (als Francesco Bonsignori); F. Heinemann: Giovanni Bellini e i Belliani, Band I. Venedig 1963, Nr. V.163, S. 242, Abb. 700 (als Lauro Padovano); E. Zafran: European Art in the High Museum. Atlanta 1984, S. 40 mit Abb. (als zugeschrieben an Francesco Bonsignori); F. Zeri, F. Rossi: Accademia Carrara di Belle Arti Bergamo. La raccolta Morelli nell'Accademia Carrara, Mailand 1986, S. 133-135 (als Francesco Bonsignori); G. Valagussa: Accademia Carrara Bergamo - dipinti italiani del Trecento e del Quattrocento. Catalogo completo, Mailand 2018, S. 266-268 (als Lauro Padovano?). Provenienz: Vermutlich Sammlung Gonzaga, Mantua (15.-16. Jh.); Sammlung Vieweg, Braunschweig; Auktion Lepke, Berlin, 18.03.1930, lot 23, Abb. Tafel 46, als Paduaner Meister um 1500; Kunsthandel E.&A. Silbermann Galleries, New York; High Museum of Art, Atlanta; Auktion Christie's, New York, 26.01.2005, lot 277; Sammlung Prof. Dr. Thomas Olbricht, Essen. Van Ham Kunstauktionen GmbH & Co KG, Hitzelerstr. 2, 50968 Köln, Tel. +49 (221) 92 58 62-0, Fax: +49 (221) 92 58 62-4, E-Mail: [email protected] Van Ham Kunstauktionen Das vorliegende Gemälde ist zusammen mit einer Tafel der Darstellung "Der Heilige Johannes der Evangelist lässt Drusiana auferstehen" (Bergamo, Pinacoteca dell'Accademia Carrara, Inv. -

A Study of Unusual Black and Dark Grey Pigments Used by Artists in the Sixteenth Century
National Gallery Technical Bulletin Volume 24, 2003 National Gallery Company London Distributed by Yale University Press This volume of the Technical Bulletin is published with the generous support of the Samuel H. Kress Foundation and the American Friends of the National Gallery, London, Inc. Series editor Ashok Roy © National Gallery Company Limited 2003 All rights reserved. No part of this publication may be transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without the prior permission in writing of the publisher. First published in Great Britain in 2003 by National Gallery Company Limited St Vincent House, 30 Orange Street London wc2h 7hh www.nationalgallery.co.uk British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this journal is available from the British Library isbn 1 85709 997 4 issn 0140 7430 525043 Publisher Kate Bell Project manager Jan Green Editor Diana Davies Designer Tim Harvey Picture research Xenia Corcoran and Kim Klehmet Production Jane Hyne and Penny Le Tissier Printed in Italy by Conti Tipocolor front cover Georges Seurat, Bathers at Asnières (NG 3908), detail of plate 4, page 7 title page Giulio Romano, The Birth of Jupiter (NG 624), detail of plate 1, page 38 ‘Black Earths’: A Study of Unusual Black and Dark Grey Pigments used by Artists in the Sixteenth Century marika spring, rachel grout and raymond white n his Lives of the Artists, Vasari describes ‘an beautiful for all lights and all shadows, and espe- Iastounding piece of painting’ by Sebastiano del cially if it is the one from Venice, which comes in Piombo, a portrait of Pietro Aretino in which there little balls’.8 A terra nera di campana (black earth of may be seen ‘five or six different kinds of black in bells) is mentioned by Vasari, Armenini, Lomazzo, the clothes that he is wearing – velvet, satin, Borghini and Baldinucci. -

Lives of the Most Eminent Painters Sculptors and Architects
Lives of the Most Eminent Painters Sculptors and Architects Giorgio Vasari Lives of the Most Eminent Painters Sculptors and Architects Table of Contents Lives of the Most Eminent Painters Sculptors and Architects.......................................................................1 Giorgio Vasari..........................................................................................................................................2 LIFE OF FILIPPO LIPPI, CALLED FILIPPINO...................................................................................9 BERNARDINO PINTURICCHIO........................................................................................................13 LIFE OF BERNARDINO PINTURICCHIO.........................................................................................14 FRANCESCO FRANCIA.....................................................................................................................17 LIFE OF FRANCESCO FRANCIA......................................................................................................18 PIETRO PERUGINO............................................................................................................................22 LIFE OF PIETRO PERUGINO.............................................................................................................23 VITTORE SCARPACCIA (CARPACCIO), AND OTHER VENETIAN AND LOMBARD PAINTERS...........................................................................................................................................31 -

A Depiction of an Italian Arming Doublet, C1435-45 Tobias E. Capwell
1 A Depiction of an Italian Arming Doublet, c1435-45 Tobias E. Capwell In the Istituto al Gabinetto dei disegni e stampe della Villa Farnesina in Rome there are a series of sixteen pen on parchment drawings (Inv. FN 2818-2833), dating from between 1435 and 1445. The identity of the artist is not known, although he may have been a Paduan. The 220x295 mm drawings depict many famous figures from classical and early medieval history; thus the drawings are often referred to as the Uomini illustri series. Included are emperors, kings, war leaders, philosophers, and biblical and classical heroes. Figure 01: Julius Caeser (fol This is not the only such manuscript to survive. Related 2826v), Istituto al Gabinetto dei disegni e stampe della examples may be found in the collections of the Biblioteca Villa Farnesina, Rome, Inv. FN 2818-2833. Reale, Turin (codex 102), the National Gallery of Art in Washington (single page from the ‘Cockerell Chronicle), the British Library (the ‘Florentine Picture Chronicle’) and the Crespit Collection in Milan.1 However, the creator of the Uomini illustri series devotes an especially large proportion of his work to the study of military heroes. Therefore, these drawings are of 2 some importance to the study of fifteenth- century arms and armour. Indeed, both Mann2 and Boccia3 have included them in their works on Italian armour. The artist was clearly interested in the subject of arms and armour; this interest is articulated both in the attention to detail and in the actual use of armour as an chronological device. Military figures of the ancient world, such as Alexander (fol 2825v) and Julius Caesar (fol 2826v) are portrayed in a form of Figure 02: Godfrey de Boullion and Frederick Barbarossa (fol 2827v), Istituto al Gabinetto dei disegni e stampe della armour all’ antica, a blend of the fantastical Villa Farnesina, Rome, Inv. -
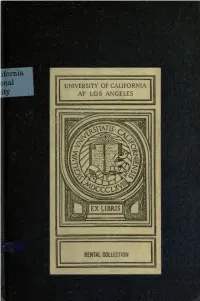
The Venetian Painters of the Renaissance : with an Index to Their
UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT LOS ANGELES RENTAL COLLECTION By Bernhard Berenson The Venetian Painters of the Renaissance. With a Frontispiece. Third Edition. Revised and enlarged. Crown 8vo, gilt top The Florentine Painters of the Renaissance. With a Frontispiece. Third revised and enlarged edition. Crown 8vo. The Central Italian Painters of the Renais- sance. With a Frontispiece. Second revised and enlarged edition. Crown 8vo. The North Italian Painters of the Renaissance. With Frontispiece. Crown 8vo. G. P. PUTNAM'S SONS Ne-w "YorK London PAINTERS TI ANCE Shepherd with Pipe, from the Painting by Giorgione, at Hampton Court. G. \ ONS tlbe Knickerbocker |>re0 THE VENETIAN PAINTERS OF THE RENAISSANCE WITH AN INDEX TO THEIR WORKS BERNHARD BERENSON " AUTHOR OF FLORENTINE PAINTERS OF THE RENAISSANCE," " " CENTRAL ITALIAN PAINTERS OF THE RENAISSANCE THIRD EDITION G. P. PUTNAM'S SONS NEW YORK AND LONDON Gbe "Knickerbocker press COPYRIGHT, 1894 BY G. P. PUTNAM'S SONS Entered at Stationers' Hall, London, BY G. P. PUTNAM'S SONS Made in the United States of America Art Library NOTE TO THIRD EDITION. VjJ ij TN this edition changes have been made in 3 the numbering of the Venice and Vienna <: Galleries, as well as of some minor collections, 55 to correspond to recent rehanging. Many other alterations have been required by the breaking up of private collections. In several r- instances it has been impossible to trace ^ pictures to their new homes, and of such the more important remain under the names of ^ their former owners. To the lists of painters have been added Beccaruzzi, Caprioli, Polidoro Lanzani, Rocco Marconi, Andrea Schiavone, 1 and Girolamo da Treviso, artists important ' O to be but of merit so i enough missed, unequal j ^> - <o that only their more interesting works are here given. -

Comunicato Stampa Mantegna 1506 – 2006 Un Artista Per Tre Città Padova
�������� �������������� ��������������� Comunicato stampa ������������������������� ��������������������� ����������������������� Mantegna 1506 – 2006 ������������������� Un artista per tre città �������������������� ����������������� Padova, Musei Civici agli Eremitani ������������ ������������������ Verona, Gran Guardia Mantova, Fruttiere di Palazzo Te 16 settembre 2006 – 14 gennaio 2007 ������������������ Un progetto straordinario che unisce tre città nel nome di Andrea Mantegna. ������������������� ���������������������������� ��������������������� Il genio del grande artista, figura di spicco del Rinascimento italiano, sarà celebrato in occasione del ��������������� quinto centenario della morte, avvenuta nel 1506, con uno storico evento espositivo articolato in tre sedi: ���������������� Padova, Verona e Mantova. ���������������������� �������������������� Tre importanti città d’arte che insieme festeggiano il maestro, capace di innovare profondamente il ������������ linguaggio artistico dell’Italia del Nord nella metà del Quattrocento; tre città unite – per la prima volta ����������� ������������������� – in un unico ambizioso progetto espositivo, che intende ripercorre l’opera di Mantegna dagli esordi alla ������������������ maturità, presentando le sue opere nei luoghi in cui ha vissuto e lavorato e cogliendo l’apporto e l’influsso ���������������� ������������������������ da lui esercitato sulla cultura del tempo. ������������������������ ��������������������� 350 opere complessive, 64 capolavori di Mantegna, 140 musei prestatori, -

MAMFA Rivera 2013.Indd
Diego Rivera The Italian Sketchbook, 1920–21 Diego Rivera The Italian Sketchbook, 1920–21 mary-anne martin fine art 23 east 73rd street new york, ny 10021 This catalogue accompanies the exhibition Diego Rivera: The Italian Sketchbook 1920–21, which will be presented at Master Drawings New York 2013. On view at the gallery January 25–February 22, 2013. Mary-Anne Martin | Fine Art 23 East 73rd Street New York, NY 10021 Tel: (212) 288-2213 Fax: (212) 861-7656 [email protected] www.mamfa.com Cover: Diego Rivera in Paris, c. 1920 collection inba, casa diego rivera, guanajuato Diego Rivera The Italian Sketchbook Pencil, conté crayon and ink on paper 30 drawings on 28 pages unbound, dimensions variable 1920–21 provenance Arquin, Florence, Diego Rivera, The Angelina Beloff (Rivera’s first wife) Shaping of an Artist, 1889-1921, gift to Jean Charlot, 1945 University of Oklahoma Press, 1971, by descent to Martin Charlot, pp. 113–143 and ff. the artist’s son Exhibition catalogue for Diego Rivera: A Retrospective, Detroit Institute of exhibition history Arts (traveling exhibition), 1986, W.W. Diego Rivera, 50 Años de su Labor Artistico, Norton, New York, fig. 73, p. 52 in the Instituto Nacional de Bellas Artes, catalogue (scaffold study). Mexico City, August–December 1949, Diego Rivera: Catálogo General de Obra de no. 192, illus. Caballete, Instituto Nacional de Bellas Diego Rivera: A Retrospective, Detroit Artes, Mexico, 1989, no. 347, p. 52. Institute of Arts, February 10–April 27, Marnham, Patrick, Dreaming with His 1986, no. 89, illus. Eyes Open: A Life of Diego Rivera, Alfred literature A. -

Italian Renaissance Portraits That Disappoint: Isabella D'este
Italian Renaissance Portraits that Disappoint: Isabella d’Este, Francesco del Giocondo and Other Displeased Patrons Faculty Research Working Paper Series Jonathan K. Nelson Syracuse University Florence and Harvard Kennedy School Richard Zeckhauser Harvard Kennedy School July 2019; Revised April 2021 RWP19-024 Visit the HKS Faculty Research Working Paper Series at: https://www.hks.harvard.edu/research-insights/publications?f%5B0%5D=publication_types%3A121 The views expressed in the HKS Faculty Research Working Paper Series are those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the John F. Kennedy School of Government or of Harvard University. Faculty Research Working Papers have not undergone formal review and approval. Such papers are included in this series to elicit feedback and to encourage debate on important public policy challenges. Copyright belongs to the author(s). Papers may be downloaded for personal use only. www.hks.harvard.edu Italian Renaissance Portraits that Disappoint: Isabella d’Este, Francesco del Giocondo and Other Displeased Patrons∗ Jonathan K. Nelson± and Richard J. Zeckhauserδ Abstract The successful fruits of Italian Renaissance patronage were often prominently displayed by the original owners and written up favorably by their contemporaries and ours. By contrast, paintings and sculptures that displeased or, worse, disgraced their patrons, though occasionally mentioned in publications about the patrons or artists, tended to get lost in historical accounts. As a result, standard assessments convey an unrealistically favorable picture. To facilitate a more balanced understanding of the patronage process, this essay addresses the risks inherent in commissioned portraits made in Italy from the late fifteenth through the late sixteenth century, including paintings by Andrea Mantegna, Domenico Ghirlandaio, and Leonardo da Vinci.