Salvatore Barbagallo Città Svelata
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Calendar of the Order of Preachers
CALENDAR OF THE ORDER OF PREACHERS JANUARY The Holy Name of Jesus 1 2 3 Blessed Stephana Quinzani, virgin 4 St. Zedislava of Lemberk, lay Dominican & mother, Obligatory memorial 5 6 7 Saint Raymond of Pennafort, priest Obligatory memorial 8 9 10 Blessed Gonsalvo of Amarante, priest; Blessed Ana Monteagudo, virgin 11 Blessed Bernard Scammacca, priest 12 13 14 15 16 17 18 Saint Margaret of Hungary, virgin Obligatory memorial 19 Blessed Andrew of Peschiera, priest 20 21 22 Blessed Antony della Chiesa, priest 23 Blessed Henry Suso, priest 24 25 26 27 Blessed Marcolino de Forlí, priest 28 Saint Thomas Aquinas, priest and doctor of the Church Feast 29 Blessed Villana de' Botti, matron 30 31 Page 1. Section Five: Hagiography FEBRUARY 1 2 3 Blessed Peter of Ruffia, priest and martyr; Blessed Antony of Pavonio, priest and martyr; Blessed Bartholomeo of Cerverio, priest and martyr 4 Saint Catherine de' Ricci, virgin Obligatory memorial Ash Wednesday does not occur before this date. 5 6 7 Anniversary of Deceased Parents 8 9 10 11 12 Blessed Reginald of Orléans, priest Optional memorial 13 Blessed Jordan of Saxony, priest Obligatory memorial 14 15 16 Blessed Nicholas of Paglia, priest 17 18 Blessed John of Fiesole [Fra Angelico], priest Optional memorial 19 Blessed Alvaro of Córdoba, priest 20 Blessed Christopher of Milan, priest 21 22 23 24 Blessed Constantius of Fabriano, priest 25 26 27 28 29 Page 2. Section Five: Hagiography MARCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ash Wednesday does not occur after this date. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Easter does not occur before this date. -

Dominican Calendar and Indulgences, 1920
DOMINICAN CALENDAR AND INDULGENCES, 1920 JANUARY Dedicated to the Holy Name lat, Thur. New Year's Day. Cir reception of sacraments on the fit:&t cumcision of Our Lord. Holy Day of Saturday of the month, prayers in Obligation. Feast-day of the Confra honor of Mary Immaculate and pray ternity of the Holy Name. General ers for the Pope's intention. absolution with plenary indulgence. 4th, Sun. Octave of Holy Innocents. Indulgences: 1. Plenary for Tertiar First Sunday of the month. Indul ies, who, having received the sacra gences: Four plenary indulgences for ments, visit a Dominican church, or Rosarians, who, having received the one having a chapter of Tertiaries, sacraments, fulfil the required condi and there pray for the Pope's inten tions, namely: 1. By visiting the tion. Those unable to receive the <;hu rch or c1iapel of the Rosary, and sacraments but fulfilling the other there praying for the intention of the conditions gain a partial indulgence Holy Father. 2. By being present at of 7 years and 7 quarantines. If the the exposition of the Blessed Sacra above churches do not exist, the par ment in any church where the Rosary ish church may be visited. 2. Plenary Society is established and there pray for members of Living Rosary Soci ing for the Pope's intentions. 3. By ety who say one decade of Rosary attending the Rosary procession, daily for one month and fulfil the praying for the Pope's intentions and usual conditions for gaining a plenary making a visit to the Rosary altar or indulgence, i. -

In PDF 515Kb 130Pp
Selections from the Supplement to the Liturgy of the Hours for the Order of Preachers A Draft Translation of the Proprium Officiorum Ordinis Praedicatorum (1982) for Study and Consultation: Dominican Liturgical Commission, U.S.A. Chicago, 1991 DIFFERENT ELEMENTS IN THE OFFICES: Historical Notes 25. In accord with the General Instruction of the Liturgy of the Hours a short biographical note has been placed at the beginning of the proper Office of each Saint or Blessed. As is the case for some Propers of certain religious families and dioceses, these short biographical notices were written in a fuller manner and edited according to contemporary historico-critical findings by the office of the Postulator General of the Order." Thus, the desire of many has been satisfied, namely, the desire for spiritual nourishment, not only from the second readings of the Office of Readings, but also from the biographical note which describes the unique characteristics of the spiritual life, the teaching, or the pastoral activity of the Saint or Blessed. These notes can serve as an initial introduction to the Saint or Blessed or as a homiletic aid, as well as a source for personal meditation. General Introduction, p. xxxiv. Liturgical Calendar of the Order of Preachers January 3 Bl. Stephana Quinzani, sister and virgin 4 Bl. Zedislava Berkiana, lay Dominican and wife 7 St. Raymond of Penyafort, friar, priest and Master of the Order Memorial 10 Bl. Gonsalvo of Amarante, friar and priest Bl. Ann of the Angels Monteagudo, nun and virgin 11 Bl. Bernard Scammacca, friar and priest 18 St. -

Anacronismo Colonial En El Santoral Dominico
Universidad de Chile Departamento de Artes Facultad de Teoría de las Artes Anacronismo colonial en el Santoral Dominico. La pervivencia de un estilo colonial quiteño hacia 1840 en Santiago de Chile. Tesis para optar al grado de Licenciada en Artes con mención en Teoría e Historia del Arte Maisa Candela Cardemil Barros Profesora guía: Dra. Constanza Acuña Fariña. 2017 1 Índice Índice…………………………………………………………………………………………….1 Agradecimientos……………………………………………………………………………....3 Introducción…………………………………………………………………………………....4 Capítulo I Antecedentes del Arte Colonial Americano, una mirada sobre los orígenes e influencias del arte colonial en Latino América. 1.1 Conquista del territorio Americano.………………………………………………..12 1.2 Arte y religión, un vínculo indisociable…………………………………………....16 1.3 El arte Manierista y el Barroco……………………………………………………..24 1.4 Configuración de un estilo colonial americano…………………………………..28 Capítulo II Los orígenes del arte en Quito, y la conformación de un estilo propio. 2.1 El arte colonial en Ecuador, una visión general sobre la simbiosis europea....31 2.2Talleres y artistas en Quito………………………………………………………….35 -

St. Bernadette Catholic Church 9020 E
St. Bernadette Catholic Church 9020 E. 51st Terrace, Kansas City, MO 64133-2125 www.stbernadettekcmo.org Facebook: St Bernadette Catholic Church KCMO Communications: ..................... Church, 356-3700; [email protected]; Fax, 737-3447 Mass Schedule: .......................... Saturday: 4:00 pm; Sunday: 8:00 am and 10:30 am Weekdays: ................................. Mass: Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 8:15 am Communion Service: ................ Monday and Saturday, 8:15 am Priest Emergency: ..................... 356-3700, press 4 May 17, 2015 Special Events: ........................... 356-3700, press 3, pause press 76 Mission Statement We the faith community of St. Bernadette exist to reach out and bring people into a relationship with Jesus Christ. Recognizing the talents and dignity of all, we acknowledge God’s call to use our gifts in developing Christian relationships and promoting spiritual growth through procla- mation of Holy Scripture. We look to the mature wisdom within our community for guidance in the faith formation of young hearts and minds. We have a special concern for the poor as we strive for peace and justice. We welcome all to a warm fellowship in our faith family through our shared belief in God the Father, Christ our Savior and the Holy Spirit. Parish Staff: Servants of God’s People Annulment Process: Contact Advocates Cathy Weidmaier or Linda Pastor, Reverend David Holloway, ext. 12 Sapenaro in the Parish Office or you may contact Allison Townley, a [email protected] Tribunal staff member, 756-1850, ext. 266. Baptisms: Prior to birth, please contact the parish office to register Pastoral Care Coordinator, Cathy J. Weidmaier, ext. 32 for the preparation class. -

The Advocate - Nov
Seton Hall University eRepository @ Seton Hall The aC tholic Advocate Archives and Special Collections 11-9-1961 The Advocate - Nov. 9, 1961 Catholic Church Follow this and additional works at: https://scholarship.shu.edu/catholic-advocate Part of the Catholic Studies Commons, and the Missions and World Christianity Commons Did You Renew Your Advocate Subscription? New Encyclical Coming, i Holy Father Discloses VATICAN CITY (NC) Anew which alone can lead them toward solid sacrifice of so many unknown ones who and the world of labor.” encyclical was by John and lasting peace.” promised Pope cannot oven reveal their hidden The Pope then noted the program XXIII at a Mass marking his 80th birth- martyrdom.” of Catholic Action prayer, action and POPE JOHN ALSO discussed his day and the third anniversary of his coronation his sacrifice —and said that, "without coronation. anniversary, 80th year, ON THE EVE of the ceremonies, prayer, action becomes inconclusive and and the work of St. Charles Borromco, John received The encyclical, he said, will mark T’ope in audience the exterior concealing feast an superficiality, the 15th centenary of the death of whose day it was. diplomats assigned to the Holy See and Pope emptiness and sterility under a cloak of He noted that the cclchration was their Leo the Great on Nov. 11, and will center families, telling them that current fleeting successes. Without prayer, the his only a few days away from the 15th events have made the collaboration upon relation to the Church’s history. of real value of sacrifice is not under- The centenary of the death of Leo the Great, their governments with that of the Pope also used the occasion to Holy stood.” If Not .. -

UPS-QT04199.Pdf
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE QUITO CARRERA: TEOLOGÍA PASTORAL Tesis previa a la obtención del título de: LICENCIADO EN TEOLOGÍA PASTORAL TEMA: CREACIÓN DE UN BLOGGER VIRTUAL PARA LA FORMACIÓN INICIAL – PERMANENTE E INTEGRAL DE LA FRATERNIDAD LAICAL DOMINICANA DEL VICARIATO SANTA CATALINA DE SIENA – ECUADOR AUTOR: HÉCTOR DANIEL COELLO BURGOS DIRECTOR: RAÚL GONZÁLEZ Quito, junio del 2013 DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DE USO DEL TRABAJO DE GRADO Yo, Héctor Daniel Coello Burgos, autorizo a la Universidad Politécnica Salesiana la publicación total y parcial de este trabajo de grado y su reproducción sin fines de lucro. Además declaro que los conceptos desarrollados, análisis realizados y las conclusiones del presente trabajo, son de exclusiva responsabilidad del autor. Quito, junio del 2013 _______________________ Héctor Daniel Coello Burgos CC. 091796608-7 DEDICATORIA A Dios, Trino y Uno; a la Virgen María de la Santísima Trinidad, A la Fraternidad Laical Dominicana, al Vicariato General «Santa Catalina de Siena», a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y a toda persona de buena voluntad que le interese conocer sobre el contenido y dar buen uso a este trabajo. AGRADECIMIENTO A la Orden de Predicadores, a la Universidad Politécnica Salesiana, al P. Raúl González CSJ, a Mons. Francisco Luna OGF, y a todos aquellos que hicieron posible el desarrollo del presente trabajo. ÍNDICE INTRODUCCIÓN …………………………………………………………… 1 CAPÍTULO I PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS … 4 1.1 Comunicación y medios…………………………………………………… 4 1.2 Pastoral de la comunicación………………………………………………. 10 1.3 Nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la formación integral del ser humano………………………………………… 16 1.4 Los blogs y blogger, como herramienta de comunicación………….……… 24 CAPÍTULO II LA FORMACIÓN EN LA VIDA CONSAGRADA SECULAR …………… 27 2.1 Vida consagrada y formación……………………………………………... -
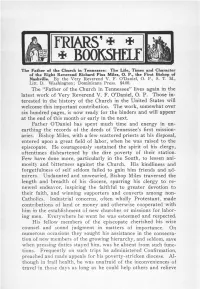
Friars' Bookshelf 217
'FRIARS~+ + j 4 BOOKSHflf The Father of the Church in Tennesaee: The Life, Times and Character of the Right Reverend Richard Pius Miles, 0. P., the First Bishop of Nashville. By the Very Reverend V. F. O'Daniel, 0. P., S. T. M., Litt. D. Washington; Dominicana Press. $4.00. The "Father of the Church in Tennessee" lives again in the latest work of Very Reverend V. F. O.'Daniel, 0. P. Those in terested in the history of the Church in the United States will welcome this important contribution. The work, somewhat over six hundred pages, is now ready for the binders and will appear at the end of this month or early in the next. Father O'Daniel has spent much time and energy in un earthing the records of the deeds of Tennessee's first mission aries. Bishop Miles, with a few scattered priests at his disposal, entered upon a great field of labor, when he was raised to the episcopate. He courageously sustained the spirit of his clergy, oftentimes disheartened by the dire poverty of their station. Few have done more, particularly in the South, to lessen ani mosity and bitterness against the Church. His kindliness and forgetfulness of self seldom failed to gain him friends and ad mirers. Undaunted and unwearied, Bishop Miles traversed the length and breadth of his diocese, spurring his clergy to re newed endeavor, inspiring the faithful to greater devotion t o their faith, and winning supporters and converts among non Catholics. Industrial concerns, often wholly Protestant, made contributions of land or money and otherwise cooperated with him in the establishment of new churches or missions for labor ing men. -

By Mr. Joseph Komadina, OP
Provincial Mission Statement COUNCIL DELEGATES ELECT NEW OFFICERS Called to a deeper relationship of love and service to God, From October 25th through October 28th, the Provincial Council met in we are members of the Dominican Order, who commit Chicago with the primary duty of electing new officers. With the guidance to live the Dominican charism as lay people. In of the Holy Spirit, and grounded in prayer, the Provincial Council elected collaboration with the Dominican Family, Mr. Joseph Komadina, O.P. our new President. The newly elected officers we work to promote social justice and peace in society. and their subsequent appointees are listed on this page. May we all be thankful for our past officers, including former Supported by prayer, study, community and President Karen Sabourin, and may we all pray diligently for our ministry, we fulfill our vocation to proclaim the new officers in the great tasks that lie before them. Gospel wherever we, as individuals, live and work. The news delivered by Council delegates about their chapters throughout the Province may be found in our St. Albert the Great Lay Dominican Executive Committee “News from around the Province” section on page 4. President: Mr. Joseph Komadina, O.P. The weekend was a great success, featuring reports from all our extra- ordinary missions throughout the Province of St. Albert the Great. Vice-President: Mr. Terry McSweeney, O.P. Treasurer: Mrs. Mary Lee Odders, O.P. Recording Secretary: Mrs. Cheryl Beckman, O.P. Past President: Ms. Karen Sabourin, O.P. Provincial Promoter: Rev. Rich Litzau, O.P. * * * * * * * Lay Dominican Inter-Provincial Council Reps DLIPC Delegate: Ms. -

Catalogo Libri Fondazione G&M Giarrizzo 1.Xlsx
Autore Titolo Collocazione Abate, Alberto. Alberto Abate. 040 GMG‐750‐ 000024 Da Quarto al Volturno : noterelle di uno dei Mille / Giuseppe Cesare Abba presentazione di Giovanni Spadolini con un saggio e il commentario Abba, Giuseppe Cesare, 1838‐1910. di Luigi Russo. 040 GMG‐945‐ 000324 Abbate, Vincenzo Palermo 1700 : i contatti con Bologna e la committenza del marchese di Regalmici / Vincenzo Abbate 040 GMG‐Misc.Abbate‐ 000001 Abbate, Vincenzo. La grande stagione del collezionismo : mecenati, accademie e mercato dell'arte nella Sicilia tra Cinque e Seicento / Vincenzo Abbate. 040 GMG‐700‐ 000020 Commercio, colonie e impero alla vigilia della Rivoluzione americana : John Campbell pubblicista e storico nell'Inghilterra del sec. XVIII / Guido Abbattista, Guido Abbattista 040 GMG‐942‐ 000024 Commercio, colonie e impero alla vigilia della Rivoluzione americana : John Campbell pubblicista e storico nell'Inghilterra del sec. XVIII / Guido Abbattista, Guido Abbattista 040 GMG‐337 000012 Abbattista, Guido James Mill e il problema indiano : gli intellettuali britannici e la conquista dell'India / Guido Abbattista 040 GMG‐941‐ 000010 Abbattista, Guido La rivoluzione americana / Guido Abbattista 040 GMG‐973‐ 000021 Abbattista, Guido La folie de la raison par alphabet : le origini settecentesche dell' Encyclopaedia Britannica / Guido Abbattista 040 GMG‐ Misc. Abbattista‐ 000010 Abbattista, Guido John Oldmixon, storico dell' impero britannico in America / Guido Abbattista 040 GMG‐ Misc. Abbattista‐ 000012 Abbattista, Guido Parlamento, partiti e ideologie politiche nell'Inghilterra del settecento : temi della storiografia inglese da Namier a Plumb / Guido Abbattista 040 GMG‐ Misc. Abbattista‐ 000014 Abbattista, Guido La prima volta dell'abate Raynal : l'Histoire du Stadhoudérat e il repubblicanesimo olandese / Guido Abbattista 040 GMG‐ Misc. -

Calendar of the Order of Preachers
Calendar of the Order of Preachers The General Calendar of the Order of Preachers and the Particular Calendar for the Use of Provinces, Monasteries and Congregations are combined below. Celebrations on the General Calendar of the Order are in bold type. The rank of feasts in the General Calendar are indicated as follows: S = Solemnity F = Feast M = Memorial (Obligatory) OM = Optional Memorial Four secondary titles have been used to indicate the place of particular saints and blesseds in the Order, i.e., friar, nun, sister and lay Dominican. Celebrations of the Roman Calendar with a particular reference to the Order, or for which we have particular texts, but with the same rank on both calendars, are enclosed in brackets. [ ] This calendar has been up-dated to conform to the Catalogus Hagiographicus (Rome: 2001) and the Additamenta ad Proprium Missalis et Liturgiæ Horarum (2006) JANUARY 3 Holy Name of Jesus Votive Mass and Office recommended (OM) 3 Bl. Stephana Quinzani, sister and virgin 4 St. Zedislava [Berkiana] of Lemberk, lay Dominican and Mother (M) 7 St. Raymond of Peñafort, friar, priest and Master of the Order (M) 10 Bl. Gonsalvo of Amarante, friar and priest Bl. Ann of the Angels Monteagudo, nun and virgin 11 Bl. Bernard Scammacca, friar and priest 15 St. Francis Fernandez de Capillis, priest, Peter Sans, bishop, and companions martyrs in China. (M) 18 St. Margaret of Hungary, nun and virgin (M) 19 Bl. Andrew Grego of Peschiera, friar and priest 22 Bl. Anthony della Chiesa, friar and priest 23 Bl. Henry Suso, friar and priest 27 Bl. -

St. Columbkille Church | 200 E. 6Th St., Papillion, NE 68046
Twenty-Ninth Sunday in Ordinary Time October 18th, 2020 The Saint Columbkille youth group, Teen Faith, gathered to celebrate the Feast of the Rosary on October 7th. St. Columbkille Church | 200 E. 6th St., Papillion, NE 68046 Public & Live streamed masses Reconciliation Monday-Thursday Monday-Thursday Saturday Public Mass: at 8:15 a.m. and 5:30 p.m. 5:00-5:20 p.m. 3:30-4:30 p.m. Live streamed at 8:15 a.m. on the St. Columbkille Parish YouTube channel and via the link to it at the top of our website. Friday: 6:20 a.m. and 8:15 a.m. Live streamed at 8:15 a.m. Mass, Homilists, intentions & Presiders Saturday: Communion Service, 8:15 a.m., Sunday Vigil Public Mass & Live streamed on parish YouTube channel at 5 p.m. Monday, October 19th Sunday 8:15 a.m. +Joshua Dubbs (Fr. Greisen) Public Masses at 7:30 a.m.*, 9 a.m. (masks required)*, 5:30 p.m. +George Rainbolt (Fr. Greisen) 10:30 a.m.* and noon Tuesday, October 20th *Beginning August 16th 8:15 a.m. +Arnold Kubischta (Fr. Greisen) 5:30 p.m. +Pat McNally (Fr. Greisen) St. Columbkille Parish Directory Wednesday, October 21st PRIESTS 8:15 a.m. +Emily Flakus (Fr. Greisen) FR. DAVE REESON, PASTOR 5:30 p.m. +Julia Chavez (Fr. Greisen) 402-339-3285 ext. 103 | [email protected] Thursday, October 22nd FR. TOM GREISEN, ASSOCIATE PASTOR 8:15 a.m. Anniv. Blessings-Bob & Andrea Fillaus 402-339-3285 ext. 106 | [email protected] (Fr.