Enzo Lippolis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Cult of Isis
Interpreting Early Hellenistic Religion PAPERS AND MONOGRAPHS OF THE FINNISH INSTITUTE AT ATHENS VOL. III Petra Pakkanen INTERPRETING EARL Y HELLENISTIC RELIGION A Study Based on the Mystery Cult of Demeter and the Cult of Isis HELSINKI 1996 © Petra Pakkanen and Suomen Ateenan-instituutin saatiO (Foundation of the Finnish Institute at Athens) 1996 ISSN 1237-2684 ISBN 951-95295-4-3 Printed in Greece by D. Layias - E. Souvatzidakis S.A., Athens 1996 Cover: Portrait of a priest of Isis (middle of the 2nd to middle of the 1st cent. BC). American School of Classical Studies at Athens: Agora Excavations. Inv. no. S333. Photograph Craig Mauzy. Sale: Bookstore Tiedekirja, Kirkkokatu 14, FIN-00170 Helsinki, Finland Contents Acknowledgements I. Introduction 1. Problems 1 2. Cults Studied 2 3. Geographical Confines 3 4. Sources and an Evaluation of Sources 5 11. Methodology 1. Methodological Approach to the History of Religions 13 2. Discussion of Tenninology 19 3. Method for Studying Religious and Social Change 20 Ill. The Cults of Demeter and Isis in Early Hellenistic Athens - Changes in Religion 1. General Overview of the Religious Situation in Athens During the Early Hellenistic Period: Typology of Religious Cults 23 2. Cult of Demeter: Eleusinian Great Mysteries 29 3. Cult of Isis 47 Table 1 64 IV. Problem of the Mysteries 1. Definition of the Tenn 'Mysteries' 65 2. Aspects of the Mysteries 68 3. Mysteries in Athens During the Early Hellenistic Period and a Comparison to Those of Rome in the Third Century AD 71 4. Emergence of the Mysteries ofIsis in Greece 78 Table 2 83 V. -
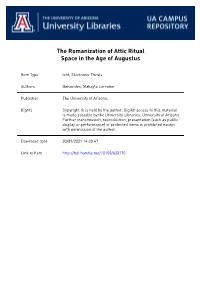
The Romanization of Attic Ritual Space in the Age of Augustus
The Romanization of Attic Ritual Space in the Age of Augustus Item Type text; Electronic Thesis Authors Benavides, Makayla Lorraine Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction, presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Download date 30/09/2021 14:30:47 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/633170 THE ROMANIZATION OF ATTIC RITUAL SPACE IN THE AGE OF AUGUSTUS by Makayla Benavides ____________________________ Copyright © Makayla Benavides 2019 A Thesis Submitted to the Faculty of the DEPARTMENT OF RELIGIOUS STUDIES AND CLASSICS In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of MASTER OF ARTS In the Graduate College THE UNIVERSITY OF ARIZONA 2019 1 7 THE UNIVERSITY OF ARIZONA GRADUATE COLLEGE As members of the Master's Committee, we certify that we have read the thesis prepared by Makayla Benavides titled The Romanizationof Attic Ritual Space in the Age ofAugustus and recommend that it be accepted as fulfillingthe dissertation requirement for the Master's Degree. Date: .r- / - :.?CJ/ 5f David Soren Date: S - I - 2..o I � Mary E Voyatzis David Gilman Romano Date: ----- [Committee Member Name} Final approval and acceptance of this thesis is contingent upon the candidate's submission of the final copies of the thesis to the Graduate College. I hereby certify that I have read this thesis prepared under my direction and recommend that it be accepted as fulfillingthe Master's requirement. -

Ceramic Production and Exchange in the Late Mycenaean Saronic Gulf
Ceramic Production and Exchange in the Late Mycenaean Saronic Gulf William D. Gilstrap A Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy Department of Archaeology University of Sheffield February 2015 Abstract This thesis examines the production, exchange and consumption of pottery around the Saronic Gulf, Greece, during Late Mycenaean period, specifically Late Helladic IIIB1 to Late Helladic IIIC Phase 1, roughly 1300-1130 BC. While the focus of many studies of Mycenaean political economy has fallen on Messinia and the Argolid, the choice of the Saronic Gulf offers the chance to examine ceramic crafting, movement and use in an area which hosts no accepted ‘palatial’ centres. It aims to examine the role of pottery in everyday social and economic transaction, taking a ‘bottom-up’ approach to shedding light on Mycenaean society and economy. Pottery from a wide range of sites has been studied: urban centres such as Athens; harbours at Kanakia on Salamis and Kalamianos in coastal Corinthia; small settlements of Stiri in Corinthia, Myti Kommeni on Dokos and Lazarides on Aegina; sanctuary sites of Eleusis and Ayios Konstantinos, Methana; and finally the settlement and pottery production site of Kontopigado, Alimos near the Attic coast. Based on typological and macroscopic fabric studies, a large number of samples have been chosen for examination by an integrated programme of petrographic, chemical (by neutron activation analysis) and microstructural analysis (by scanning electron microscopy), in order to group and characterise to pottery according to composition, to reconstruct key aspects of ceramic manufacture and, where possible, to suggest the area or location of their production. -

History of the Eleusinian Mysteries
Gregory Dickerson - April 17th, 1993 History of the Eleusinian Mysteries We often think of the imposing grandeur of the Parthenon on the Acropolis as embodying the highest sublimity of ancient Greek religion, but the unimposing, flat expanse of foundations now visible at Eleusis is the real holiest of holies in Ancient Greece. Most of the evidence for the initiation ceremonies there in honor of Demeter, the goddess of grain, is inferential, since no ancient writer revealed the secret. But the “Homeric” Hymn to Demeter, which tells the story of Hades carrying off Persephone to be his queen in the world of the dead and the wanderings of Demeter as she sought her lost daughter until she was finally restored (for part of the year) to the upper world, is taken as the Eleusinian foundation myth, upon which the ceremonies were modeled, especially details consequent upon Demeter’s coming to the palace at Eleusis, where she served as nursemaid for a time to the infant son, Demophoon, whom she was making immortal by putting him each night into the fire until interrupted by his frightened mother. “Happy is that one of mortal men who has seen these things…” Indeed, happiness in this life and in the next was the promise of the mysteries (secret initiation ceremonies). The prerequisites were simple enough: you had to have clean hands (no blood pollution), a pure heart and speak Greek. You could be male or female, native or foreigner, free or slave. The preliminaries included a purification in the Lesser Mysteries in Athens on the 20th of Anthesterion (about March 1st), which you could attend under the terms of a 55-day travel truce. -

PREFACE Tmsbookis Identical with None of the Earlier Works I Have Pub
PREFACE TmsBOOKis identical with none of the earlier works I have pub- lished on the same subject. Issued in a pocketbook series, the Dutch volume Eleusis: de heiligste mysterien van Griekenland was neces- sarily limited in length. Similar considerations led me to limit the scope of the German volume Die Mysterien von Eleusis. Even so, it contained more than an attempt at reconstruction. Unfortunately, it was already in print when G. E. Mylonas' book Eleusis and the Eleusin- ian Mysteries appeared. This publication for the first time made possible a complete survey of the results of excavations and a dis- cussion of their interpretation by archaeologists. It called for an en- largement of my book. Another difference followed from my conviction that the Eleusinian gods should be numbered among the "Archetypal Images." This point of view was stressed neither in the Dutch nor in the German volume, but is expressed in my earlier essay on the Divine Maiden. It is developed in the present work, which treats the problem of the Mysteries more fully, from the standpoint not only of Greek ex- istence—this was the central theme of the German version—but also of human nature. It is human nature, man as a whole, in his concrete reality, that is sometimes helped by outward means to achieve an inner light. Such a means at Eleusis was fasting. In addition to hunger, there was another undeniable condition for the accomplishment of the Mysteries, which may be termed the pharmaceutical preparation for them: the drinking of the kykeon. My investigations have now been extended in this direction, which was not considered in the previous versions. -

The Athenian Empire
Week 8: The Athenian Empire Lecture 13, The Delian League, Key Words Aeschylus’ Persians Plataea Mycale Second Ionian Revolt Samos Chios Lesbos Leotychidas Xanthippus Sestos Panhellenism Medizers Corinth Common Oaths Common Freedom Asia Minor Themistocles Pausanias Dorcis Hegemony by Invitation Aristides Uliades of Samos Byzantium Hybris Delos Ionia Hellespont Caria Thrace NATO UN Phoros Hellenotamias Synod Local Autonomy 1 Lecture 14, From League to Empire, Key Words Eion Strymon Scyros Dolopians Cleruchy Carystus Naxos Eurymedon Caria Lycia Thasos Ennea Hodoi Indemnity Diodorus Thucydides Athenian Imperial Democracy Tribute Lists Garrisons 2 Chronological Table for the Pentekontaetia 479-431 481/0 Hellenic League, a standard offensive and defensive alliance (symmachia), formed with 31 members under Spartan leadership. 480/79 Persian War; battles under Spartan leadership: Thermopylae (King Leonidas), Artemesium and Salamis (Eurybiades), Plataea (Pausanias), and Mycale (King Leotychides). 479 Thank-offerings dedicated at Delphi for victory over Persia including serpent column listing 31 cities faithful to “the Hellenes”. Samos, Chios, and Lesbos, and other islanders enrolled in the Hellenic League. Sparta, alarmed by the growth of Athenian power and daring, send envoys to urge the Athenians not to rebuild their walls, but Themistocles rejects the idea and tricks the envoys; Athenians rebuild walls using old statues as ‘fill’, while Themistocles is on diplomatic mission to Sparta. Following the departure of Leotychides and the Peloponnesian contingents, Xanthippus and the Athenians cross over to Sestos on the European side of the Hellespont, lay siege to the town, and capture the Persian fortress. Themistocles persuades the Athenians to complete fortifications at Piraeus, begun in 492; while Cimon promotes cooperation with Sparta, Themistocles hostile to the hegemon of the Peloponnesian and Hellenic leagues; attempts to rouse anti-Spartan feelings. -

Athens' Peacetime Navy in the Age of Perikles Eddy, Samuel K Greek, Roman and Byzantine Studies; Summer 1968; 9, 2; Proquest Pg
Athens' Peacetime Navy in the Age of Perikles Eddy, Samuel K Greek, Roman and Byzantine Studies; Summer 1968; 9, 2; ProQuest pg. 141 Athens' Peacetime Navy in the Age of Perikles Samuel K. Eddy N THE eleventh and twelfth chapters of his biography of Perikles, I Plutarch gives some details of the policies developed by the Athenian statesman to relieve the plight of the poor of Athens. Some men, he says, were sent as settlers to the newly-created klerou chies in the empire. Others, both skilled and unskilled workmen, were employed in constructing the great monuments rising on the Akropolis and in other parts of Attika. Perikles also, Plutarch says, (11.4), caused sixty triremes to be manned and equipped for eight months of each year for the purposes of giving pay to the crews and of training them for war. I shall undertake to show that this number is wrong and that it should be emended to sixteen. I wish also to discuss how the sixteen ships may have been used and what implica tions such a standing navy has for our understanding of the financial history of Athens. There is no reason to doubt that the essential point in Plutarch's statement is correct, that is, that the Athenian demos did receive naval training. The contemporary Old Oligarch says they did (1.20) and Thucydides makes Perikles say the same thing (1.142.7-9). Training was necessary both for the steersmen and for the simple oarsmen, who had to row in strict unison while seated in close quarters on board ship.1 Learning to row at the different speeds ordered by the keleustai, handling the long, heavy oars while changing from <Call ahead" to Hall astern," and bringing all the oars on one side rapidly inboard to practice the side-swiping tactic sometimes used against an enemy-all this required a certain skill which only practice could give. -

Rosicrucian Digest Vol 87 No 2 2009 Eleusis
Each issue of the Rosicrucian Digest provides members and all interested readers with a compendium of materials regarding the ongoing flow of the Rosicrucian Timeline. The articles, historical excerpts, art, and literature included in this Digest span the ages, and are not only interesting in themselves, but also seek to provide a lasting reference shelf to stimulate continuing study of all of those factors which make up Rosicrucian history and thought. Therefore, we present classical background, historical development, and modern reflections on each of our subjects, using the many forms of primary sources, reflective commentaries, the arts, creative fiction, and poetry. This magazine is dedicated• to all the women and men throughout the ages who have contributed to and perpetuated the wisdom of the Rosicrucian, Western esoteric, tradition. May we ever be •worthy of the light with which we have been entrusted. In this issue, we explore• the Eleusinian Mysteries which were celebrated outside Athens for 2,000 years. Combining the mysteries of life, death, fertility, immortality, transcendence, and divine union, they were the very soul of Hellenistic civilization. Today we can glimpse their glory, still calling to us across the millennia. No. 2 - 2009 Vol. 87 - No. 2 Peter Kingsley, Ph.D. “Paths of the Ancient Sages: A Pythagorean History” Giulia Minicuci and Mary Jones, S.R.C. “Pythagoras the Teacher: From Samos to Metapontum” What We Can Learn about 2 RutOfficialh Phelps, S.R.C.Magazine “The Schoolof the of Pythagoras”the Eleusinian Mysteries AnonymousWorldwide “The Golden Verses of Pythagoras”George Mylonas, Ph.D. AntoineRosicrucian Fabre d’Olivet, Order “Excerpt fromDe mExaminationeter and Persephone of the Golden Verses” 7 Hugh McCague, Ph.D., F.R.C. -

Athens, Augustus, and the Settlement of 21 B.C
Athens, Augustus, and the Settlement of 21 B.C. Schmalz, Geoffrey C R Greek, Roman and Byzantine Studies; Winter 1996; 37, 4; ProQuest pg. 381 Athens, Augustus, and the Settlement of 21 B.C. Geoffrey C. R. Schmalz N RECENT YEARS much has been made of the 'bad blood' be tween Athens and Augustus, es ecially in the context of I the controversial imperial visit of 21 B.C. The Athenian so journ of Augustus, the second of three, is known from the rather full, if problematic, account in Cassius Dio (54.7.1-4). Over thirty years ago G. W. Bowersock adduced a supplemen tal source in Plutarch's Regum et Imperatorum Apophtheg mata (M or. 207E- F).l This passage purports to preserve a letter addressed to the Athenians by Augustus and is construed as evi dence for a winter stay on Aegina at the time. Thus taken to gether, these two sources are the basis for much of the present understanding of the early relationship between Augustus and his Athenian subjects.2 What follows here is a re-evaluation from several different per spectives of the imperial visit of 21 B.C. Through a closer reading of Dio and Plutarch, a review of the history of the period, and finally a consideration of the epigraphic evidence from Athens, several new conclusions will be drawn. First, it will become evident that Dio's account of the imperial visit cannot be placed in the winter of 21 B.C. but belongs rather to the following summer or perhaps even the fall. -
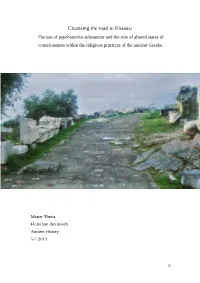
The Sanctuary at Eleusis Is One of the Most Ancient and Important Sanctuaries of the Ancient Greek World
Cleansing the road to Eleusis: The use of psychoactive substances and the role of altered states of consciousness within the religious practices of the ancient Greeks. Master Thesis Floris van den Bosch Ancient History 5-7-2013 0 Contents Introduction 02 I: The modern examples 08 The Peyote rituals of Mesoamerica 09 Banisteriopsis use in the Amazonian rainforest 10 Psilocybin mushrooms in the rituals of northern Latin-America 13 The Amanita Muscaria use in the tribal religions of Siberia 13 Kava-rituals on the islands of the Pacific 14 Other ways to an Altered state of Consciousness 15 II: The Psychology of altered states of consciousness 17 Tart’s system’s approach 17 Defining altered states of consciousness and their religious interpretation 19 Tart’s stabilizing factors and inducement procedures 20 Different methods for inducing ASC’s 21 ASC’s and mystical experiences 25 III: Ancient Greek Religion 28 Gods and men 29 Knowing about the gods 31 Voluntary contact with the Gods 32 The Mother Goddess 32 Dionysos 36 Other mysteries 39 In General 40 Spontaneous contact with the Gods 42 IV: Eleusis 46 The Homeric hymn to Demeter 46 Day-to-day description 48 What we know about the ritual 50 The accounts 50 The Building 50 Stages of initiation 51 Theories by modern scholars 53 The ‘Road to Eleusis-theory’ 55 My own considerations 58 Concluding remarks 62 Bibliography 66 1 Introduction The sanctuary at Eleusis was one of the oldest and most important sanctuaries of the ancient Greek world. Cultural activity has been attested at Eleusis during the Bronze age and continuing into the Mycenaean age. -

Greek Mysteries
GREEK MYSTERIES Mystery cults represent the spiritual attempts of the ancient Greeks to deal with their mortality. As these cults had to do with the individual’s inner self, privacy was paramount and was secured by an initiation ceremony, a personal ritual that estab- lished a close bond between the individual and the gods. Once initiated, the indi- vidual was liberated from the fear of death by sharing the eternal truth, known only to the immortals. Because of the oath of silence taken by the initiates, a thick veil of secrecy covers those cults and archaeology has become our main tool in deciphering their meaning. In a field where archaeological research constantly brings new data to light, this volume provides a close analysis of the most recent discoveries, as well as a critical re-evaluation of the older evidence. The book focuses not only on the major cults of Eleusis and Samothrace, but also on the lesser-known Mysteries in various parts of Greece, over a period of almost two thousand years, from the Late Bronze Age to the Roman Imperial period. In our mechanized and technology-oriented world, a book on Greek spirituality is both timely and appropriate. The authors’ inter-disciplinary approach extends beyond the archaeological evidence to cover the textual and iconographic sources and provides a better understanding of the history and rituals of those cults. Written by an international team of acknowledged experts, Greek Mysteries is an important contribution to our understanding of Greek religion and society. Michael B. Cosmopoulos is the Hellenic Government–Karakas Foundation Profes- sor of Greek Studies and Professor of Greek Archaeology at the University of Missouri-St. -
The Road to Eleusis: Unveiling the Secret of the Mysteries
THE ROAD TO ELEUSIS Unveiling the Secret of the Mysteries R. Gordon Wasson Albert Hofmann Carl A. P. Ruck To Richard Evans Schultes, Ph.D., M.H. (Hon.) Pioneer Explorer of Psychotropic Plants in the New World Holder of the Paul C. Mangelsdorf Chair in the Natural Sciences Director and Curator of Economic Botany Botanical Museum of Harvard University F by R. Gordon Wasson.............................................................................................. I. T W R E (...)................................................................................... II. A C Q M A (..) ................................................................. III. S T E M (....).......................................................................... IV. A D ...................................................................................................................... V. T H H D.......................................................................................... VI. D (....) (Chapter V included in alternate translation from the Loeb Edition. Chapter VI not included.) F o much has been written about the Eleusinian SMysteries and for so long a time that a word is needed to justify this presentation of three papers dealing with them. For close to , years the Mystery was performed every year (except one) for carefully screened initiates in our month of Septem- ber. Everyone speaking the Greek language was free to present himself, except only those who had the unexpiated blood of a murdered man on their hands. The initiates lived through the night in the telesterion of Eleusis, under the leadership of the two hierophantic families, the Eumolpids and the Kerykes, and they would come away all wonder- struck by what they had lived through: according to some, they were never the same as before. The tes- timony about that night of awe-inspiring experience is unanimous and Sophocles speaks for the initiates when he says: Thrice happy are those of mortals, who having seen those rites depart for Hades; for to them alone is granted to have a true life there.