13. Antabia Q6 I
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Raiders of the Lost Ark
Swiss American Historical Society Review Volume 56 Number 1 Article 12 2020 Full Issue Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/sahs_review Part of the European History Commons, and the European Languages and Societies Commons Recommended Citation (2020) "Full Issue," Swiss American Historical Society Review: Vol. 56 : No. 1 , Article 12. Available at: https://scholarsarchive.byu.edu/sahs_review/vol56/iss1/12 This Full Issue is brought to you for free and open access by BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in Swiss American Historical Society Review by an authorized editor of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact [email protected], [email protected]. et al.: Full Issue Swiss A1nerican Historical Society REVIEW Volu1ne 56, No. 1 February 2020 Published by BYU ScholarsArchive, 2020 1 Swiss American Historical Society Review, Vol. 56 [2020], No. 1, Art. 12 SAHS REVIEW Volume 56, Number 1 February 2020 C O N T E N T S I. Articles Ernest Brog: Bringing Swiss Cheese to Star Valley, Wyoming . 1 Alexandra Carlile, Adam Callister, and Quinn Galbraith The History of a Cemetery: An Italian Swiss Cultural Essay . 13 Plinio Martini and translated by Richard Hacken Raiders of the Lost Ark . 21 Dwight Page Militant Switzerland vs. Switzerland, Island of Peace . 41 Alex Winiger Niklaus Leuenberger: Predating Gandhi in 1653? Concerning the Vindication of the Insurgents in the Swiss Peasant War . 64 Hans Leuenberger Canton Ticino and the Italian Swiss Immigration to California . 94 Tony Quinn A History of the Swiss in California . 115 Richard Hacken II. Reports Fifty-Sixth SAHS Annual Meeting Reports . -

Transumanza Ok
Sentieri di pietra Robièi La Val Bavona... e la transumanza Val Bavona... und die Transhumanz Da segnalare Sehenswert 1 Bignasco, alla confluenza A nord-ovest di Cavergno si apre la Val Bavona, tra dirupi altissimi e i resti di Nordwestlich von Cavergno öffnet sich das U-förmige Val Bavona, das eine A Foroglio: il trittico di legno del 1557 nell’oratorio e la casa-torre a monte del In Foroglio, ein Trittiko im Oratorium von 1557 aus geschnitztem und bemal- della Lavizzara e della Bavona frane colossali, che le valsero il primato di valle più ripida e sassosa dell’Arco Fläche von 122 km2 bedeckt, wovon 70% unproduktives Land sind. Der Rück- villaggio, che propone un’interpretazione moderna di un’antica tipologia edili- tem Holz. Bergwärts befindet sich eine moderne Interpretation eines Turmhauses. La Valmaggia copre un quinto della superficie del Canton Ticino; dalle gole di Alpino. Col ritiro dei ghiacciai, venendo a mancare la pressione contro i versanti, gang der Gletscher hatte zur Folge, dass loses Material von den steilen Wänden zia presente in valle. Am Weg von Foroglio nach Rosèd, in der Nähe einer kleine Kapelle aus dem Ponte Brolla alle cime del Cristallina e del Basòdino essa presenta uno sviluppo La Val Bavona... tutte le parti instabili rovinarono a valle: rocce, macigni e pietre sono ovunque zu Tal stürzte und ausgedehnte Steinwüsten bildete. Geröll, Felsbrocken und Stei- lineare di una cinquantina di km ed un dislivello di 3000 m. Il suo tratto iniziale, Lungo il sentiero tra Foroglio e Rosèd, nei pressi di una cappellina datata 1812, Jahre 1812, ist ein grosser Felsblock. -

62.334 Bignasco - Peccia - Fusio Stato: 11
ANNO D'ORARIO 2021 62.334 Bignasco - Peccia - Fusio Stato: 11. Novembre 2020 Lunedì–venerdì dal 14.12.–2.4. salvo i giorni festivi generali salvo 6.1., 19.3. nonché 2.4 . 803 807 811 813 817 821 825 Locarno, Stazione part. 07 05 09 05 11 05 13 05 15 05 17 05 18 35 Bignasco, Posta arr. 07 53 09 53 11 53 13 53 15 53 17 53 19 23 Bignasco, Posta 07 55 10 00 12 00 14 00 16 00 18 00 19 30 Cavergno, Paese 07 57 10 02 12 02 14 02 16 02 18 02 19 32 Brontallo, Bivio 08 01 10 06 12 06 14 06 16 06 18 06 19 36 Brontallo, Paese 08 05 10 10 12 10 16 10 18 10 19 40 Menzonio, Sentiero 08 09 10 14 12 14 14 07 16 14 18 14 19 44 Menzonio, Bivio 08 12 10 17 12 17 14 10 16 17 18 17 19 47 Menzonio, Paese 08 15 10 20 12 20 16 20 18 20 19 50 Broglio, Paese 08 21 10 26 12 26 14 13 16 26 18 26 19 56 Prato, Ponte 08 25 10 30 12 30 14 17 16 30 18 30 20 00 Peccia, Paese 08 29 10 34 12 34 14 21 16 34 18 34 20 04 Mogno, Paese 08 40 10 45 12 45 14 32 16 45 Fusio, Paese 08 45 10 50 12 50 14 37 16 50 62.334 Fusio - Peccia - Bignasco Stato: 11. -

Flyer Sentiero Lavizzara
8 Fusio Sentiero Fusio Lavizzara Per percorsi escursionistici e alpini: Mappa topografica della Vallemaggia 1: 50’000 Für Alpin- oder Bergwanderungen: Topographische Karte des Maggiatals 1:50’000 Valle 8 di Peccia 11 Valle di Peccia 10 9 7 Informazioni più dettagliate si trovano sui prospetti ottenibili presso: Weitere Informationen finden Sie in den Prospekten erhältlich bei: Piano di Peccia Vallemaggia Turismo, Maggia, tel. 091 753 18 85, www.vallemaggia.ch Valle Valle Sornico - Peccia Cancelleria comunale Lavizzara, Prato Sornico, di Peccia di Peccia tel. 091 755 14 21, www.lavizzara.ch Infopoint, Bignasco, tel. 091 760 76 76, www.infopointvm.ch Negozio Artis, Cevio, Mogno tel. 091 754 18 16, www.artisvallemaggia.ch Infopoint Regione Sambuco, Fusio, 9 tel. 079 272 81 23, [email protected] [email protected] [email protected] www.pietraviva.ch Catto 1324 Passo Varenzo dei Sassi 973 2554 Rif. Garzonera P. di Mezzodì SAT 2003 Pne. di Vespero 2653 Fiesso 2717 P. di Sassello 979 2480 Valle Leventina Campanile 2741 Alpe Campo la Torba Rodi Madone Passo Sassello 957 2756 2334 Prato 1039 P. Folcra Passo Alpe Sassello Pne. di Tremorgio Pne. Sambuco 2669 2662 del Naret P. Scheggia 2581 P. Massari 2438 Alpe Bolla 2559 Regione 2760 Cristallina Sambuco Lago Lago Naret Tremorgio 2310 1827 Passo Vanit 2138 Val Sambuco P. della Sassada Alpe Scheggia 2710 Passo del Sasso Nero 2420 P. Sciresa Cap. Leit Alpe Massari 2257 P. del lago Scuro 2326 Lago Passo 2648 Sambuco Alpe Pianascio Campolungo Pne. dei Laghetti 1461 2318 2616 Cristallina 2912 Alpe della Bolla Alpe Sciresa P. -

20. Pero E Poma Q6 F
A chacun son eau Oubliez la hâte lors de cette excursion, du moins dans sa partie initiale, pour admirer à loisir, au gré de la montée, Bosco/Gurin et ses maisons, ses étables et la verdure qui l’entoure, créant des espaces unis par une harmonieuse géométrie tonale entre la pierre ciselée et le bois équarri. Une verdure qui varie de saison en saison, mais aussi de minute en mi- nute et se montre, selon que la lumière l’inonde ou qu’elle en jaillit, tour à tour éclatante (on croirait presque sentir une odeur de peinture) ou délicate (elle paraît alors se déchirer au premier soue de vent qui vient l’eeurer pour laisser entrevoir, ça et là, la chair obscure de la terre). L’itinéraire nous fait quitter les prairies, avancer parmi les aulnes et les Lacs alpins de la Suisse italienne conifères qui s’écartent pour nous permettre de revoir Bosco, lequel imite parfois d’autres villages ou au contraire concentre son unicité, orant une image insolite pour notre plaisir et notre souvenir sans recourir à la Pero et Poma 20 technique et aux artices du pittoresque. Puis les arbres s’eacent pour laisser apparaître la montagne, là derrière, comme si elle vous attendait: une rencontre qui élève d’un coup le niveau du parcours et, tout aussi soudainement, ouvre le paysage, lui donnant une ampleur qui explique le choix de l’excursion et donne la sensation de s’être perdu avec bonheur. Nous trouvons, ensuite, jouant le rôle de panneau indicateur, le Corte di Dentro au Wolfstael, un nom qui conviendrait davantage à un conte qu’à cet endroit, rendu inoensif par l’abandon. -
Legenda Percorso Valle Maggia
w Numeri utili • Nützliche Nummern • Numéros utiles • Useful numbers Cycling routes Ambulanza, emergenze – Sanitätsnotruf, Krankenwagen Ospedale La Carità ascona-locarno.com/bike 144 Ambulance, appel dʼurgence – Ambulance emergency call Pronto Soccorso +41 (0)91 811 41 11 REGA Guardia aerea di soccorso Clinica S. Chiara 1414 Rettungsflugwacht – Garde aérienne de sauvetage – Air-Rescue Pronto Soccorso +41 (0)91 756 41 11 /Including Incluso/Inklusive/Inclus Polizia – Polizei – Police – Police Soccorso stradale – Pannenhilf 117 Poliza cantonale +41 (0)91 816 10 11 140 Dépannage routier – Road assistance orso Polizia comunale Locarno +41 (0)91 756 33 11 Perc Vallemaggia Pompieri – Feuerwehr – Pompiers – Fire Brigade Previsioni meteo – Wetterbericht 118 Centrale Locarno +41 (0)91 756 33 41 162 Météo – Weather forecast Bike Hotels– Relax, sport & divertimento 145 Intossicazione – Vergiftungen – Intoxication – Intoxication Informazioni – Auskünfte 1811 Renseignements – Information your ideal base Erholung, Sport und Spass ascona-locarno.com/bikehotels Détente, sport et loisirs Relaxation, sport & fun Ascona-Locarno Tourism [email protected] Lido Locarno Tel +41 (0) 91 759 90 00 Tel. +41 (0)848 091 091 www.ascona-locarno.com facebook.com/lidolocarno Via Respini 11 [email protected] instagram.com/lidolocarno CH–6601 Locarno www.lidolocarno.ch 20 Proposte di itinerari ciclabili 20 Propositions d'itinéraires cyclables Percorso 1 Percorso 6 Percorso 11 Percorso 16 Locarno – Bignasco Locarno – Forcola di Dunzio Valle Cannobina Locarno – Bellinzona Paesaggi mozzafiato, un clima mite e temperato, itinerari pianeggianti o salite con oltre Des paysages à couper le souffle, un climat doux et tempéré, des itinéraires au plat ou Lunghezza: 31,2 km Dislivello: 351 m Lunghezza: 19,8 km Dislivello: 477 m Lunghezza: 68 km Dislivello: 905 m Lunghezza: 22 km Dislivello: 105 m il 20% di dislivello, 2'300 ore di sole all’anno. -

Centro Ricreativo-Turistico Di Bignasco: Piscina E Area Di Sosta Turistica
COMUNE DI CEVIO Studio di fattibilità (modello imprenditoriale e businessplan) per il Centro ricreativo-turistico di Bignasco: piscina e area di sosta turistica Rapporto intermedio dopo la fase di elaborazione 1 Versione del 15 giugno 2012 Sonneggstrasse 30 CH-8006 Zürich Telefon: +41 (0)44 252 11 33 Fax: +41 (0)44 252 11 36 [email protected] www.flury-giuliani.ch IMPRESSUM Incarico attribuito dal Municipio di Cevio Coordinazione del progetto Giovanni Do, municipale a Cevio, Gianluca Giuliani, Flury&Giuliani GmbH Gruppo d’accompagnamento (in ordine alfabetico) Gabriele Bianchi, ERS-LVM Giovanni Do, municipale, capodicastero Patrizio Fenini Siro Quadri Graziano Sarra Dusca Schindler Coordinazione per la stesura del rapporto Gianluca Giuliani Flury&Giuliani GmbH Sonneggstrasse 30 CH-8006 Zürich Telefon: +41 (0)44 252 11 34 Fax: +41 (0)44 252 11 36 [email protected] www.flury-giuliani.ch Foto in copertina Via alta Vallemaggia; foto: Vallemaggia Turismo Management Summary Il presente rapporto preliminare, redatto su incarico del Municipio di Cevio lancia una riflessione a tutto campo sul futuro della struttura balneare di Bignasco e sull’utilizzo e sfruttamento della zona sportiva contigua. L’obiettivo della prima fase dello studio è stato quello di allestire un quadro generale, complessivo, del potenziale di sviluppo economico dato dall’area in cui attualmente sorge la piscina di Bignasco e dall’area circostante (Centro ricreativo-turistico di Bigna- sco). La preoccupazione è stata quella di riconoscere tutte le varianti immaginabili e di dotare la riflessione di una base d’analisi solida e completa. Nella prima fase di studio si sono definite tre (possibili) “componenti principali” dell’idea di progetto: • La piscina (aperta e coperta); • La cascata e l’area adiacente; • L’area di sosta turistica. -
Maggia Valley
euwareness switzerland Case Study 1: Maggia Valley Adèle Thorens and Corine Mauch Case Study 1: Maggia Valley Adèle Thorens Corine Mauch April 2002 Institut de Hautes Études en Administration Publique (IDHEAP) Route de la Maladière 21 CH-1022 Chavannes-près-Renens (Lausanne) Switzerland Tel: +41.21.694.0640 Fax: +41.21.694.0609 Website: www.unil.ch/idheap/index.htm Email: [email protected]; [email protected]; [email protected] EUWARENESS is a research project on European Water Regimes and the Notion of a Sustainable Status. Research institutes from six European countries (Netherlands, Belgium, France, Spain, Italy, Switzerland) have been cooperating in this two year project (2000-2002). More information is available on www.euwareness.nl. The project is supported by the European Commission under the 5th Framework Programme, and co-ordinated by the University of Twente in the Netherlands. 1 TABLE OF CONTENTS Table of contents ........................................................................................................................ 2 1. General description of the water basin................................................................................... 3 1.1 Geographical and hydrological aspects............................................................................ 3 1.2 WATER USES INVOLVED ........................................................................................... 3 Hydroelectric production................................................................................................... -
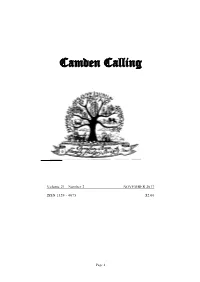
Camden Calling
Camden Calling Volume 21 Number 2 NOVEMBER 2017 ISSN 1329 - 4075 $2.00 Page 1 OFFICE BEARERS August 2017 — July 2018 President: Ray Herbert Vice- President: Barbara Sulley Secretary: Cathey Shepherd Minute Secretary Pat Patterson Treasurer: Barbara Sulley Library Coordinator: Tony Jackson Editor: Warren Sims Assistant Editor: Anne McIntosh Research Officer: Fred Gibson Assistant Research Officers: Margaret Wheeler Dawn Williams Public Officer: Rex Dowle Membership: Beverley Booth Social Secretary: To Be Advised Committee Members: Neil Patterson Dawn Williams Lee Stratton Honorary Accountant Mr. Jim Hunter Address all enquiries to: The Secretary Camden Area Family History Society Inc. P.O. Box 679 Camden. NSW. 2570. Australia. Or email: [email protected] Normal Membership Subscriptions: Single A$30.00 Couples A$35.00 Pensioner/Concession Membership Subscription: Single A$25.00 Couples A$30.00 WEBSITE www.cafhs.org.au RESEARCH FEES Non- members use of Resources- $10.00 per session. Written enquires $30.00 — provides up to fifteen printed or photocopied pages. A4 size stamped addressed envelope to be included with your enquiry. RESEARCH CENTRE Family History Room Camden Library/Museum Complex. John Street. Camden. NSW 2570 Thursday 10.00am— 3.00pm Friday 10:00am — 3 . 0 0 p m Saturday 9:30am— 12 noon (Closed late December to late January) ANNUAL GENERAL MEETING The Annual General Meeting of the Camden Area Family History Society Inc. is held on the first Tuesday of August each year, immediately following the general meeting. The Society meets on the first Tuesday of each month (except January) at 7.30pm in the Community Meeting Room of the Camden Library/Museum Complex 40 JOHN STREET CAMDEN. -

Impa. Museo Cevio Iniziali
tra le Costruivano senza metro e senza disegno, ma nel solco di una tradizione antica e sicura. Plinio Martini Questa pubblicazione Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica e la ricerca a cui fa capo Repubblica e Cantone Ticino sono state possibili (Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport; grazie al contributo finanziario di: Dipartimento del territorio; Dipartimento delle finanze e dell’economia) Vallemaggia pietraviva Fondazione Valle Bavona Raiffeisen Cavergno-Cevio Raiffeisen Maggia e Valli Officine Idroelettriche della Maggia Vallemaggia Turismo © 2004 Museo di Valmaggia, Cevio Ogni riproduzione di testi, fotografie e disegni è vietata senza autorizzazione ISBN: 88-8281-152-2 Armando Dadò editore CH-6601 Locarno, via Orelli 29, www.editore.ch MUSEO DI VALMAGGIA tra le costruzioni sottoroccia splüi grondàn cantìn Armando Dadò editore Impressum Direzione della ricerca e Bruno Donati coordinamento editoriale Rendiconto al Fondo nazionale Flavio Zappa svizzero per la ricerca scientifica (FNSRS) Gruppo redazionale Marco Bianconi, Renzo Dalessi, Augusto Gaggioni, Romano Guglielmoni, Armando Losa, Giuseppe Martini, Lara Pedrazzi, Sergio Ravani Approfondimenti Massimo Centini, Philippe Curdy, Francesco Fedele, Alessandro Gamboni, Catherine Leuzinger-Piccand, Urs Leuzinger, Armando Losa, Giuseppe Martini, Werner Meyer, Michele Moretti, Nicola Oppizzi, Stefania Rigotti, Martin Schindler, Norbert Spichtig, Fosco Spinedi, Claudio Valsangiacomo, Mario Vicari, Flavio Zanini, Flavio Zappa Inventario Marco Bianconi, Renzo -

Bignasco... E La Lüèra Bignasco
Sentieri di pietra Bignasco... e la lüèra Bignasco... und die Wolfsfalle 1 I macigni 6 La lüèra Sono almeno tre le particolarità storiche che caratterizzano questo villaggio. Unter den mindestens drei Merkmalen, welche dieses Dorf charakterisieren, ste- Il Piodau (da pioda, lastra di sasso) è la fascia rocciosa È un manufatto imponente. Una superficie di oltre 100 mq Innanzitutto i ponti. Posto alla confluenza di due fiumi, Bavona e Maggia, i due hen die Brücken an erster Stelle: Am Zusammenfluss der beiden Flüsse Bavona che sovrasta l'entrata sud di Bignasco: da qui, in epoca è chiusa tra una parete rocciosa, un monolite enorme e due ponti di collegamento fra le diverse sponde esistono da secoli, forse da millenni. und Maggia gelegen, bestehen die beiden Verbindungsbrücken zwischen den preistorica, si sono staccati macigni colossali che hanno 2 robusti muri a secco: quello a sud supera all'esterno i sette Bignasco... Vi è poi il nucleo più antico (Bignasc Vécc) situato sulla sponda sinistra del fiume verschiedenen Ufern seit Jahrhunderten wenn nicht Jahrtausenden. Es folgt der sconquassato tutto il versante. Uno di questi, che sembra metri di altezza. Non vi sono aperture, ad eccezione di un Maggia: è anch’esso un unicum, poiché è l’agglomerato valmaggese che conta am linken Ufer der Maggia liegende älteste Ortskern «Bignasc Vécc», einmalig posato in precario equilibrio sul ciclopico monolito a ridosso piccolo passaggio attraverso il quale, attirato da un'esca il maggior numero di case cinquecentesche. da es sich dabei um die Siedlung des Maggiatals mit den meisten Häusern aus della carrozzabile, è facilmente accessibile ed offre una viva, entrava il predatore, facendo scattare un meccanismo Si è scelto ...la lüèra, ossia la trappola per catturare i lupi, poiché è un manu- dem 16. -

Brontallo-Menzonio
Sentieri di pietra Brontallo... e le stalle Brontallo... und die Ställe 1 Le stalle 4 Il castagneto 6 I vigneti Chi sale da Bignasco verso la valle Lavizzara non può che rimanere affascinato Wer von Bignasco in Richtung Lavizzaratal fährt, erblickt voll Faszination dieses Brontallo stupisce anche per l’ordine urbanistico, frutto di Nell’ambito dello stesso Progetto è pure stata ripristinata Nonostante ci si trovi a oltre 700 metri sul mare, qui la vi- da quel paesino aggrappato a metà montagna, proprio all’entrata della Valle, e kleine, direkt am Taleingang auf halber Höhe am Berghang klebende Dorf und un‘accurata lettura e rispetto del territorio: le case vecchie una vecchia selva castanile terrazzata con la potatura dei te americana fruttifica ancora bene. dal poggio, appena più in alto, contro il cielo, dove è situato Margonegia, uno die etwas weiter oben gelegene Anhöhe mit Margonegia, einem der schönsten tutte raggruppate attorno alla Gesina nel luogo più sicuro, castagni, la pulizia del sottobosco e la ricostruzione dei La si faceva arrampicare sui tetti delle stalle e delle case Brontallo... dei monti più belli della Valmaggia. Maiensässe des Maggiatals. gli orti e i campi sull’unico spazio pianeggiante e nel pendìo muri pericolanti. per sfruttare il calore della pietra e veniva anche coltivata Ma pure l’arrivo a Brontallo, a 716 m s.m., rappresenta un susseguirsi di scoperte Doch auch die Ankunft in Brontallo selbst auf 716 m ü. M. bietet eine Reihe von più soleggiato davanti al nucleo («In campagna»), le case La si raggiunge scendendo lungo il sentiero che fino a sui terrazzamenti.