Poggiolo La Storia Millenaria Di Una Piccola Comunità
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
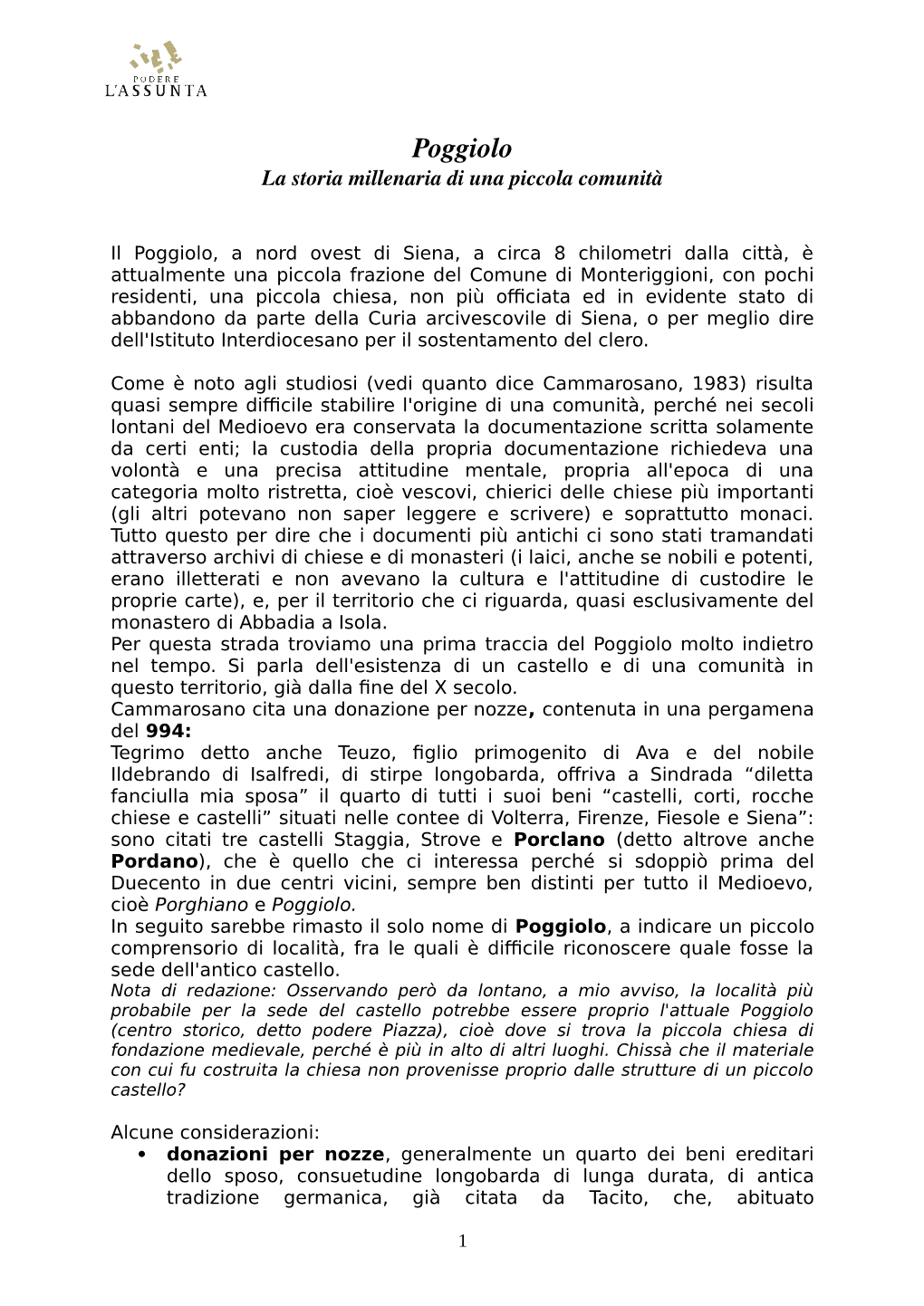
Load more
Recommended publications
-

SIENA Alelargoro En
SUGGESTED ROUTE FROM SIENA TO RADICONDOLI map downloaded from www.radiconventosservanza.it or From Siena follow the signposts for the dual www.ethoikos.it cariageway Siena-Firenze towards Firenze and stay Graphic design by Alessandro Belli and on this route until you reach the exit for Roberto Cozzolino Monteriggioni. Here turn left and follow the road for about 50 metres when you will come to a junction ©2002-2004 all rights reserve with a bar on your right. Take the right turn towards Colle di Val d’Elsa and proceed for just over 1 Km where you will take a left turn sign-posted to Abbadia Isola–Strove. Follow on this road until you Poggibonsi reach the SP541 route where you will turn sharp left over a bridge sign-posted to Grosseto. Stay on this road for about 10 km until you reach a right turn towards Radicondoli. You will recognise this turning as it is soon after a small petrol station also on your right. Follow the direction for Radicondoli which you SP 541 SS 2 will reach after about 13 km. Siena-Firenze Colle SP 5 Val D’Elsa MONTERIGGIONI exit Siena-Firenze SP 74 To w ards To w ards COLLE GROSSETO VAL D’ELSA Badesse SS 2 To w ards ABBADIA ISOLA- SP 541 STROVE SIENA Mensano Fuel station Pievescola SS 326 SP 541 Sovicille SP 3 To w ards SP 73 RADICONDOLI SS 2 Rosia SP 35 SP 3 SS 223 RADICONDOLI To w ards Chiusdino, Roccastrada How to get to the Convent Once you reach the village, past the Post Office, follow the road down to your left which is sign-posted to Castelnuovo Val di Cecina do not head for the town centre). -

Comune Di Monteriggioni (1815-1864)
Archivio preunitario (1815-1864) ARCHIVIO PREUNITARIO COMUNE DI MONTERIGGIONI (1815-1864) 414-416 Registri delle deliberazioni 1862 giu. 12-1865 giu. 8 Due reg. legg. in mezzaperg. di cc. n.n. 414 1862 giu. 12-1864 apr. 5 416 1864 mag. 23-1865 giu. 8 415 1864 apr. 5-1865 giu. 8, copia per il cancelliere 417 Repertorio degli affari amministrativi 1852-1860 Reg. legg. in cartoncino di cc. n.n. 418 Repertorio dell’Arruolamento militare 1852-1860 Reg. legg. in cartoncino di cc. n.n. 419 Repertorio delle lettere del cancelliere 1861-1865 Reg. legg. in cartoncino di cc. n.n. 420 Carteggio 1859-1872 421 Ministeriali 1816-1825 Reg. legg. in cartoncino di cc. n.n. 422-423 Bilanci preventivi 1859-1860 Due reg. legg. in cartoncino di cc. n.n. 422 1859 423 1860 424-425 Registri dei mandati 1859-1860 Due reg. legg. in cartoncino di cc. n.n. 424 1859 425 1860 426-427 Repertori delle assegnazioni 1859-1860 Due reg. legg. in cartoncino di cc. n.n. 426 1859 427 1860 1 Archivio preunitario (1815-1864) 428-429 Conti consuntivi 1859-1860 Due reg. legg. in cartoncino di cc. n.n. 428 1859 429 1860 430-431 Allegati ai consuntivi 1959-1860 430 1859 431 1860 432 Stati delle anime 1862-1863 2 Archivio postunitario 1865-1906 ARCHIVIO POSTUNITARIO COMUNE DI MONTERIGGIONI (1865-1906) I. Deliberazioni del Consiglio 1-6 Deliberazioni del Consiglio 1865 ago. 10-1912 feb. 1 Sei regg. legg. in cartoncino di cc. n.n. 1 1865 ago. 10-1869 ott. -

ELENCO ACCOMPAGNATORI TURISTICI DI SIENA COGNOME NOME INDIRIZZO PROV. Alekseyenko Iryna Via Uopini, 10 Monteriggioni SI Alfieri
ELENCO ACCOMPAGNATORI TURISTICI DI SIENA CITTA' COGNOME NOME INDIRIZZO (di Residenza) PROV. Alekseyenko Iryna Via Uopini, 10 Monteriggioni SI Alfieri Veronica Via Umberto I°, 5 Piancastagnaio SI Alicia Andrea Loc. Monti 89 Gaiole in Chianti. SI Ambrosio Filomena Via Elia Mazzei, 34 Castelnuovo B.ga SI Amerighi Laura Montevarchi SI Angeli Pierluigi Via G. di Vittorio, 9 Chianciano Terme SI Angeletti Daniela Via Oslavia,105 Chiusi SI Ardenghi Daniela Via di Fontanella,21 Siena SI Aurigi Ilaria Via Alfieri, 23/B Castelnuovo B.ga SI Avanzati Alessandra Via Chianacce, 20 Montepulciano SI Azzalin Gianluca Piazza Nagj, 2 Poggibonsi SI Bacci Renato Via G..Matteotti 53 Volterra SI Baglioni Serena S.S. 146 Sud, 14 Montepulciano SI Baglioni Denise Loc. Terranera di Sotto, 172/A Subbiano (AR) Baiocchi Lisa Via Trento,48 Abbadia S.Salvatore SI Baldini Rita Via dello Spuntone, 2 Colle di Val D'Elsa SI Bandini Gaia Loc.Il Casalone Colle Val d'Elsa SI Bani Gloria Loc. Pancole, 19/A San Gimignano SI Baragli Viviana Località Sant'Andrea, 10 San Gimignano SI Barbagli Lisa Strada di Colle Pinzuto,52 Siena SI Barbetti Stefania Via Roma,2 Siena SI Barbetti Tiziana P.zza del Mercato 48 Siena SI Barbieri Gabriella Via dei Pispini,55 Siena SI Bardelli Federica Via Traversa Valdichiana Ovest , 62 Torrita di Siena SI Bardelli Sara Via Abruzzi, 20 Siena SI Bardelli Annalisa Via Leccetello, 53 Trequanda SI Bartalini Duccio P.zza G.Amendola.6 Siena SI Bartoli Francesca Via E.Fermi,14 Sinalunga SI Bassanelli Elisa Via Gallerani, 19 Siena SI Bastreghi Elena Via Lauretana Ovest, 1 Montepulciano SI Batelli Barbara Loc. -

Enoproject Srl Consulenza Viticola Enologica Franco Bernabei Matteo Bernabei Viale Vittorio Veneto, 66 50022 Greve in Chianti (F
Enoproject Srl Consulenza Viticola Enologica Franco Bernabei Matteo Bernabei Viale Vittorio Veneto, 66 50022 Greve in Chianti (FI) Telefono 055853693 – 055853831 Email: Franco Bernabei: [email protected] Matteo Bernabei: [email protected] ENOPROJECT S.R.L. – A SOCIO UNICO – VIALE VITTORIO VENETO, 66 – 50022 – GREVE IN CHIANTI (FI) –TEL.055–853693/853831– FAX 055–8544472– E-MAIL: [email protected] –C.F./P.IVA 02578790285 SEDE LEGALE: VIALE DELLE TERME, 123 – 35031 ABANO TERME (PD) – TRIBUNALE PADOVA – N. 16495 REG. ORD. – N. 43086 SOC. – N. 48374 VOL. – C.C.I.A.A . RD . PD. N. 245776 CAP. SOC. EURO 10400,00 ENOPROJECT S.R.L. Franco Bernabei Making wine vineyard to vineyard, winery to winery: so one can follow the productive history of each winery. The many trips to France with visits to both small wineries to major Château had made it clear to Franco Bernabei the importance of “terroir” and how to grow the vines. Freelance wine maker since 1978 and then in 1993 Franco Bernabei and his wife Daniela founded ENOPROJECT, a wine making consulting company based in Greve in Chianti. Currently there are about thirty Italian wineries under the Enoproject wing. Ten people are currently working in Enoproject, amongst them his son Matteo, a graduate in Viticulture and Enology. His wife Daniela follows the administration and coordination of the office. 2 ENOPROJECT S.R.L. – A SOCIO UNICO – VIALE VITTORIO VENETO, 66 – 50022 – GREVE IN CHIANTI (FI) –TEL.055–853693/853831– FAX 055–8544472– E-MAIL: [email protected] –C.F./P.IVA 02578790285 SEDE LEGALE: VIALE DELLE TERME, 123 – 35031 ABANO TERME (PD) – TRIBUNALE PADOVA – N. -

Azienda Usl Toscana Sud Est Locazioni E Comodati Al 31/12/2016
30/12/2016 AZIENDA USL TOSCANA SUD EST LOCAZIONI E COMODATI AL 31/12/2016 AREA ARETINA - LOCAZIONI PASSIVE Denominazione-attività Indirizzo Comune Locatore Scadenza Canone 2016 prevalente RSA Ninci Loc. Mugliano,208 Arezzo Fraternita dei Laici 31/12/2007 € 21.950,87 Alloggio Sanitario Socio-Riab. a bassa Via Malpighi, 12/4 Arezzo Arezzo Casa case popolari senza scadenza € 2.177,11 intensità assistenziale Alloggio Sanitario Socio-Riab. a bassa Villaggio Colombo, 1 Arezzo Arezzo Casa case popolari senza scadenza € 3.653,22 intensità assistenziale Alloggio Sanitario Socio-Riab. a bassa Via Montale, 44 Arezzo Arezzo Casa case popolari senza scadenza € 3.428,18 intensità assistenziale Alloggio Sanitario Socio-Riab. a bassa Villaggio Gattolino, 11 Arezzo Arezzo Casa case popolari senza scadenza € 4.015,92 intensità assistenziale Alloggio Sanitario Socio-Riab. a bassa Piazza Andromeda, 54 Arezzo Arezzo Casa case popolari senza scadenza € 2.353,37 intensità assistenziale Alloggio Sanitario Socio-Riab. a bassa Via Libia, 1/3 Arezzo Arezzo Casa case popolari senza scadenza € 4.098,10 intensità assistenziale Centro Diurno Via La Nave, 6/H Bibbiena sig.ri T.M. e T.I. 30/11/2017 € 8.469,48 Casa Famiglia di Camucia Via Aldo Capitini/piazzale Europa n. 12 Camucia di Cortona Sig. F. F. 28/02/2018 € 5.760,00 28/02/2014 prorogato e in corso di Centro Socio Sanitario Cortona Vicolo Mancini, 4 Cortona Misericordia di Cortona € 18.000,00 rinnovo Centro Socio Sanitario di Mercatale Via Mazzini Mercatale Sigg. B.A. - B.M. e B.Z. 31/08/2018 € 7.948,08 31/12/2020 senza ulteriore rinnovo delib Residenza Protetta DSM Via Boccaccio, 3 Montevarchi Comune di Montevarchi € 67.653,28 DG nr. -

Guida-Inventario Dell'archivio Di Stato
MINIS TERO PER I BENI CULTURALI E AM BIENTALI PU B BLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO XCII ARCHIVIO DI STATO DI SIENA GUIDA-INVENTARIO DELL'ARCHIVIO DI STATO VOLUME TERZO ROMA 1977 SOMMARIO Pag. Prefazione VII Archivio Notarile l Vicariati 77 Feudi 93 Archivi privati 105 Bandini Policarpo 106 Bologna-Buonsignori-Placidi 108 Borghesi 140 Brancadori 111 Brichieri-Colombi 113 Busacca Raffaele 115 Canonica (la) 116 Nerazzini Cesare 118 Pannocchieschi-D'Elci 120 Petrucci 140 Piccolomini-Clementini 123 Piccolomini-Clementini-Adami 128 Piccolomini-Naldi-Bandini 131 Piccolomini (Consorteria) 134 Sergardi-Biringucci 137 Spannocchi 141 Tolomei 143 Useppi 146 Venturi-Gallerani 148 Particolari 151 Famiglie senesi 152 Famiglie forestiere 161 PR EFAZIONE Nella introduzione al primo volume della guida-inventario dell'Archivio di Stato di Siena furono esposti gli intenti con i quali ci si accinse alla pub blicazione di quell'importante mezzo di corredo che consistevano nel valorizzare il materiale documentario di ciascun fo ndo archivistico per facilitare agli stu diosi la via della ricerca storica. Il caloroso e benevolo accoglimento riservato dagli interessati dice chiaramente quanto fe lice sia stata l'iniziativa e quanto brillanti siano stati i risultati raggiunti, che si sono palesati anche maggiori di quelli previsti. Infa tti la valorizzazione del materiale, oltre all'ordinamento ed alla inventariazione degli atti, presupponeva anche lo studio accurato delle ori gini e delle competenze dell'ufficio o dell'ente che quegli atti aveva prodotto. Per cui, essendo stati illustrati nei primi due volumi 1 ottanta fondi appartenenti alle più importanti magistrature dello Stato, insieme alla storia di ogni singolo ufficio è emersa in breve sintesi anche la storia del popolo senese. -

Create by Pagemanager
Numero Unico delle Scuole di MONTERIGGIONI IL SALUTO DEL SINDACO L'attività di comunicazione sta assu mendo sempre più un ruolo di fon damentale importanza nello svilup po dei nostri rapporti sociali. Farsi conoscere e far conoscere le proprie idee, le proprie attività, costi tuisce un importantissimo segnale di coscienza civica ed esaita la voglia e le capacità di confrontarsi democraticamente e liberamente al fine di rimuovere i vari ostacoli ad una capacità di rapporti che diviene ogni giorno sempre più problemati ca. Rivolgo pertanto un plauso ai nostri alunni, agli insegnanti ed alle auto rità didattiche che hanno voluto e realizzato questa iniziativa, che sicuramente costituisce fin da ora un preciso contributo al migliora mento del messaggio educativo ed istituzionale degli alunni delle scuole di Monteriggioni. Il Sindaco Paolo Casprini SOMMARIO II Giornalino, perché, per chi... * Una storia antica 2 L'idea del giornalino secondo me è ...per far conoscere noi e la nostra ...per comunicare le cose di tutti i stata una buona cosa, sia per noi scuola, quello che facciamo. giorni e per far divertire le persone che per gli altri. Sono d'accordo a Martina Baccani 5A S.Martino che io leggono. • Abbadia Pisola 3 continuare questo giornalino perché Angela Fantappiè 5B S.Martino anche i più timidi o quelli più silen ...perché vogliamo provare ad esse • Tanti castelli 4 ziosi , che si vergognano di tutto, re dei veri giornalisti. Se passate per Monteriggioni Antonella Pappalardo comprate il nostro giornalino, 5A S.Martino costa poco ed è carino! • Una miriade di cento .... .5 Questo è utile per aiutarli ad espri mersi e per invitarli ad una comuni E'interessante e divertente, ...per ricordare ai bambini che ver compratelo pure, brava gente! • Un Comune, ma dov'è? 6 cazione più diretta. -

Stefano Romani
F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome STEFANO ROMANI Residenza Via Martelli 14, 53021, Abbadia San Salvatore (SI) Domicilio Via Nerucci 15, 58033, Castel del Piano (GR) Telefono 328 6961507 Fax 0577 222011 E-mail [email protected] [email protected] Nazionalità Italiana Data di nascita 09.03.1978 Sesso M ESPERIENZA LAVORATIVA • Date (da – a) 2007 - oggi • Nome e indirizzo del datore di GEOSOL S.R.L. – Viale Europa 31, 53100 Siena lavoro • Tipo di azienda o settore Società di geologia • Tipo di impiego Collaboratore geologo, tecnico di cantiere • Principali mansioni e responsabilità Indagini geologiche e geotecniche nel settore geologico-tecnico, ambientale, stradale, estrattivo ed urbanistico, recupero di frane e aree degradate, studi idrogeologici ed idraulici, opere di miglioramento fondiario etc. Tecnico per indagini georadar, monitoraggi inclinometrici, videoispezioni pozzi e cavità, monitoraggi e prove di portata su pozzi con piezometri digitali, rilievi topografici e geomorfologici con GPS, campionamento terre e rocce da scavo, monitoraggio quadro fessurativo edifici con crepemetri, fessurimetri ed estensimetri. Assistenza tecnica di cantiere per esecuzione indagini geotecniche e geofisiche in situ. Tecnico CAD e GIS. • Principali lavori svolti Consulenza professionale ed assistenza di cantiere a supporto dei seguenti progetti SETTORE GEOLOGICO TECNICO 2018 – BORGO SAN FELICE S.R.L. – Castelnuovo Berardenga Indagine geognostica per restauro fabbricato “Curia” – San Felice – -

Comunicato Eccellenza
ATTIVITA’ CALCIO UISP SIENA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 Comunicato 18 del 12/02/2019 ECCELLENZA ASD PADOVANI 1990 - G.S. PIEVESCOLA 1 - 0 SAN GIMIGNANO SPORT - G.S. VICO D' ELSA ASD 0 - 1 SP.1972 MOBILI SACCHINI - CAMPIGLIA BONA OSTERIA 2 - 1 S. UOPINI QUERCEGROSSA - G.S. AMATORI ANCAIANO 0 - 1 FOMENTA ASD F.C. - A.C. SINALUNGA 1 - 1 USAP ASD ELE.MAC. - G.A.SAN ROCCO 1 - 2 CRAL MPS - POL.STAGGIA 53038 0 - 2 Disciplina Ammoniti: Andrea Beligni, Niccolo' Grotti (A.C. SINALUNGA); Luigi Esposito, Federico Bartalini (ASD PADOVANI 1990); Francesco Cadinu, Francesco Nicoletti (CRAL MPS); Davide Bosco (G.A.SAN ROCCO); Francesco Manganelli (G.S. AMATORI ANCAIANO); Richard Nidiaci (G.S. VICO D' ELSA ASD); Abdoulaye Ndiaye (POL.STAGGIA 53038); Mattia Capresi (S. UOPINI QUERCEGROSSA); Gianmarco Guazzini (SAN GIMIGNANO SPORT); Alberto Landi (SP.1972 MOBILI SACCHINI); Stefano Pucci, Ayoub El Azhari (USAP ASD ELE.MAC.). Diffide: Paolo Zara (A.C. SINALUNGA); Giovanni Evacuo (ASD PADOVANI 1990); Roberto Floris (CRAL MPS); Stefano Fantozzi (G.A.SAN ROCCO); Massimo Galgani, Andrea Poli, Alberto Ticci (G.S. PIEVESCOLA); Ibrahim Fofana (POL.STAGGIA 53038); Danilo Silvestrini (S. UOPINI QUERCEGROSSA); Tommaso Panichi, Riccardo Gelli (SAN GIMIGNANO SPORT); Mattia Fedi (USAP ASD ELE.MAC.). Una giornata: Neki Dyrmishi ART 215 R.T.N., Luigi La Salvia ART 215 R.T.N. (A.C. SINALUNGA); Francesco Giuntini ART 217 R.T.N., Vincenzo D'angelo (Tessera 190186945) ART 216 R.T.N. (ASD PADOVANI 1990); Alessio Spinelli ART 215 R.T.N., Francesco Giacomazzo ART 215 R.T.N. (CAMPIGLIA BONA OSTERIA); Antonio Silvestri ART 215 R.T.N., Michele Ciofi ART 223 R.T.N., Paolo De Falco ART 217 R.T.N. -

Orari E Percorsi Della Linea Bus
Orari e mappe della linea bus S35 S35 Piazza Gramsci Visualizza In Una Pagina Web La linea bus S35 (Piazza Gramsci) ha 2 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Piazza Gramsci: 06:20 - 17:25 (2) Quercegrossa: 06:55 - 20:15 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus S35 più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus S35 Direzione: Piazza Gramsci Orari della linea bus S35 29 fermate Orari di partenza verso Piazza Gramsci: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 06:20 - 17:25 martedì 06:20 - 17:25 Quercegrossa mercoledì 06:20 - 17:25 Bivio Calamandei Via Piero Calamandrei, Monteriggioni giovedì 06:20 - 17:25 Argianino venerdì 06:20 - 17:25 sabato 06:20 - 20:30 Macialla domenica Non in servizio Maciallina Santo Stefano La Ripuccia Informazioni sulla linea bus S35 Direzione: Piazza Gramsci Bivio Basciano Fermate: 29 Durata del tragitto: 25 min La Ripa La linea in sintesi: Quercegrossa, Bivio Calamandei, Argianino, Macialla, Maciallina, Santo Stefano, La Via Chiantigiana, Monteriggioni Ripuccia, Bivio Basciano, La Ripa, Chiantigiana 10, Chiantigiana 10 Bivio Vignaglia, Colombaio, Chiantigiana Rinfusola, Montarioso, Rotatoria Montarioso, Hotel Anna, Fontebecci, Lo Stellino, Torre Fiorentina, Via Bivio Vignaglia Fiorentina, Palazzo Diavoli, Bivio Montebello, Cavour, Antiporto Camollia, Porta Camollia, Montluc, Colombaio Montluc, Fratelli Cadorna, Piazza Gramsci Via delle Regioni, Castelnuovo Berardenga Chiantigiana Rinfusola Montarioso Rotatoria Montarioso Via Chiantigiana, Belverde Hotel Anna Via Chiantigiana, -

Monte Reggioni, Monte Riggioni, Monteriggioni
Dizionario Geografico, Fisico e Storico della Toscana (E. Repetti) http://193.205.4.99/repetti/ Monte Reggioni, Monte Riggioni, Monteriggioni ID: 3135 N. scheda: 34260 Volume: 3; 6S Pagina: 500 - 504; 159 - 160 ______________________________________Riferimenti: Toponimo IGM: Monteriggioni Comune: MONTERIGGIONI Provincia: SI Quadrante IGM: 113-2 Coordinate (long., lat.) Gauss Boaga: 1680109, 4806534 WGS 1984: 11.22463, 43.39162 ______________________________________ UTM (32N): 680172, 4806708 Denominazione: Monte Reggioni, Monte Riggioni, Monteriggioni Popolo: S. Maria Assunta a Monteriggioni Piviere: S. Maria Assunta a Monteriggioni Comunità: Monteriggioni Giurisdizione: Sovicille in Rosia Diocesi: Siena Compartimento: Siena Stato: Granducato di Toscana ______________________________________ MONTE REGGIONI, o MONTE RIGGIONI ( Mons Regionis ) in Val d'Elsa . Castello murato che sebbene quasi deserto presta tuttora il nome ad una comunità e ad una chiesa plebana (S. Maria Assunta) capo luogo di vicarìa foranea, nella Giurisdizione e circa dieci miglia a settentrione della potesteria di Sovicille in Rosia, Diocesi e Compartimento di Siena. Risiede sopra un'umile collinetta isolata presso la strada Regia romana che gli passa sotto dal lato di ponente-libeccio, fra il grado 28° 53' di longitudine e il grado 43° 23' 7" di latitudine, 6 miglia a maestro di Siena, altrettante a scirocco-levante di Colle, 8 miglia a scirocco di Poggibonsi, e 12 a libeccio di Radda. Dell'origine di Monte Reggioni, al pari che dell'etimologia del suo nome, non vi sono dati che possano dirsi meno che congetturali, come per esempio sarebbe uno quello di dubitare che questo paese fosse stato dai Sanesi edificato munito a guardia della loro regione occidentale . Nè tampoco è da credere che l'epoca di Montereggioni sia quella segnata in una lapida stata posta nel 1213 sopra una Page 1/6 Dizionario Geografico, Fisico e Storico della Toscana (E. -
Tu8 Tu22 Tu7 Tu9 Tu23 Regolamento Urbanistico
LEGENDA Perimetro dei Centri Abitati ai sensi della L.R. 1/05 (art. 26) Aggiornamento dell’edificato Tessuti storici (art. 27) Edifici di interesse storico-tipologico classificati nelle schede allegate al P.S. (art. 15) Tessuti consolidati omogenei/eterogenei (art. 29) COMUNE RI n° Aree di riqualificazione e/o integrazione dei tessuti esistenti (art. 30) DI TU n° Aree di trasformazione urbanistica (art. 31) MONTERIGGIONI IP Interventi puntuali a destinazione residenziale (art. 32) Provincia di Siena Aree produttive artigianali e/o industriali di completamento (art. 33) REGOLAMENTO DE n° Aree produttive artigianali e/o industriali di espansione (art. 33) URBANISTICO DRI Aree produttive artigianali e/o industriali soggette a prescrizioni particolari per rischio idraulico (art. 33) (approvato con atto del C.C. Aree per attività commerciali, direzionali e attrezzature (art. 34) del 14/7/2006, n. 47) ME n° Aree per attività commerciali, direzionali e attrezzature di previsione (art. 34) Aree per attività turistico-ricettive (art.35) RE n° Aree per attività turistico-ricettive di previsione (art. 35) Aree pubbliche per attrezzature e servizi (art. 36): attrezzature scolastiche ’sc’ esistenti ’SC’ di previsione; attrezzature di interesse comune ’c’ esistenti ’C’ di previsione; municipio ’am’; Quadro d’unione chiese e opere parrocchiali ’ch’ esistenti ’CH’ di previsione; cimitero ’cm’ esistente ’CM’ di previsione; impianti tecnologici ’t’ esistenti ’T’ di previsione Attrezzature private di interesse collettivo (art. 37): Sedi di associazioni culturali, ricreative, religiose ’ac’ esistenti; Nuovo Centro di Castellina Scalo ’CB’ di previsione; Clinica Rugani in località Colombaio Variante urbanistica ai sensi della L. R. n. 1 del 5 gennaio 2005 ’cl’ esistente; Centro Servizi della Diocesi di Siena in località Montarioso ’CS’ di previsione; Centro STATO DI PROGETTO sociale e ricreativo di Badesse ’CX’ di previsione; Area per i trasporti e la logistica a Badesse ’L’ di previsione; Laboratorio di ricerca ’lr’ esistente.