Stvdi Medievali
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
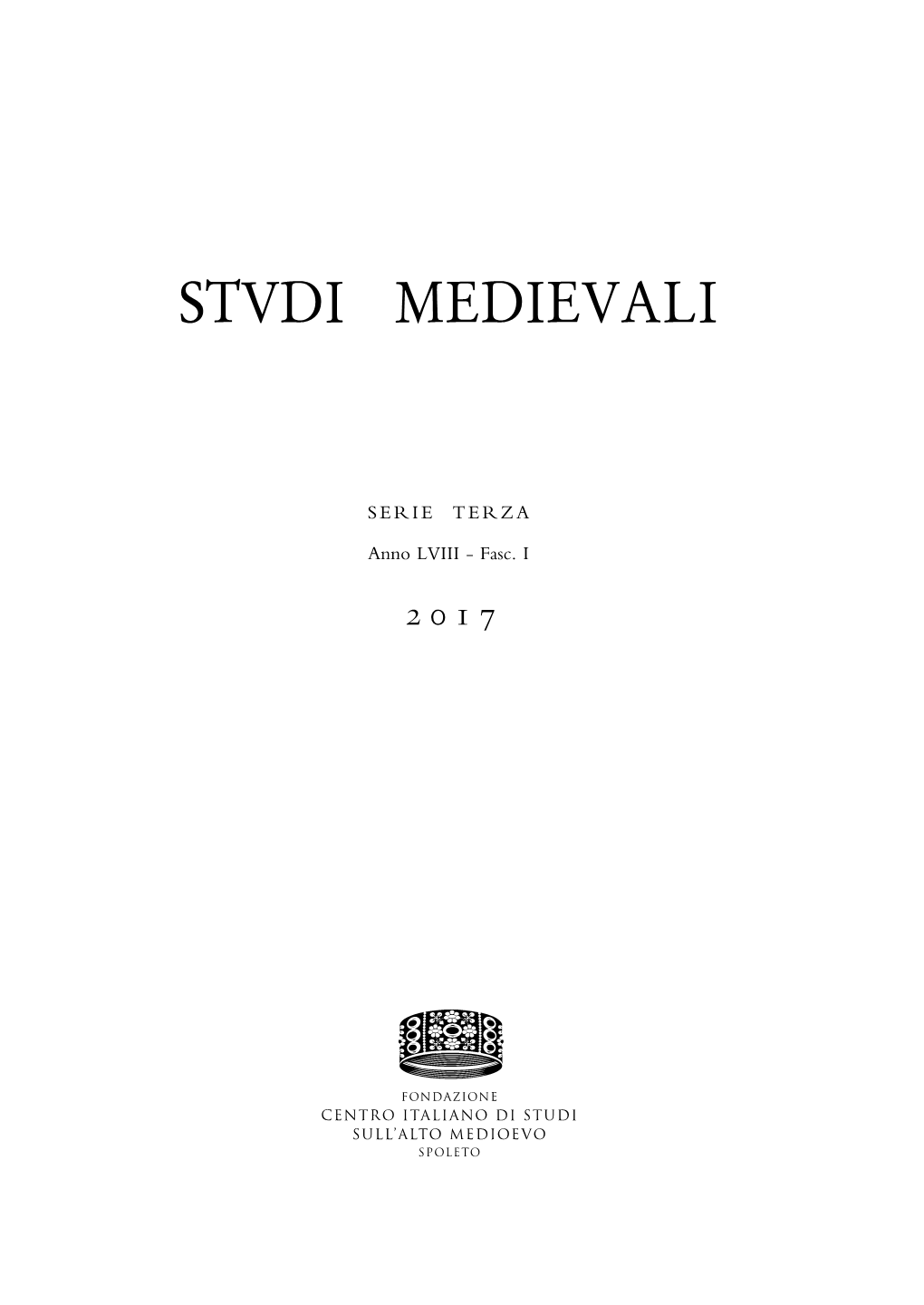
Load more
Recommended publications
-

Reflective Intercultural Education for Democratic Culture and Engaged Citizens
Reflective Intercultural Education for Democratic Culture and Engaged Citizens Reflective Intercultural Education for Democratic Culture and Engaged Citizens By Fiora Biagi and Lavinia Bracci Reflective Intercultural Education for Democratic Culture and Engaged Citizens By Fiora Biagi and Lavinia Bracci This book first published 2020 Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2020 by Fiora Biagi and Lavinia Bracci All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-5275-5515-1 ISBN (13): 978-1-5275-5515-0 TABLE OF CONTENTS Acknowledgements .................................................................................... vii Introduction .............................................................................................. viii Hospitality and Liquid Borders 1. Hospitality: ancient and postmodern paradigms 2. A journey into knowledge: from the clerici vagantes to contemporary study abroad 3. Liquid culture 4. EUFICCS 5. How this book is structured Chapter 1 ..................................................................................................... 1 EUFICCS Philosophy and Methodology: Pedagogical and Didactic Background 1.1 -

This Dissertation Has Been 64—6945 Microfilmed Exactly As Received PEARCY, Roy James, 1931-HUMOR in the FABLIAUX
This dissertation has been 64—6945 microfilmed exactly as received PEARCY, Roy James, 1931- HUMOR IN THE FABLIAUX. The Ohio State University, Ph.D., 1963 Language and Literature, general University Microfilms, Inc., Ann Arbor, Michigan Copyright by Roy James Pearcy 1° 6A HUMOR IN THE FABLIAUX DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Roy James Pearcy, B.A,(Hons.) ****** The Ohio State University 1963 Approved by J-. Adviser Department of English ACKNOWLEDGMENTS I would like to express my gratitude to Professor Francis L. Utley, who directed this dissertation, for his gracious and willing assistance, and for his sus taining and helpful interest throughout the progress of the work. Thanks are also due to Professor Morton W. Bloomfield, now at Harvard, who helped me prepare for the General Examination, and to Professor Robert M. Estrich, the chairman of my department, for aid and counsel in matters too many and varied to enumerate. I am also much indebted to The Graduate School of The Ohio State University for financial assistance afforded me in the form of a University Fellowship from January to June 1962, and Summer Fellowships in I960 and 1963. ii CONTENTS Page AC ENOWLEDGMENTS i i Chapter I INTRODUCTION..................................... 1 II RELATION OF PLOT AND COMIC ELEMENTS IN THE FABLIAUX................................. 38 III THE INTRODUCTION:SATIRE IN THE FABLIAUX........ 61 IV THE CORE:HUMOR IN THE FABLIAUX................. 98 V THE CONCLUSION: IRONY IN THE FABLIAUX.......... 127 VI HUMOR AND DICTION IN THE FABLIAUX............. 148 VII CHAUCER'S FABLIAU-TALES....................... -

El Claustro Y El Mundo : Miradas Comparativas Sobre La Poesía Medieval Latina Y Vernácula
Disalvo, Santigo Aníbal El claustro y el mundo : Miradas comparativas sobre la poesía medieval latina y vernácula Seminario - Programa 2014 Documento disponible para su consulta y descarga en Memoria Académica, repositorio institucional de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE) de la Universidad Nacional de La Plata. Gestionado por Bibhuma, biblioteca de la FaHCE. Para más información consulte los sitios: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar http://www.bibhuma.fahce.unlp.edu.ar Esta obra está bajo licencia 2.5 de Creative Commons Argentina. Atribución-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 Universidad Nacional de La Plata Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Secretaría de Posgrado Seminario Posgrado EL CLAUSTRO Y EL MUNDO: MIRADAS COMPARATIVAS SOBRE LA POESÍA MEDIEVAL LATINA Y VERNÁCULA Año lectivo: 2014 Régimen de cursada: Cuatrimestral (primer cuatrimestre) Profesor a cargo: Santiago Disalvo (Adjunto Interino, cátedra Literatura Española I) Carga horaria: 30 horas 1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS La historia de cultura occidental está atravesada por rasgos que se gestaron en aquella forma de civilización surgida en Europa y el mundo mediterráneo, a partir de la base romana cristiana, durante los siglos medievales. Uno de los factores internos más importantes que favoreció el desarrollo material, social, intelectual y espiritual de la cultura europea, desde el inicio de la Edad Media, fue el fenómeno del monacato en sus múltiples formas. En gran medida, los conceptos mismos de “persona”, “trabajo”, “cultura”, tal como los entendió la civilización occidental posterior, o la noción de la transmisión y el carácter misionario de dicha civilización (Dawson, 1995, 1997), hasta llegar a aspectos de materialidad tan cotidiana como la división horaria de la jornada o la cultura del libro, son, en gran medida, herencia de aquella “ola civilizadora” que tomó su impulso en los monasterios medievales. -

"The University in the Middle Ages: on the Invention of a New Use of Reason." Experiments in Decolonizing the University: Towards an Ecology of Study
Schildermans, Hans. "The University in the Middle Ages: On the Invention of a New Use of Reason." Experiments in Decolonizing the University: Towards an Ecology of Study. London,: Bloomsbury Academic, 2021. 29–46. Bloomsbury Collections. Web. 26 Sep. 2021. <http:// dx.doi.org/10.5040/9781350149854.ch-002>. Downloaded from Bloomsbury Collections, www.bloomsburycollections.com, 26 September 2021, 13:50 UTC. Copyright © Hans Schildermans 2021. You may share this work for non-commercial purposes only, provided you give attribution to the copyright holder and the publisher, and provide a link to the Creative Commons licence. 2 The University in the Middle Ages: On the Invention of a New Use of Reason Given the deadlock that the university as institution confronts us with, how is it possible to construct a new point of departure? This chapter endeavors to search for new beginnings that might permit telling a different story about the university and its relation to the world. Therefore, I will take recourse to the invention of the university in the Middle Ages, since it might start a story of the university that is different from either the narrative of its ruinous sell-out to capital or the nostalgia of its glorious past as a sanctuary where people could study “in freedom and solitude.” Taking recourse to, however, does not mean returning to the past to find a model for future universities, or retracing the university’s origins. Instead, my aim will be to test the hypothesis of the university as an ecology of study to construct a historical argument that makes this proposition more palpable, as well as to provide insight into what it might mean concretely. -

LA SÁTIRA CONTRA LA CURIA ROMANA EN EL POEMA BURANO LICET EGER CUM EGROTIS Revista Káñina, Vol
Revista Káñina ISSN: 0378-0473 [email protected] Universidad de Costa Rica Costa Rica Cerdas Fallas, Maricela LA SÁTIRA CONTRA LA CURIA ROMANA EN EL POEMA BURANO LICET EGER CUM EGROTIS Revista Káñina, vol. XXXIV, núm. 1, 2010, pp. 63-73 Universidad de Costa Rica San José, Costa Rica Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44248787005 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Káñina, Rev. Artes y Letras, Univ. Costa Rica. XXXIV (1): 63-73, 2010 / ISSN: 0378-0473 LA SÁTIRA CONTRA LA CURIA ROMANA EN EL POEMA BURANO LICET EGER CUM EGROTIS Maricela Cerdas Fallas* RESUMEN El artículo se refiere a la importancia de los goliardos como representantes de la literatura latina medieval. Asimismo, presenta de manera general la situación de la Curia Romana en el siglo XII y analiza un poema de los Carmina Burana como ejemplo de crítica satírica contra la corrupción de la Iglesia católica. Palabras clave: latín, Carmina Burana, sátira, literatura medieval, goliardos. ABSTRACT The article refers to the importante of the goliards as representatives of medieval Latin literature. Moreover, it presents a panoramic view of the situation of the Roman Curia in the 12th century and analyzes a poem from the Carmina Burana as an example of satirical criticism against the corruption of the Roman Catholic Church. Key Words: Latin, Carmina Burana, satire, medieval literature, goliards. -

Clérigos Vagabundos
Manuel-Antonio MARCOS CASQUERO CLÉRIGOS VAGABUNDOS Por el ancho camino voy andando, como hace la juventud; en los vicios me sumerjo, de la virtud olvidado, ansioso de los placeres, más que de la salvación: muerto en el alma, me preocupo bien del cuerpo1. Quien así canta no es otro que el Archipoeta de Colonia, confesando su depravación ante su protector Reinaldo de Dassel, arzobispo elector de Co- lonia y archicanciller de Federico Barbarroja. ¿Es verdad que por los anchos caminos de la Europa de los siglos XI al XIII cruzaron tropeles de clérigos semejantes al Archipoeta, clérigos a los que, precisamente por aquella vida errabunda, se les aplicó el calificativo de «vagabundos»: clerici vagantes, popularmente también conocidos como goliardos? ¿Y quiénes fueron tales personajes? ¿Qué papel representaron en el mundo medieval? ¿Qué pueden decirnos de la época en que vivieron? Tiene razón García Villoslada2 cuando considera demasiado restringido el concepto de que «el goliardo medieval era un poeta latino popular, va- gabundo y juerguista, bohémien avant la lettre», concepto que se limita a ver en el goliardismo nada más que «la vida alegre y disoluta de los clerici vagantes, manifestada y cantada en sus poemillas eróticos, báquicos, censo- rios o bufonescos». Según él, bajo consideración semejante, «en toda la his- toria literaria del Medioevo latino no habría más que unos poquitos goliardos de nombre conocido o de apelativo famoso: el Primate de Orleans, el Archipoeta de Colonia y pocos más». Por ello considera que debe ampliarse el marco conceptual, ya que «hubo muchísimos poetas goliárdicos que nada 1 Marcos-Oroz 1995: 308, Via lata gradior more iuventutis, implico me vitiis, immemor virtutis, voluptatis avidus magis quam salutis, mortuus in anima curam gero cutis. -

UNA PARODIA EVANGÉLICA EN LOS CARMINA BURANA Maricela
Káñina, Rev. Artes y Letras, Univ. Costa Rica XXXVI (1): 117-126, 2012 / ISSN:0378-0473 UNA PARODIA EVANGÉLICA EN LOS CARMINA BURANA Maricela Cerdas Fallas* RESUMEN El artículo menciona la importancia de los goliardos como representantes de la literatura latina medieval. Asimismo, presenta de manera general la situación de la Curia Romana en el siglo XII y analiza un poema satírico de los Carmina Burana en el que se hace una crítica paródica contra la corrupción de la Iglesia Católica en la época. Palabras clave: latín, Carmina Burana, parodia, literatura medieval, goliardos. ABSTRACT The article refers to the importance of the goliards as representatives of medieval Latin literature. In addition, it presents a panoramic view of the situation of the Roman Curia in the 12th century and analyzes a satirical poem from the Carmina Burana as an example of parodic criticism against the corruption of the Roman Catholic Church at the time. Key Words: Latin, Carmina Burana, parody, medieval literature, goliards. 1. Introducción b. Cantos de celebración del amor y del regreso de la primavera. Carmina Burana es el nombre con que se conoce una colección de más de doscientos c. Poemas relacionados con el juego y la bebida. poemas medievales (carmina) que se encuentran Marcos Casquero expresa que en un manuscrito hallado en el siglo XIX en el monasterio de Benediktbeuren, en el sur de los poemas goliárdicos no sólo cantan al amor, al Burana vino, a las mujeres, a la primavera, o que sus versos Alemania. es la latinización de la palabra circulan entre la burla, la parodia, la jocosidad, alemana beuren. -

The Music of Sorcery in Brazil (Literary Conference) VIBRANT - Vibrant Virtual Brazilian Anthropology, Vol
VIBRANT - Vibrant Virtual Brazilian Anthropology E-ISSN: 1809-4341 [email protected] Associação Brasileira de Antropologia Brasil de Andrade, Mário The music of sorcery in Brazil (Literary Conference) VIBRANT - Vibrant Virtual Brazilian Anthropology, vol. 14, núm. 1, 2017, pp. 184-207 Associação Brasileira de Antropologia Brasília, Brasil Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=406952169012 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative Déjà Lu The music of sorcery in Brazil (Literary Conference) Mário de Andrade Abstract “The music of sorcery in Brazil” was given as a lecture by Mário de Andrade to the Brazilian Music Association (Associação Brasileira de Música), in Rio de Janeiro, in 1933. The author never managed to complete its revision for publication. This was undertaken by Oneyda Alvarenga, who published the text of the lecture and a series of related documents in Volume XIII – Música de Feitiçaria no Brasil–of the Complete Works of Mário de Andrade (Editora Itatiaia/Instituto Nacional do Livro, 1983, p.23-70). The author is in search for the role of music, with its distinctive rhythms and melodic form, in the mystical trance of Afro- Brazilian religions. The text combines the flavour of his direct research experience in thecatimbó of the Brazilian Northeast; his erudite bibliographical studies that were strongly influenced by evolutionary and diffusionist anthropology at the end of the 19th century and beginning of the twentieth; and an analysis of the music of macumba in the Rio de Janeiro around the 1930s as found in the recordings that Andrade so much enjoyed collecting and listening to. -

The Civilization of the Renaissance in Italy by Jacob Burckhardt
THE CIVILIZATION OF THE RENAISSANCE IN ITALY By Jacob Burckhardt Translated by S. G. C. Middlemore, 1878 Edited by Candida Martinelli This free e-book was created and is distributed not-for-profit by Candida Martinelli of Candida Martinelli’s Italophile Site Images in this book are from Webshots.com 2 HE REATISE AND ISTORY IN ATIN PART I THE STATE AS A WORK OF ART.............5 T T , H L ....................149 ANTIQUITY AS THE COMMON SOURCE......................153 NTRODUCTION I ..............................................................5 NEO-LATIN POETRY..................................................157 DESPOTS OF THE FOURTEENTH CENTURY.....................8 FALL OF THE HUMANISTS IN THE SIXTEENTH CENTURY ESPOTS OF THE IFTEENTH ENTURY D F C .......................13 ..................................................................................167 THE SMALLER DESPOTISMS ........................................21 THE GREATER DYNASTIES ..........................................27 PART FOUR THE DISCOVERY OF THE WORLD THE OPPONENTS OF THE DESPOTS ..............................38 AND OF MAN.............................................................176 THE REPUBLICS: VENICE AND FLORENCE...................43 JOURNEYS OF THE ITALIANS......................................176 FOREIGN POLICY .........................................................60 THE NATURAL SCIENCES IN ITALY ...........................178 WAR AS A WORK OF ART ............................................65 DISCOVERY OF THE BEAUTY OF LANDSCAPE............183 THE PAPACY................................................................67 -

University of Southampton Research Repository Eprints Soton
University of Southampton Research Repository ePrints Soton Copyright © and Moral Rights for this thesis are retained by the author and/or other copyright owners. A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the copyright holder/s. The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given e.g. AUTHOR (year of submission) "Full thesis title", University of Southampton, name of the University School or Department, PhD Thesis, pagination http://eprints.soton.ac.uk UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON FACULTY OF HUMANITIES Department of Music The Two-Part Conductus: Morphology, Dating and Authorship by Jacopo Mazzeo Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy May 2015 1 UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON ABSTRACT FACULTY OF HUMANITIES Music Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy THE TWO-PART CONDUCTUS: MORPHOLOGY, DATING AND AUTHORSHIP By Jacopo Mazzeo The conductus repertoire was widely cultivated between c.1160 and the late thirteenth century, and it comprises Latin texts set to both monophony and polyphony. Unlike the organum and the motet, the conductus does not normally exploit any pre-existing musical or poetic material. This makes the polyphonic share of conductus material the first newly composed, coherent repertoire for more than one voice. This thesis focuses on the two-part conductus. -

De Los Goliardos a Los Clérigos «Falsos»*
Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, H. a Medieval, t. 25, 2012, págs. 43 -84 De los goliardos a los clérigos «falsos»* From goliards to «false» clergymen ANA A RRANZ GUZMÁN ** RESUMEN ABSTRACT Los goliardos han sido estudiados casi de The Goliards have been studied manera exclusiva desde la óptica de la almost exclusively from a li te rary point filología, ya que el denominador común de of view, since the common denominator estos personajes fue su poe sía en latín. A that unites them was their Latin poe try. lo largo de estas páginas, sin embargo, se However, this study intends to cover ha pretendido hacer un reco rrido por certain aspects of historical interest. aquellos aspectos más ligados a los On the one hand, their wealth will intereses históricos. Por un lado, se be examined as they conformed a examina su riqueza como subgrupo specific social class and there has been estamental, dado el interés que despiertan considerable interest in their collective su particular comportamiento vital y su behaviour and unique outlook on the singular mirada sobre el modelo de social context they lived in. On the sociedad en el que se desenvolvieron. Por other hand, this study also looks at otro, se analiza la posible relación de los the possible relationship among protagonistas de este movimiento cultural the major figures of this cultural con los denominados clérigos movement and those labelled vagabond vagabundos, malhechores de corona y clergymen, wrongdoers, clérigos falsos, denunciados and false clergymen, denounced especialmente a fines del Medievo en la especially at the end of the Middle Ages Corona de Castilla. -

Download Report 2013-14
MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR WISSENSCHAFTSGESCHICHTE RESEARCH REPORT 2013—2014 Boltzmannstraße 22, 14195 Berlin, Phone (+4930) 22667– 0, www.mpiwg-berlin.mpg.de MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR WISSENSCHAFTSGESCHICHTE RESEARCH REPORT 2013—2014 REPORT RESEARCH Max Planck Institute for the History of Science INSTITUT FÜR WISSENSCHAFTSGESCHICHTE MAX-PLANCK- Cover: The photo of the Institute’s entrance hall was taken by Montserrat de Pablo with the Experimental Historical Camera Obscura (CO) of the MPIWG. This Camera served and serves investigations into the performance of optical CO’s of the 17th and 18th centuries when this instrument played an important role in the development of optics. These CO’s were also of significance for painting in the early modern period and later on no less for photography up to the present day. Montserrat de Pablo, who teaches photography at the Universidad de Castillia-La Mancha, Cuenca, Spain, stayed at the MPIWG as a visiting scholar and artist-in-residence in Department I in 2014 and 2015. photographs p. 255: Yehuda Elkana © Wissenschaftskolleg zu Berlin, Johannes Fehr © Collegium Helveticum Most of the portrait photographs were taken by Skúli Sigurdsson RESEARCH REPORT 2013—2014 MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR WISSENSCHAFTSGESCHICHTE Max Planck Institute for the History of Science Department II 2 MPIWG RESEARCH REPORT 2013–2014 Introduction In 2014 the Max Planck Institute for the History of Science (MPIWG), Berlin, turned twenty. Since 2013, the MPIWG has witnessed a changing of the guard in key posi- tions: a new Department directed by Dagmar Schäfer has begun its work; Ohad Parnes has succeeded Jochen Schneider as Research Coordinator; and Esther Chen will soon take over as Head Librarian from Urs Schoepflin.