Ventunesimo Secolo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Thatcher, Northern Ireland and Anglo-Irish Relations, 1979-1990
From ‘as British as Finchley’ to ‘no selfish strategic interest’: Thatcher, Northern Ireland and Anglo-Irish Relations, 1979-1990 Fiona Diane McKelvey, BA (Hons), MRes Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences of Ulster University A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the Ulster University for the degree of Doctor of Philosophy August 2018 I confirm that the word count of this thesis is less than 100,000 words excluding the title page, contents, acknowledgements, summary or abstract, abbreviations, footnotes, diagrams, maps, illustrations, tables, appendices, and references or bibliography Contents Acknowledgements i Abstract ii Abbreviations iii List of Tables v Introduction An Unrequited Love Affair? Unionism and Conservatism, 1885-1979 1 Research Questions, Contribution to Knowledge, Research Methods, Methodology and Structure of Thesis 1 Playing the Orange Card: Westminster and the Home Rule Crises, 1885-1921 10 The Realm of ‘old unhappy far-off things and battles long ago’: Ulster Unionists at Westminster after 1921 18 ‘For God's sake bring me a large Scotch. What a bloody awful country’: 1950-1974 22 Thatcher on the Road to Number Ten, 1975-1979 26 Conclusion 28 Chapter 1 Jack Lynch, Charles J. Haughey and Margaret Thatcher, 1979-1981 31 'Rise and Follow Charlie': Haughey's Journey from the Backbenches to the Taoiseach's Office 34 The Atkins Talks 40 Haughey’s Search for the ‘glittering prize’ 45 The Haughey-Thatcher Meetings 49 Conclusion 65 Chapter 2 Crisis in Ireland: The Hunger Strikes, 1980-1981 -

The Ship 2014/2015
A more unusual focus in your magazine this College St Anne’s year: architecture and the engineering skills that make our modern buildings possible. The start of our new building made this an obvious choice, but from there we go on to look at engineering as a career and at the failures and University of Oxford follies of megaprojects around the world. Not that we are without the usual literary content, this year even wider in range and more honoured by awards than ever. And, as always, thanks to the generosity and skills of our contributors, St Anne’s College Record a variety of content and experience that we hope will entertain, inspire – and at times maybe shock you. My thanks to the many people who made this issue possible, in particular Kate Davy, without whose support it could not happen. Hope you enjoy it – and keep the ideas coming; we need 2014 – 2015 them! - Number 104 - The Ship Annual Publication of the St Anne’s Society 2014 – 2015 The Ship St Anne’s College 2014 – 2015 Woodstock Road Oxford OX2 6HS UK The Ship +44 (0) 1865 274800 [email protected] 2014 – 2015 www.st-annes.ox.ac.uk St Anne’s College St Anne’s College Alumnae log-in area Development Office Contacts: Lost alumnae Register for the log-in area of our website Over the years the College has lost touch (available at https://www.alumniweb.ox.ac. Jules Foster with some of our alumnae. We would very uk/st-annes) to connect with other alumnae, Director of Development much like to re-establish contact, and receive our latest news and updates, and +44 (0)1865 284536 invite them back to our events and send send in your latest news and updates. -

Lord Cecil Parkinson 1
Lord Cecil Parkinson 1 Trade minister in Margaret Thatcher's first government in 1979, Cecil Parkinson went on to become Conservative Party chairman. He was instrumental in privatizing Britain's state-owned enterprises, particularly electricity. In this interview, Parkinson discusses the rethink of the British Conservative Party in the 1970s, Margaret Thatcher's leadership in the Falklands War, the coal miners' strike, and the privatization of state-owned industries. Rethinking the Conservative Party, and the Role of Keith Joseph INTERVIEWER: Let's talk about Margaret Thatcher during the '70s. After the defeat of [Prime Minister Ted] Heath, Margaret Thatcher almost goes back to school. She and Keith Joseph go to Ralph Harris [at the Institute for Economic Affairs] and say, "Give us a reading list." What's going on here? What's Margaret really doing? LORD CECIL PARKINSON: I think Margaret was very happy with the Heath manifesto. If you look at the Heath manifesto, it was almost a mirror image of her 1979 manifesto. All the things—cutting back the role of the state, getting rid of the nationalized industries, curbing the train unions, cutting of taxes, controlling public expenditure—it's all there. It's a very, very good manifesto. And I've heard her recently compliment him on the 1970 manifesto, which was a slightly sort of backhanded compliment, really. What troubled her was that we could be bounced out of it. We could be moved from doing the things which we knew were right and doing things which we secretly knew were wrong because of circumstances, and I think instinctively she felt this was wrong, but she didn't have the sort of intellectual backup, she felt, to back up her instincts. -

The Ethics of Privatisation
Durham E-Theses The ethics of privatisation Yeats, Charles How to cite: Yeats, Charles (1998) The ethics of privatisation, Durham theses, Durham University. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/5052/ Use policy The full-text may be used and/or reproduced, and given to third parties in any format or medium, without prior permission or charge, for personal research or study, educational, or not-for-prot purposes provided that: • a full bibliographic reference is made to the original source • a link is made to the metadata record in Durham E-Theses • the full-text is not changed in any way The full-text must not be sold in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. Please consult the full Durham E-Theses policy for further details. Academic Support Oce, Durham University, University Oce, Old Elvet, Durham DH1 3HP e-mail: [email protected] Tel: +44 0191 334 6107 http://etheses.dur.ac.uk THE ETHICS OF PRIVATISATION by Charles Yeats Abstract The main aim of the thesis is to provide an ethical evaluation of privatisation. We begin by sketching a history of privatisation in order to give an initial impression of how it has dramatically re-drawn the economic borders of the state in Britain and in many other countries across the world. We also show how privatisation has come to challenge the post-war Christian consensus which was supportive of the mixed economy. We men explain why we find a qualified Aristotelian-Thomist tradition offers us the best moral resource for our enquiry. -

Constitutional Change in the United Kingdom
Constitutional Change in the United Kingdom The years since New Labour came to power in 1997 have seen changes on an unprecedented scale in Britain’s constitutional arrangements. The reforms have been widespread and far-reaching in their implications: devolution to Scotland, Wales and Northern Ireland; reform of the House of Lords; the Human Rights Act 1998; and significant changes in the rules of the political game. This book is one of the first to examine all the changes collectively and in detail, to place each in its historical context, and to analyse both the problems and the solutions, with pointers to further reform in future. It is comprehensive in its coverage, and clearly written. It should be an ideal resource for undergraduate students of British politics and constitutional law who seek to make sense of this dynamic and complex subject. Nigel Forman was the Member of Parliament for Carshalton and Wallington between 1976 and 1997. During that time he was also a Parliamentary Private Secretary at the Foreign and Commonwealth Office and the Treasury, as well as a Minister at the Department for Education. He has taught at several universities and is a visiting lecturer at the Civil Service College. His other publications include Mastering British Politics with N.D.J. Baldwin (Macmillan, 1985; fourth edition 1999). Constitutional Change in the United Kingdom F.N. Forman London and New York First published 2002 British Library Cataloguing in Publication Data by Routledge A catalogue record for this book is available from the 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE British Library Simultaneously published in the USA and Canada Library of Congress Cataloguing in Publication Data by Routledge A catalog record for this book has been requested 29 West 35th Street, New York, NY 10001 Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2004. -
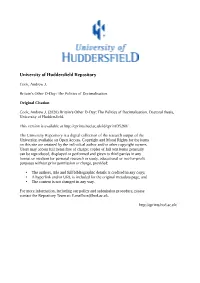
University of Huddersfield Repository
University of Huddersfield Repository Cook, Andrew J. Britain’s Other D-Day: The Politics of Decimalisation Original Citation Cook, Andrew J. (2020) Britain’s Other D-Day: The Politics of Decimalisation. Doctoral thesis, University of Huddersfield. This version is available at http://eprints.hud.ac.uk/id/eprint/35268/ The University Repository is a digital collection of the research output of the University, available on Open Access. Copyright and Moral Rights for the items on this site are retained by the individual author and/or other copyright owners. Users may access full items free of charge; copies of full text items generally can be reproduced, displayed or performed and given to third parties in any format or medium for personal research or study, educational or not-for-profit purposes without prior permission or charge, provided: • The authors, title and full bibliographic details is credited in any copy; • A hyperlink and/or URL is included for the original metadata page; and • The content is not changed in any way. For more information, including our policy and submission procedure, please contact the Repository Team at: [email protected]. http://eprints.hud.ac.uk/ BRITAIN’S OTHER D-DAY: THE POLITICS OF DECIMALISATION ANDREW JOHN COOK A thesis submitted to the University of Huddersfield in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy The University of Huddersfield March 2020 CONTENTS Page Acknowledgements…………………………………………………………………………. 2 Abstract…………………………………………………………………………………………… 4 Chapter 1: Introduction…………………………………………………………………… 6 Chapter 2: Political Management…………………………………………………….. 50 Chapter 3: Britishness and Europeanisation…………………………………….. 92 Chapter 4: Modernity, Declinism and Affluence………………………………. 128 Chapter 5: Interest Groups………………………………………………………………. -

The Cynical State
THE CYNICAL STATE COLIN LEYS ‘Mendacity is a system that we live in’. (Tennessee Williams, Cat on a Hot Tin Roof) overnments have always lied. They naturally deny it, even long after it Gis abundantly clear that they have lied, trailing multiple red herrings, dismissing inconvenient evidence, implying that there is counter-evidence they are not free to produce. When a lie can no longer be credibly denied it is justified, usually by an appeal to the national interest. Governments of modern representative democracies are no different, even if they are more liable than dictators to be exposed. Half-truths and outright lies are routinely told. Facts are routinely concealed. Files are unaccountably lost. Tapes are mysteriously erased. Democratic checks and balances are rarely effective and the public’s collective memory is short. Even so, in recent years state cynicism has broken new ground. The British government’s flagrant abuse of military intelligence to persuade parliament and the public to endorse its attack on Iraq was a dramatic case in point. In July 2003, soon after the official end of the war, a British government weapons expert, David Kelly, killed himself after being revealed as the source for a BBC report that the government’s dossier outlining the intelligence had been knowingly ‘sexed up’. The government appointed a reliable judge, Lord Hutton, to hold a public enquiry into Kelly’s death. The evidence given to the enquiry showed that the Prime Minister’s staff had been working flat out to make it appear that Saddam Hussein posed a threat to Britain that would justify invading Iraq. -

When Ronald Reagan Met Margaret
RADAR Research Archive and Digital Asset Repository James Cooper ‘I must brief you on the mistakes’: When Ronald Reagan met Margaret Thatcher, 25-28 February 1981 Journal of Policy History (Cambridge University Press, 2014) This version is available: https://radar.brookes.ac.uk/radar/items/eb2e4a14-4874-46e9-9b29-876d34ec6998/1/ Available on RADAR: 26.05.2016 Copyright © and Moral Rights are retained by the author(s) and/ or other copyright owners. A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. This item cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the copyright holder(s). The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. This document is the accepted version. WWW.BROOKES.AC.UK/GO/RADAR ‘I must brief you on the mistakes’: When Ronald Reagan met Margaret Thatcher, 25-28 February 1981 Abstract Margaret Thatcher and Ronald Reagan gained power after promising similar solutions to the economic decline of the 1970s and are commonly viewed in the same ‘New Right’ context. Having met twice before in 1975 and 1978, the first meeting in February 1981, following their respective ascents to power, was popularly viewed as a diplomatic ‘love-in’ and a reaffirmation of the Anglo-American ‘special relationship’ in the context of an emerging New Right hegemony. However, this article demonstrates that even at this early stage, it was clear that the Reagan-Thatcher dynamic would be as much ‘political’ as would be ‘special’. -

Specialist Autograph Auction Saturday 12 July 2014 11:00
Specialist Autograph Auction Saturday 12 July 2014 11:00 International Autograph Auctions (IAA) Office address Foxhall Business Centre Foxhall Road NG7 6LH International Autograph Auctions (IAA) (Specialist Autograph Auction) Catalogue - Downloaded from UKAuctioneers.com Lot: 1 boxing ring, standing over Sonny Liston who lies on the canvas BOXING: A printed 8vo menu for a luncheon hosted by Jack before him. Signed ('Muhammad Ali aka Cassius Clay') in bold Solomons at Isow's Restaurant and Jack of Clubs nightspot in gold ink to a clear area of the background. Double matted in London in honour of the former World Champion boxers Max blue and white and framed and glazed in a gold coloured frame Baer, Henry Armstrong and Gus Lesnevich, 29th October 1958, to an overall size of 22.5 x 26.5. EX signed to the inside by fifteen boxers including Max Baer (World Estimate: £200.00 - £300.00 Heavyweight Champion 1934-35), Henry Armstrong (World Featherweight Champion 1937-38, World Welterweight Champion 1938-40 and World Lightweight Champion 1938-39), Lot: 6 Gus Lesnevich (World Light Heavyweight Champion 1941-48), FRAZIER JOE: (1944-2011) American Boxer, World Carlo Ortiz (World Lightweight Champion 1962-65, 1965-68), Heavyweight Champion 1970-73. Signed colour 8 x 10 Rinty Monaghan (World Flyweight Champion 1947-49), Terry photograph of Smokin' Joe standing in a full length boxing Downes (World Middleweight Champion 1961-62), Bruce pose. Signed in bold green ink with his name alone to a light Woodcock (European Heavyweight Champion 1946-49), Peter area of the image. EX Waterman (European Welterweight Champion 1958), Len Estimate: £80.00 - £100.00 Harvey (British Heavyweight Champion 1938-42), Johnny Williams (British Heavyweight Champion 1952-53), Harry Mizler (British Lightweight Champion 1934), Eric Boon (British Lot: 7 Lightweight Champion 1938-44), Sammy McCarthy (British NORTON KEN: (1943-2013) American Boxer, WBC Featherweight Champion 1954-55), Pat Supple and one other. -
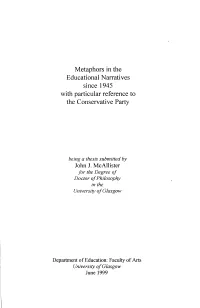
Metaphors in the Educational Narratives Since 1945 with Particular Reference to the Conservative Party
Metaphors in the Educational Narratives since 1945 with particular reference to the Conservative Party being a thesis submitted by John J. McAllister for the Degree of Doctor of Philosophy in the University of Glasgow Department of Education: Faculty of Arts University of Glasgow June 1999 ProQuest Number: 13815571 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a com plete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest ProQuest 13815571 Published by ProQuest LLC(2018). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States C ode Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC. 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106- 1346 GLASGOW UNIVERSITY LIBRARY ( Summary: 1 Summary Metaphors in the Educational Narratives since 1945 with particular reference to the Conservative Party This study seeks to provide both a methodology and an application of that methodology in its account, partly historical, partly philosophical, of the metaphors in the educational narratives since 1945. It considers, in particular, selected texts of the Conservative Party and focusses on the paradigm shifts in the educational narratives in 1945 and again in 1979. The study deconstructs these narratives, teasing out their constitutive metaphors: their characteristic representations of educational identities, realities and relationships. The ideological subtexts of these representations are described, as is the process by which they came to represent the ‘common sense’ of education as the metaphors which constituted them became literalised. -

Ministers' Metrication Conspiracy
Ministers’ Metrication Conspiracy How legislation for compulsory metrication in 1971 was achieved by the bypassing of Parliament and public, in order to ensure admission to the EEC - and how politicians buried this conspiracy by creating the myth that compulsory metrication had followed a decision by Parliament in 1965 From Francis Pym, Government Chief Whip and Parliamentary Secretary to the Treasury, to John Eden, Minister of State for Industry - 22 November 1971 Tuesday, 27 October 1970 Julian Amery, Minister for Housing and Construction, speaking in the House of Commons “I have made it plain, as did my hon. Friend in opening the debate, that we favour going forward towards voluntary metrication. I have tried to make it plain that we are opposed to compulsion in any respect.” Tuesday, 29 December 1970 A Memorandum from the European Commission to Member States: “… the European Commission has adopted a proposal concerning the approximation of the legislation of the Member States relating to units of measure … The consequences of the unification of the units of measure will of course be felt in the field of trade of goods … The EC has selected, as a harmonisation formula, that of “total harmonisation”. This means that the Community provisions and definitions will have to replace the national provisions and definitions … The Commission has therefore laid down a transitional period of five years, during which the Member States will have to gradually eliminate the “units of measure” which do not conform … Certain units commonly used in the various Member States do not correspond to the International System of units and must be eliminated … Member States will have 18 months, after the adoption of the Directive, to make their national legislation conform to this …” Introduction This year marks the 50th anniversary of the government’s 24 May 1965 announcement that Britain should adopt the metric system voluntarily. -

Bringing Labor Back In
Bringing Labor Back In: Varieties of Unionism and the Evolution of Employment Protection and Unemployment Benefits in the Rich Democracies By Joshua C. Gordon A thesis submitted in conformity with the requirements for the Degree of Doctorate of Philosophy Graduate Department of Political Science University of Toronto © Copyright by Joshua C. Gordon (2012) Bringing Labor Back In: Varieties of Unionism and the Evolution of Employment Protection and Unemployment Benefits in the Rich Democracies Joshua C. Gordon Department of Political Science, University of Toronto Doctor of Philosophy, 2012 Abstract This thesis looks at the politics of labor market policy in the postwar period in the advanced industrialized democracies. Specifically, the dissertation seeks to explain stark cross-national differences in unemployment benefit systems and employment protection legislation. The theory advanced in this thesis emphasizes significant differences in union organization across the rich democracies. This view, “Varieties of Unionism”, shows how the varying political capacities and policy preferences of labor movements explain most of the cross-national policy differences. In particular, the research points to union movements’ ideological traditions and varying rates of union density, union centralization, and involvement in unemployment benefit administration as crucial explanatory forces. Each feature of union movements captures an important part of why they might choose to advocate on behalf of the unemployed and to their differential ability to have those policy preferences realized, as well as indicating the kinds of preferences they will have for employment protection legislation. In the case of policies directed at the unemployed (or so-called labor market ‘Outsiders’), these insights lead to the construction of an index of “Outsider-oriented Unionism”, which correlates very closely to cross-national variations in unemployment benefit generosity as well as to active labor market policy spending.