Civilta' Della Transumanza
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
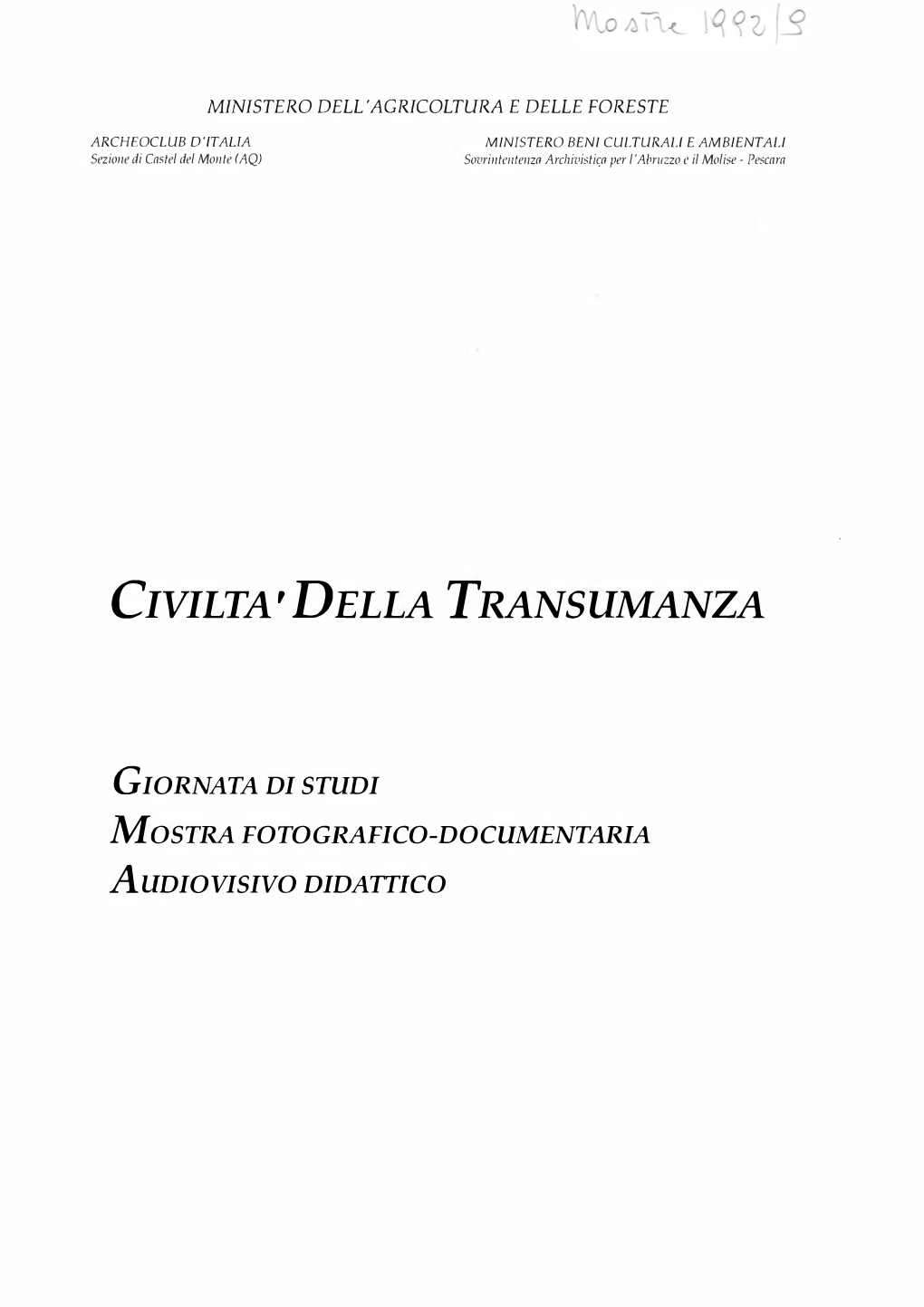
Load more
Recommended publications
-

Il Paesaggio Culturale Delle Vie Della Transumanza
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE Dottorato di ricerca in Bioscienze e Territorio, Curriculum Territoriale, 30° ciclo (A.A. 2014/2015 - A.A. 2016/2017) IL PAESAGGIO CULTURALE DELLE VIE DELLA TRANSUMANZA. CONSERVAZIONE E RIUSO A FINI TURISTICI SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE DI AFFERENZA: M-GGR/01 Tesi di dottorato di GIUSEPPE DI FELICE, matricola n. 153803 Coordinatore del dottorato Tutore del dottorato Prof.ssa GABRIELLA STEFANIA SCIPPA Prof.ssa MONICA MEINI Co-tutore Prof. MARCO PETRELLA _________________________________________________________________________________________________ Tesi di dottorato in Bioscienze e Territorio, Università degli Studi del Molise Giuseppe Di Felice, “Il paesaggio culturale delle vie della transumanza. Conservazione e riuso a fini turistici” INDICE INTRODUZIONE – Obiettivi e struttura della ricerca p. 1 PRIMA PARTE Inquadramento storico-geografico della ricerca p. 6 CAPITOLO 1 La transumanza nell’Italia centro-meridionale: un’analisi diacronica p. 7 1.1 Inquadramento generale p. 7 1.2 Dalle origini all’istituzione doganale p. 9 1.3 La Dogana delle pecore di Puglia p. 12 1.4 Il declino dell’allevamento transumante nel periodo post-doganale p. 19 CAPITOLO 2 Geografia e cartografia del sistema della transumanza p. 22 2.1 L’organizzazione della transumanza durante la vita della Dogana p. 22 2.2 Organizzazione istituzionale e inquadramento spaziale del controllo pubblico p. 33 2.3 Le reintegre: uno strumento di rappresentazione del territorio p. 39 SECONDA PARTE La ricostruzione del paesaggio della transumanza p. 48 Nota introduttiva p. 49 CAPITOLO 3 I locati, primi attori della pratica della transumanza p. 54 3.1 Le fonti p. 54 3.2 Il Molise, non solo terra di transito p. -

Digital Ethnography Research Report 8.42 Mb
WP T2 – IDENTIFICATION OF BEST PRACTICES IN THE COLLECTIVE COMMERCIAL VALORISATION OF ALPINE FOOD INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE WP leader: Kedge Business School Deliverable n. D.T2.3.1 Digital Ethnography Research Report on Consumer Response to the Alpine Food Intangible Cultural Heritage Involved partners: Kedge Business School University of Innsbruck This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme. Contents 1. Introduction 2. Case study Aosta Valley, Italy 2.1 Role of the Alpine Food ICH in the overall image of the Aosta Valley on Instagram (IG) 2.2 Heritage Products (1): The case of Fontina cheese PDO 2.3 Heritage Products (2): The case of Arnad Lard 2.4 Alpine heritage events on IG: The cases of Desarpa and the Festa de lo Pan Ner 2.5 Consumer Reviews of Restaurants on TripAdvisor 3. Case study Raclette of Valais cheese PDO, Switzerland 4. Case Study Tyrolean Graukäse, Austria/Italy 4.1 Data collection, sampling, content analysis and network visualisation 4.2 Overall resonance of the Alpine heritage food product Graukäse on IG 4.3 Consumer meanings 5. Conclusions 5.1 Key insights 5.2 Recommendations References 2 List of Figures 1 – Instagram: Illustrative post on #raclette 2 – #valledaosta: Hashtag network 3 – #aostavalley: Hashtag network 4 – #volgovalledaosta: Hashtag network 5 – Content of posts on #valledaosta (%, N=500) 6 – #fontina: Hashtag network 7 – #fontinadop (left) and #fontinadalpeggio (right): Hashtag networks 8 – Content of posts on #fontina and #fontinacheese -

Il “Genius Loci” Del “Tratturo”. Recupero Del Retaggio Della Transumanza Nel Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio E Molise (Italia) the “Genius Loci” of the “Tratturo”
APEA. Asociación Profesional Extremeña de Antropología Il “genius loci” del “tratturo”. Recupero del retaggio della transumanza nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (Italia) The “genius loci” of the “tratturo”. Recovery of the transhumance heritage in the Abruzzo, Lazio and Molise National Park (Italy) Mariapia Graziani Direttrice del Museo della Transumanza di Villetta Barrea (Abruzzo, Italia) [email protected] Maria Avram Università di Oradea (Romania) [email protected] Resumen La práctica pastoril de la trashumancia, o la migración estacional de los rebaños a lo largo de rutas fijas conocido como "tratturi", que en el Mezzogiorno (sur de Italia) tiene orígenes antiguos, ha modelado profundamente el paisaje social y cultural de muchas regiones del sur de Italia. Los territorios de la antigua trashumancia en el sur de Italia hoy en día están afectados por las nuevas culturas económicas y la trashumancia ha sido sustituida por formas sedentarias de cría de ovejas integradas con la agricultura. Sin embargo, el patrimonio cultural y territorial todavía existe: esta antigua herencia ha dejado huellas en los ámbitos territorial y cultural de estas zonas, signos que pueden ser aún fácil de entender, leer e interpretar. En este contexto, son particularmente interesantes las iniciativas emprendidas en el área del Parque Nacional de Abruzzo, Lazio y Molise (Italia), porque están concebidos para combinar la recuperación de este importante legado histórico de las políticas institucionales de protección del medio ambiente y la promoción del turismo sostenible. Abstract Pastoral practice of transhumance, or the seasonal migration of flocks along fixed routes known as "tratturi”, which in the Mezzogiorno (Southern Italy) has ancient origins, has profoundly shaped the social landscape and ETNICEX, 2011, Núm. -

Download Download
Almatourism Special Issue N. 8, 2018: de Waal V., Understanding the Continuous Sustainable Nature of Cultural and Sacred Heritage - The Cultural and Sacred Sites of the Majella National Park in Abruzzo Almatourism Journal of Tourism, Culture and Territorial Development ___________________________________________________________ Understanding the Continuous Sustainable Nature of Cultural and Sacred Heritage - The Cultural and Sacred Sites of the Majella National Park in Abruzzo de Waal, V.* Foundation for GAIA (UK), ICOMOS ISC PRERICO (France), IUCN WCPA CSVPA (Switzerland) ABSTRACT Since time immemorial there have been places that held a special meaning and were perceived to be endowed with special powers or of special spiritual or cultural significance. It is surprising to discover that many cultural and sacred sites have a long history reaching back hundreds of thousands of years (Mallarach & Papayannis, 2010). While some cultural traditions have their source in civilisations that have long since disappeared (Hamilton, 2006), many of their beliefs are still alive and their sacred sites have continued to be used for millennia, like in the Apennine, the old traditional Italian mountain. These sites, a true example of study, provide some understanding of how societies evolve, how the histories of people, their legends, their traditions, their beliefs, their laws, their rituals and religions play out in the evolution of human cultures to bring us to where we stand today: a composite of the past that survived through geographical and cultural diversification (Frascaroli & Verschuuren, 2016). _________________________________________________________ Keywords: Majella National Park; Paleolithic; Sacred Sites; Cultural Traditions; Beliefs * E-mail: [email protected] almatourism.unibo.it – ISSN 2036-5195 - https://doi.org/10.6092/issn.2036-5195/7723 129 This article is released under a Creative Commons - Attribution 3.0 license. -

The Case of Tratturo Castel Di Sangro-Lucera (Molise, Italy)
land Article Land Use Dynamics of Drove Roads: The Case of Tratturo Castel di Sangro-Lucera (Molise, Italy) Michele Minotti * ID , Carmen Giancola, Piera Di Marzio ID and Paolo Di Martino ID Department of Biosciences and Territory, University of Molise, C.da Fonte Lappone, 86090 Pesche (IS), Italy; [email protected] (C.G.); [email protected] (P.D.Marz.); [email protected] (P.D.Mart.) * Correspondence: [email protected]; Tel.: +39-08-7440-4111 Received: 23 August 2017; Accepted: 5 January 2018; Published: 8 January 2018 Abstract: Organized transhumant pastoralism has contributed to shaping the cultural landscape of many countries. It has affected areas designated for grazing, temporary and permanent shelters, and towns. Through the analysis of historical maps and recent information, in a temporal range from 1652 to 2014, this study focused on changes in land cover and conservation status of one of the main Italian transhumance paths, namely the Tratturo Castel di Sangro-Lucera. Although there are some areas where this drove road is still recognizable, it is mostly identifiable only through a few tangible signs. The methodological approach, which we present in this study, allowed us to compare historical and recent cartographies as well as archive documentation. The resulting virtual reinstatement is proposed as an efficient method for the conservation and management of material cultural heritage and can be applied in other countries with transhumance drove roads (e.g., France, Portugal). Keywords: drove roads; transhumance; land use change; reinstatement; squatting; Molise (Italy) 1. Introduction Pastoralism has been widely practiced all over the world, starting with the Neolithic period [1] and nowadays can be divided into three types: pastoral farming (pastoral mobility with little or no long-distance movement); nomadic pastoralism (pastoral mobility in highly irregular patters); and transhumant pastoralism (regular back-and-forth movements between relatively fixed locations) [2]. -

Migration, Agriculture and Rural Development
IMISCOE Research Series Michele Nori Domenica Farinella Migration, Agriculture and Rural Development IMISCOE Short Reader IMISCOE Research Series This series is the official book series of IMISCOE, the largest network of excellence on migration and diversity in the world. It comprises publications which present empirical and theoretical research on different aspects of international migration. The authors are all specialists, and the publications a rich source of information for researchers and others involved in international migration studies. The series is published under the editorial supervision of the IMISCOE Editorial Committee which includes leading scholars from all over Europe. The series, which contains more than eighty titles already, is internationally peer reviewed which ensures that the book published in this series continue to present excellent academic standards and scholarly quality. Most of the books are available open access. For information on how to submit a book proposal, please visit: http://www. imiscoe.org/publications/how-to-submit-a-book-proposal. More information about this series at http://www.springer.com/series/13502 Michele Nori • Domenica Farinella Migration, Agriculture and Rural Development IMISCOE Short Reader Michele Nori Domenica Farinella Robert Schuman Centre for Advanced Department of Political Sciences and Law Studies University of Messina European University Institute Messina, Messina, Italy Firenze, Firenze, Italy ISSN 2364-4087 ISSN 2364-4095 (electronic) IMISCOE Research Series ISBN 978-3-030-42862-4 ISBN 978-3-030-42863-1 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-030-42863-1 © The Editor(s) (if applicable) and The Author(s) 2020. This book is an open access publication. -

AMHS NOTIZIARIO May 2018
www.abruzzomoliseheritagesociety.org AMHS NOTIZIARIO May 2018 Top: Guest speaker Diane Welland. Bottom (from left): AMHS President Ray LaVerghetta with Diane Welland, Nancy DeSanti, 1st VP-Programs, and Lucio D’Andrea, President Emeritus. (photos courtesy of Joe Novello and Maria D’Andrea-Yothers). NEXT SOCIETY EVENT: AMHS General Society Meeting, Sunday, June 10, 2018 at 1:00pm at Casa Italiana. Professor Thomas Guglielmo will talk about Italian immigration. See inside for details. A MESSAGE FROM THE PRESIDENT I hope you enjoy the rest of the Notiziario and the wonderful season of spring too! Dear members and friends: Ray LaVerghetta By the time that you read this message, we UPCOMING SOCIETY EVENTS AND will (hopefully) no ACTIVITIES longer be waiting for spring to spring. Winter this year has seemed to GWU PROFESSOR THOMAS GUGLIELMO TO TALK ABOUT ITALIAN IMMIGRATION drag its feet (so to st speak) and hang around By Nancy DeSanti, 1 Vice President - Programs longer than usual. It seems that we too The interesting and timely topic waited a little longer of immigration, specifically than usual for the Italian immigration to America, second AMHS program in 2018. It did take place however on will be the topic of our third April 15th at Carmine’s restaurant, where noted nutritionist and program for this year. The writer Diane Welland joined us for an extremely interesting luncheon meeting will be held talk on the history of pasta. She explained that pasta is actually at Casa Italiana on June 10, good for us and that there are many tips on its use as well as 2018, at 1:00 p.m., and we are many enticing recipes for preparing it – we just need to know honored to have as our speaker where to look. -

Recupero E Valorizzazione Del Tratturo Pescasseroli-Candela
Provincia di Foggia Recupero e valorizzazione del tratturo Pescasseroli-Candela Progetto Piillota dell Piiano Paesaggiistiico Terriitoriialle Regiionalle Schema dii Piiano Operatiivo IIntegrato n.. 10 dell PTCP dii Foggiia RELAZIONE GENERALE Gruppo di lavoro Consulenze: Coordinamento scientifico Arturo Cucciolla, Giorgio Muratore Coordinamento operativo Mauro Iacoviello, Documentazione storica e Beni Culturali* Roberta de Iulio Collaboratori Pierluigi Bovi, Saverio Buccino, Antonella Carella, Paolo D'Addato, Antonello D'Ardes, Felice Dattoli, Antonio De Maio, Matteo Vairo Ufficio di Piano Stefano Biscotti (dirigente) Giovanna Caratu', Cosmo D. Lovascio, Maria Vitale * le analisi di questa sezione sono tratte dalla tesi di dottorato Il paesaggio della transumanza: dalla memoria storica al riuso compatibile, Università di Foggia, Corso di Dottorato Storia e Archeologia Globale dei Paesaggi-XXV CICLO PREMESSE...............................................................................................................................3 1. la memoria letteraria e iconografica dei paesaggi della transumanza....6 1.1.I paesaggi della transumanza nella letteratura di viaggio...........................9 1.1.1 I viaggiatori francesi..............................................................................................9 1.1.2 I viaggiatori inglesi...............................................................................................20 1.1.3 I viaggiatori tedeschi ...........................................................................................24 -

De Copmontagnaestate:Layout 1
ABRUZZEN ITALIEN Berge im Sommer In den Bergen der 2 Abruzzen 10 Abruzzen: Berge für alle Sommerurlaubsorte in den 12 abruzzesischen Bergen 26 Die Seen der Abruzzen Veranstaltungen: Jeder Tag ein unvergessliches 28 Erlebnis! Gastlichkeit in den 30 abruzzesischen Bergen Die Berge der Abruzzen, Kunsthandwerk und 34 kulinarische Kostbarkeiten In den BERGEN Der majestätische und raue Gran Sasso mit seinem hellen Kalkstein beherrscht den Apennin. Knapp unter der Nordwand des Corno Grande befindet sich der Calderone, der einzige Gletscher im Apennin und der südlichste Europas. Im Süden des Massivs erstreckt sich die weitläufige Ebene Campo Imperatore auf einer Höhe von 1800 m. Die Monti della Laga sind reich an Quellen, Wasserläufen und Wäldern. Das mit dem Morrone- Massiv verbundene Majellagebirge ragt zwischen Meer und Apennin in die Höhe und dominiert die abruzzesische Landschaft. Seit Urzeiten bildet es für die Einheimischen das „Muttergebirge“ (La Montagna Madre). Die zwischen Gebirge und Meer eingebettete Hügellandschaft weist deutliche Zeichen permanenten Wandels auf: Der Lehm rutscht ins Tal ab und bildet somit Erosionsrinnen (sog. Calanchi), die die abgerundeten Konturen zerklüften. Alpine Umgebungen, die nach Meer duften Im Sommer, wenn der Schnee endlich geschmolzen ist und die Buchenwälder sowie die unendlichen Wiesen wieder in sattem Grün leuchten, ist das Gebirge der Abruzzen wirklich unwiderstehlich. Die üppige Vegetation verleiht der gesamten Region einen reifen Glanz: Mit ihren Wäldern und den saftig grünen Wiesen der Berge, den unendlichen Hochebenen mit grasenden Viehherden, der weiten Landschaft, die so rein gar nichts mit den fast bedrohlich wirkenden und steil abfallenden Alpenregionen gemeinsam hat, der prickelnden Luft mit ihrem Duft nach frischer Meeresbrise (auch in hohen Lagen ist der Geruch des Meers deutlich wahrzunehmen, das nur wenige Kilometer Luftlinie entfernt gut zu sehen ist) und der herrlichen intakten Natur sind die Berge der Abruzzen etwas ganz Besonderes, ABRUZZEN ITALIEN 3 der Abruzzen das den Besucher tief berühren kann. -

A.R. Staffa – La Transumanza in Abruzzo Fra Tarda Antichità E
european journal of ppostclascsicalarchaaeologies volume 10/2020 SAP Società Archeologica s.r.l. Mantova 2020 pca EDITORS EDITORIAL BOARD Gian Pietro Brogiolo (chief editor) Paul Arthur (Università del Salento) Alexandra Chavarría (executive editor) Margarita Díaz-Andreu (ICREA - Universitat de Barcelona) José M. Martín Civantos (Universidad de Granada) ADVISORY BOARD Girolamo Fiorentino (Università del Salento) Martin Carver (University of York) Caterina Giostra (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) Matthew H. Johnson (Northwestern University of Chicago) Susanne Hakenbeck (University of Cambridge) Giuliano Volpe (Università degli Studi di Foggia) Vasco La Salvia (Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti e Pescara) Marco Valenti (Università degli Studi di Siena) Bastien Lefebvre (Université Toulouse - Jean Jaurès) Alberto León (Universidad de Córdoba) ASSISTANT EDITOR Tamara Lewit (University of Melbourne) Federico Marazzi (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli) Francesca Benetti Dieter Quast (Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz) Andrew Reynolds (University College London) Mauro Rottoli (Laboratorio di archeobiologia dei Musei Civici di Como) Colin Rynne (University College Cork) Post-Classical Archaeologies (PCA) is an independent, international, peer-reviewed journal devoted to the communication of post-classical research. PCA publishes a variety of manuscript types, including original research, discussions and review ar - ticles. Topics of interest include all subjects that relate to the science and practice of archaeology, particularly multidiscipli - nary research which use specialist methodologies, such as zooarchaeology, paleobotany, archaeometallurgy, archaeome - try, spatial analysis, as well as other experimental methodologies applied to the archaeology of post-classical Europe. Submission of a manuscript implies that the work has not been published before, that it is not under consideration for publication elsewhere and that it has been approved by all co-authors. -

L'arte Del Casaro
Introduzione p1_Layout 1 17/05/16 16:13 Pagina 1 Repertorio dei formaggi e delle imprese selezionate per il “PREMIO ROMA” 2016 L’Arte del Casaro Introduzione p. 3 I vincitori p. 7 Storia e qualità del formaggio p. 17 L’analisi sensoriale del formaggio p. 27 Sezione Roma p. 33 Sezione Lazio p. 55 Sezione Nazionale p. 101 Sezione Internazionale p. 173 Introduzione p1_Layout 1 17/05/16 16:13 Pagina 2 2 Introduzione p1_Layout 1 17/05/16 19:30 Pagina 3 L’Arte del Casaro Il Concorso Formaggi “Premio Roma” è lo The Cheese Awards “Premio Roma” are an strumento fondamentale previsto dal programma important tool conceived within the programme for di miglioramento del settore lattiero-caseario the improvement of the dairy sector, implemented realizzato dalla Camera di Commercio di Roma by the Rome Chamber of Commerce through its attraverso la sua Azienda Speciale, ARM - Azienda Special Agency, ARM - Azienda Romana Mercati. Romana Mercati. The Awards, this year in the thirteenth edition, are Giunto alla sua tredicesima edizione, il Concorso, carried out in cooperation with Arsial and realizzato in collaborazione con Arsial ed Unioncamere Lazio; they have become a focal point Unioncamere Lazio, è divenuto indiscutibilmente not only for the Roman dairy companies, but also un punto di riferimento non solo per le aziende del for the regional and national ones. This year’s territorio romano, ma anche per quelle laziali e statistics confirm a positive trend: 132 companies nazionali. E sono soprattutto i numeri di questa from 18 regions that have competed with over 340 ultima edizione a confermarlo: 132 aziende di 18 samples divided in 22 categories. -

Immigrant Shepherds in Southern Europe
E-PAPER Immigrant Shepherds in Southern Europe MICHELE NORI Published by Heinrich Böll Foundation, June 2017 Immigrant Shepherds in Southern Europe by Michele Nori Contents Summary 3 Foreword 3 Agricultural Developments 4 Mediterranean Rural Migrations 7 Migrant Shepherds 10 An In-Depth Restructuring 13 Conclusions and Reccomendations 21 Appendix 23 Bibliography 25 The Author 29 Imprint 29 Summary This paper examines recent evolutions of agro-pastoral systems in the Mediterranean EU (EUMed), and problems faced following the territorial polarization and sectoral restruc- turing that the region has undergone in recent decades. In most southern EU regions the growing presence of immigrants has come to counterbalance the decline and ageing of the local rural populations and agricultural workforce. This paper specifically examines the presence, contribution and role of immigrant shepherds, who reached Southern Europe from other pastoral areas in the Mediterranean and provide skilled labour at a relatively low cost. Although this phenomenon seems to reproduce patterns of mobility that have characterized Mediterranean pastoralism in the last century, there are problems regarding the integration and training of such a workforce, which has to be undertaken in order to tackle the generational renewal of the sector – and of the rural areas within the European Union in general. Foreword At a recent conference on conflict and crisis in agriculture there were presentations from different regions of the globe. While participants from some countries stated that lack of water was constraining agricultural production (Egypt, Somalia), others maintained that in their country a lack of farm land was the limiting factor (Ethiopia), and others still stressed that in some African countries such as South Sudan vector-borne diseases are seriously affecting agricultural livelihoods.