Storia Della Botanica.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

HPB) Database Breaks the 3 Million Records Barrier
http://www.cerl.org Issue No. 23 July 2011 ISSN 1680-4546 (appears twice a year) Heritage of the Printed Book (HPB) Database breaks the 3 million records barrier With the completion of the update to the SBN(A) records provided An invitation to contribute to by the Istituto Centrale per il Catalogo Unico in Rome, which the HPB and the CERL provided over half a million new records, the HPB has finally broken Thesaurus the barrier of 3 million records. The total number now stands at 3,462,212 bibliographical descriptions. Please contact Marian Lefferts or DCG Göttingen to arrange for Another file that was contributed to the HPB is that of the University new additions to the HPB Library of Wroław. This data set of just over 1,500 MARC21 records Database from your institution was processed very rapidly, and complements the records from the or one of its affiliates. Updates Polish Microform project in that the records contain detailed copy- to existing files are also welcome. specific information for the items they describe Preferred formats remain MARC21 and UNIMARC. Hotlinking The display of hotlinks for records connected via the MARC21 subfield $w in the 76x-78x fields in FirstSearch was implemented for most fields on 15 May 2011. These “hotlinks” allow a searcher to move easily to records for related resources such as supplements, “bound withs”, individual volumes of multi- volume works, etc. It is especially fortunate that this new feature was implemented shortly after the load of the SBN(A) file because it makes it much easier for HPB users to explore the hierarchical structure of multivolume works in these Italian records. -

BCT1 (Fondo Miscellaneo). Archivi Di Persone 2018
BCT1 (Fondo miscellaneo). Archivi di persone 2018 A PRATO, GIOVANNI (1812-1883) COLLOCAZIONE: BCT1–2460, BCT1–5694/4-7 DESCRIZIONE: 1. Carteggio - 1859, minuta di una lettera indirizzata a un’imprecisata autorità politico-amministrativa del Tirolo italiano: BCT1–5694/6 - 1882, biglietto senza indirizzo: BCT1–5694/4 2. Scritti - 1869, Di un offertorio in versi, breve studio: BCT1–5694/5 - Nelle feste del centenario di Dante, dedicando il Comune di Trento a 14 maggio 1865 un busto del divino poeta scolpito da Andrea Malfatti: BCT1–2460 A PRATO, INNOCENZO (1550-1615) COLLOCAZIONE: BCT1–4-8 DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti NOTE: i BCT1–5-8 sono copie del BCT1–4 DESCRIZIONE: 1. Scritti - Historia Tridentinae Civitatis et totius Episcopatus ab Innocentio a Prato composita: BCT1– 4 - Tridentinae Civitatis Commendabilia totiusque Episcopatus Historia, ab Innocentio a Prato composita, copie del sec. XVIII: BCT1–5-8 ADAMI, SAVERIO (1885-1981) COLLOCAZIONE: BCT1–5942 DESCRIZIONE: 1. Scritti - Nani Carlo, poeta, musico, pittore: note biografiche (contiene 15 fotografie): BCT1–5942 ALBERTI, FRANCESCO ANTONIO COLLOCAZIONE: BCT1–66 ESTREMI CRONOLOGICI: 1690 DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: Antonio Mazzetti DESCRIZIONE: 1. Scritti - 1690, Indice alfabetico ragionato dei documenti dell’archivio vescovile riguardanti la Chiesa e il Principato di Trento: BCT1–66 ALBERTI D’ENNO, FRANCESCO FELICE (1701-1762) 1 BCT1 (Fondo miscellaneo). Archivi di persone 2018 COLLOCAZIONE: BCT1–9-14, BCT1–1065, BCT1–1168-1169, BCT1–2111/4, BCT1–2111/5 ESTREMI CRONOLOGICI: 1747-1761 NOTE: Contiene alcuni scritti, tra i quali è nota l’opera in più volumi composta durante l’attività di ricerca presso gli archivi del Principato vescovile e del Capitolo del Duomo di Trento DATA DI ACQUISIZIONE E PROVENIENZA: BCT1–9, BCT1–11-14 vedi Mazzetti, Antonio; BCT1–10 donato nel 1856 da Giovanni Zanella e collocato assieme ai mazzettiani; BCT1–2111/4 donato nel 1852 dal barone Sigismondo Trentini; BCT1–2111/5 donato nel 1852 dal conte Matteo Thun DESCRIZIONE: 1. -

L'attività Botanica Di Enrico Gelmi
F. FESTI e F. PROSSER: L’attività botanica di Enrico Gelmi... 101 FRANCESCO FESTI e FILIPPO PROSSER L’ATTIVITÀ BOTANICA DI ENRICO GELMI (TRENTO, 1855-1901) ED IL CATALOGO DEL SUO ERBARIO ABSTRACT - FESTI F. e PROSSER F., 2008 - The botanical activity of Enrico Gelmi (Trento, 1855-1901) and the catalogue of his herbarium. Atti Acc. Rov. Agiati, a. 258, 2008, ser. VIII, vol. VIII, B: 101-312. Enrico Gelmi (1855-1901) was one among the most active explorers of the flora in Trentino (Province of Trento - Northern-Italy) during the last decades of XIX cen- tury. This paper outlines his biographical sketch from a scientific point of view, most- ly using data coming from his herbarium, at present housed in the Museo Tridentino di Scienze Naturali, where it is one of the most important historical nuclei. The par- tially annotated catalogue of the herbarium, completely revised by the authors, is pre- sented too; the samples personally collected by Gelmi and the ones coming from oth- er collectors are separately considered. KEY WORDS - Enrico Gelmi, Herbarium, Vascular plants, Trentino. RIASSUNTO - FESTI F. e PROSSER F., 2008 - L’attività botanica di Enrico Gelmi (Trento, 1855-1901) ed il catalogo del suo erbario. Enrico Gelmi (1855-1901) è stato uno dei più attivi esploratori della botanica tridentina negli ultimi decenni del secolo XIX; ne viene qui delineato il profilo scien- tifico, desunto principalmente dal suo erbario, che è attualmente custodito presso il Museo Tridentino di Scienze Naturali e ne costituisce uno dei nuclei storici più im- portanti. Si presenta altresì il catalogo, parzialmente commentato, dell’erbario stesso, interamente sottoposto a revisione; vengono considerati separatamente i campioni raccolti personalmente da Gelmi e quelli provenienti da altri raccoglitori. -

Luciano Polonelli
Luciano Polonelli Department of Biomedical, Biotechnological and Translational Sciences, Unit of Microbiology and Virology, University of Parma, Parma, Italy Tel.: +39 0521 903429; Fax: +39 0521 993620; e-mail: [email protected] History of Medical Mycology File 2 (1895-1950) 1895 Giuseppe Marconi (1862-1940), born in Naples, Italy, Professor of Veterinary Pathology and Clinic in the Royal University of Pisa, Italy, isolated and cultivated for the first time Cryptococcus farciminosum, the agent of epizootic lymphangitis, in the form of sterile mycelium (1895). Piero Redaelli and Raffaele Ciferri transferred (1934) C. farciminosum to the genus Histoplasma, as H. farciminosum (Rivolta and Micellone 1883, Redaelli and Ciferri 1934), mainly because of its dimorphic nature that made it similar to the tissue form of H. capsulatum var. capsulatum Darling 1906. Robert J. Weeks, Arvind A. Padhye and Libero Ajello, at the Division of Mycotic Diseases, Center for Infectious Diseases, Centers for Disease Control (C.D.C.) Atlanta, Georgia, U.S.A. (1985), observed that this fungus generated macro- and microconidia resembling those of the capsulatum and duboisii varieties of H. capsulatum when incubated at room temperature, thus reducing the fungus to a varietal status as H. capsulatum var. farciminosum (Rivolta, 1873) Weeks, Padhye & Ajello, 1985. Raffaele Ciferri (1960) reduced Histoplasma duboisii (Vanbreuseghem, 1992) to varietal status as H. capsulatum var. duboisii (Vanbreuseghem, 1992), Ciferri, 1960 [Ajello, 1998; Marcone, 1895; Redaelli and Ciferri, 1934; Weeks et al., 1985]. 1 1896 The American surgeon Emmet Rixford (1865-1938), born in Bedford, Canada, first graduated in engineering and then Doctor in Medicine (1891), and Thomas C. -

Luciano Polonelli
Luciano Polonelli Department of Biomedical, Biotechnological and Translational Sciences, Unit of Microbiology and Virology, University of Parma, Parma, Italy Tel.: +39 0521 903429; Fax: +39 0521 993620; e-mail: [email protected] History of Medical Mycology File 3 (1951-1982) 1951 Lucille Katharine Georg, dead on 1980, former President of the Medical Mycological Society of the Americas (M.M.S.A.), Libero Ajello and Morris A. Gordon, at the Communicable Disease Center (C.D.C.) in Atlanta, Georgia, U.S.A., included cycloheximide in a mycological medium, named “mycobiotic agar” or “Mycosel”, for the selective isolation of Coccidioides immitis (1951). The medium, integrated with the antibiotic at low concentrations, inhibiting the growth of saprophytic fungi but also of some pathogens (such as Cryptococcus neoformans), had a great impact in the mycological culture studies [Espinel- Ingroff, 1996; Georg et al., 1951]. Morris A. Gordon, of the Laboratories for Mycology and Mycobacteriology, Infectious Disease Institute, Centers for Laboratories and Research, New York State Department, Albany, New York, U.S.A., then at the Communicable Disease Center (C.D.C.), reported that he had succeeded to cultivate “spherical forms” of Malassezia furfur (Pityrosporum orbiculare) by including olive oil or saturated fatty acids in Sabouraud dextrose agar [Espinel-Ingroff, 1996; Gordon, 1951]. Edward E. Evans and John F. Kessel, from the Department of Medical Microbiology, School of Medicine, University of Southern California, Los Angeles, California, U.S.A., described, 1 on the basis of previous studies by Evans himself, that Cryptococcus neoformans may be distinguished into three serological types, A, B and C, according to the antigenic differences detectable by agglutination reactions (1951). -
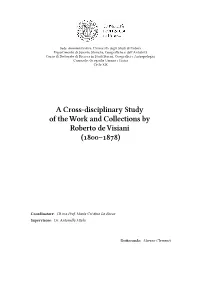
A Cross-Disciplinary Study of the Work and Collections by Roberto De Visiani (1800–1878)
Sede Amministrativa: Università degli Studi di Padova Dipartimento di Scienze Storiche, Geografche e dell’Antichità Corso di Dotorato di Ricerca in Studi Storici, Geografci e Antropologici Curricolo: Geografa Umana e Fisica Ciclo ⅩⅨ A Cross-disciplinary Study of the Work and Collections by Roberto de Visiani (1800–1878) Coordinatore: Ch.ma Prof. Maria Cristina La Rocca Supervisore: Dr. Antonella Miola Dottorando: Moreno Clementi Botany: n. Te science of vegetables—those that are not good to eat, as well as those that are. It deals largely with their fowers, which are commonly badly designed, inartistic in color, and ill-smelling. Ambrose Bierce [1] Table of Contents Preface.......................................................................................................................... 11 1. Introduction.............................................................................................................. 13 1.1 Research Project.......................................................................................................13 1.2 State of the Art.........................................................................................................14 1.2.1 Literature on Visiani 14 1.2.2 Studies at the Herbarium of Padova 15 1.2.3 Exploration of Dalmatia 17 1.2.4 Types 17 1.3 Subjects of Particular Focus..................................................................................17 1.3.1 Works with Josif Pančić 17 1.3.2 Flora Dalmatica 18 1.3.3 Visiani’s Relationship with Massalongo 18 1.4 Historical Context...................................................................................................18 -

The Fungal Collection of the Jagiellonian University Herbarium (KRA), Kraków, Poland
ISSN (print) 0093-4666 © 2012. Mycotaxon, Ltd. ISSN (online) 2154-8889 MYCOTAXON http://dx.doi.org/10.5248/120.127 Volume 120, pp. 127–132 April–June 2012 The fungal collection of the Jagiellonian University Herbarium (KRA), Kraków, Poland Anna Maria Ociepa1, Szymon Zubek2 & Piotr Mleczko 2* 1W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences & 2Institute of Botany, Jagiellonian University ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, Poland * Correspondence to: [email protected] Abstract — The paper presents a short history of the mycological collection of the Jagiellonian University Herbarium (KRA, Kraków, Poland). The Herbarium holds over 22,000 specimens, including some interesting European and extra-European fungal exsiccata. One of the most valuable fungal collections (including many type specimens) in the Herbarium is that containing Javanese fungi gathered by Marian Raciborski at the end of 19th century. Key words — fungi of Pieniny Mts., fungi of Gorce Mts., ascomycetes, basidiomycetes, Peronospora The history The origin of the Jagiellonian University Herbarium dates back to 1780, when the Faculty of Chemistry and Natural History was established, and with it the Natural History Room (Köhler 1999; Köhler 2001a). The Herbarium, which was long associated with the Chair of Botany at the Botanical Garden, is now part of the Institute of Botany of Jagiellonian University. The first record of fungi being kept in the Herbarium dates from 1812, and the oldest specimen with a date placed on the label is from 1807 (Fig. 1). In the past the Herbarium collections served mainly an educational function (Köhler 2001b). Until 1910 each set of specimens, including purchased, exchanged, or donated exsiccata and collections, was kept separately and a taxonomic criterion was not applied to the Herbarium’s arrangement. -

Illustrated Holocene Era Timeline
Illustrated Holocene Era Timeline: Human Achievements, Advancements, Innovations, and Understanding in Science using EMILIANI’s HE calendar Ruthie S. Premack Author / Compiler Technical Advisor Paul Premack Phone Edition 12,019 HE I dedicate this book To: the wonderful man who is my husband Paul Premack, our adult children Tiffany and Benjamin, his wife Kira, my mother Jo Ann Simons Stier for their love, brains, attention to detail, laughter, and thoughtfulness and to my dad Herb Stier; To: CESARE EMILIANI, who first had the idea for the Holocene Era (HE) calendar; and To: any human who can open their mind to seeing the (HE) flow of human accomplishment and to being enchanted, shocked, disappointed, or amazed by the wonders and realities of science. © 2019 (12,019 HE), Ruthie S. Premack, all rights reserved. Any portion, but not the entirety, of this book may be reproduced without permission from the author so long as this book is cited as the source and entries are not altered. Some text in this Timeline is from or based upon entries in Wikipedia. Use is permitted because we have provided credit to the authors by including a URL to the page or pages used. All entries based upon Wikipedia materials is released under CC BY-SA: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Table of Contents ABOUT THE HE CALENDAR AND FORMATTING ............................... 7 AUTHOR / COMPILER’S PREFACE ........................................................ 10 CHAPTER ONE APPETIZERS ............................................................. 12 CHAPTER TWO BEFORE THE HOLOCENE ERA: THE BIG BANG TO THE STONE AGE .............................................. 45 CHAPTER THREE 1 HE: BEGINNING OF THE HOLOCENE ERA .................................................................................... -

Uomini, Storie, Serpenti Contributi Alla Storiografia Erpetologica Del Trentino-Alto Adige E Dintorni
Ann Mus civ Rovereto Sez: Arch, St, Sc nat Vol 17 (2001) 173-274 2002 PIETRO LORENZI & SILVIO BRUNO UOMINI, STORIE, SERPENTI CONTRIBUTI ALLA STORIOGRAFIA ERPETOLOGICA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE E DINTORNI Abstract - PIETRO LORENZI & SILVIO BRUNO - Men, Stories, Snakes Contribution to the herpeto- logical historiography of Trentino Alto Adige The knowledge of history and literature of the Italian herpetology, and of the lives of the naturalists professionals and amateurs who studied the regional or national herpetofauna are defective Since the late Seventies of the XX century the Italian herpetology has grown up, becoming a subject with academic dignity, but nevertheless the herpetologists often ignore out of presumption or unripeness - its classic publications, its historiography, and the activities and passions of its founders The general aim of this paper is to give a contribution to the Italian herpetological culture, in particular with the chronicles of the lives and researches of some of the most important herpetologists who studied the herpetofauna of Trentino Alto Adige especially the snakes Key words: History, Herpetologists, Biographies, Snakes, Reptiles, Trentino-Alto Adige Riassunto - PIETRO LORENZI & Silvio Bruno - Uomini, Storie, Serpenti Contributi alla storiografia erpetologica del Trentino-Alto Adige e dintorni Le conoscenze sulla storia e sulla letteratura dellerpetologia italiana, ma pure sulla vita dei naturalisti e non, professionisti e dilettanti, che si interessarono anche o unicamente di erpeto- fauna regionale -

Notable Historical Databases of Fungal Names
MycoLens is a section in IMA Fungus introduced for historical or topical commentaries and observations of potential interest to a wide range of mycologists, but which fall outside the scope of other sections of the journal. Notable historical databases of fungal names MYCOLENS Ronald H. Petersen1 and David L. Hawksworth2, 3, 4 1Ecology and Evolutionary Biology, University of Tennessee, Knoxville, TN 37996-1100, USA; corresponding author e-mail: [email protected] 2Department of Life Sciences, The Natural History Museum, Cromwell Road, SW7 5BD London, UK 3Departamento de Biología Vegetal II, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid, Plaza Ramón y Cajal, Madrid 28040, Spain 4Comparative Plant and Fungal Biology, Jodrell Laboratory, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, TW9 3DS, UK Abstract: Present-day electronic databases of fungal names are 21st century versions of previous compilations for the same purpose. The comprehensive indices attached to books by Persoon and Fries summarized names known at those times. Later compilations appeared piecemeal in journals or free-standing, always improving but hardly available for “rapid retrieval.” Twentieth century Index of Fungi required tedious data entry from thousands of journals over many years, but the result could later be inserted into electronically retrievable computer programs. Index Fungorum includes data harvested from Index of Fungi, but perhaps its major source has been Saccardo’s Sylloge Fungorum, probably the most prodigious compilation of the 19th–20th century. Names for lichen-forming fungi were gleaned from the catalogues of Zahlbruckner and Lamb. The role of the Commonwealth Mycological Institute, its predecessors and its successors, has been significant. Key words: compilations, nomenclators, name registration, Index Fungorum. -

Biographical Sketches of Deceased North American
Biographical Sketches of Deceased North American Mycologists including a few European Mycologists L. R. Hesler January 1975 FORWARD Ron Petersen University of Tennessee May 2020 For the first half of his long career, Lexemual Ray Hesler (1888-1977) was a plant pathologist. His interest in botany was sparked by his mentor at Wabash College (class of 1911), Mason Blanchard Thomas, professor of botany and horticulture. Thomas’ time at Wabash was marked by his uncanny identification of promising young men and encouraging them to continue their studies at leading universities. But that is only one side of the equation. Once a student was discovered, graduate studies required funds to pay for tuition, books, board, and room. Often, a former student, now on the faculty of a more comprehensive university (Yale and Cornell come to mind), made arrangements for an earmarked fellowship. Hesler benefited by such. Herbet Hice Whetzel (Wabash class of 1902, by 1911 head of the Department of Plant Pathology at Cornell University) arranged a fellowship for Hesler assisting apple growers in upstate New York in the summer of Hesler’s graduation from Wabash. In September, Hesler enrolled at Cornell in plant pathology. The next three summers were spent in the orchards. There followed the Cornell Ph. D. in 1914, and retention on the Cornell Plant Pathology Department faculty until his move to Tennessee in 1919. At Tennessee, administrative duties (i.e. Head of the new Department of Botany and later Dean of the College of Liberal Arts until his retirement in 1958) reduced research time, but his plant pathological interests didn’t flag.