Santuario San Nicolo!
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
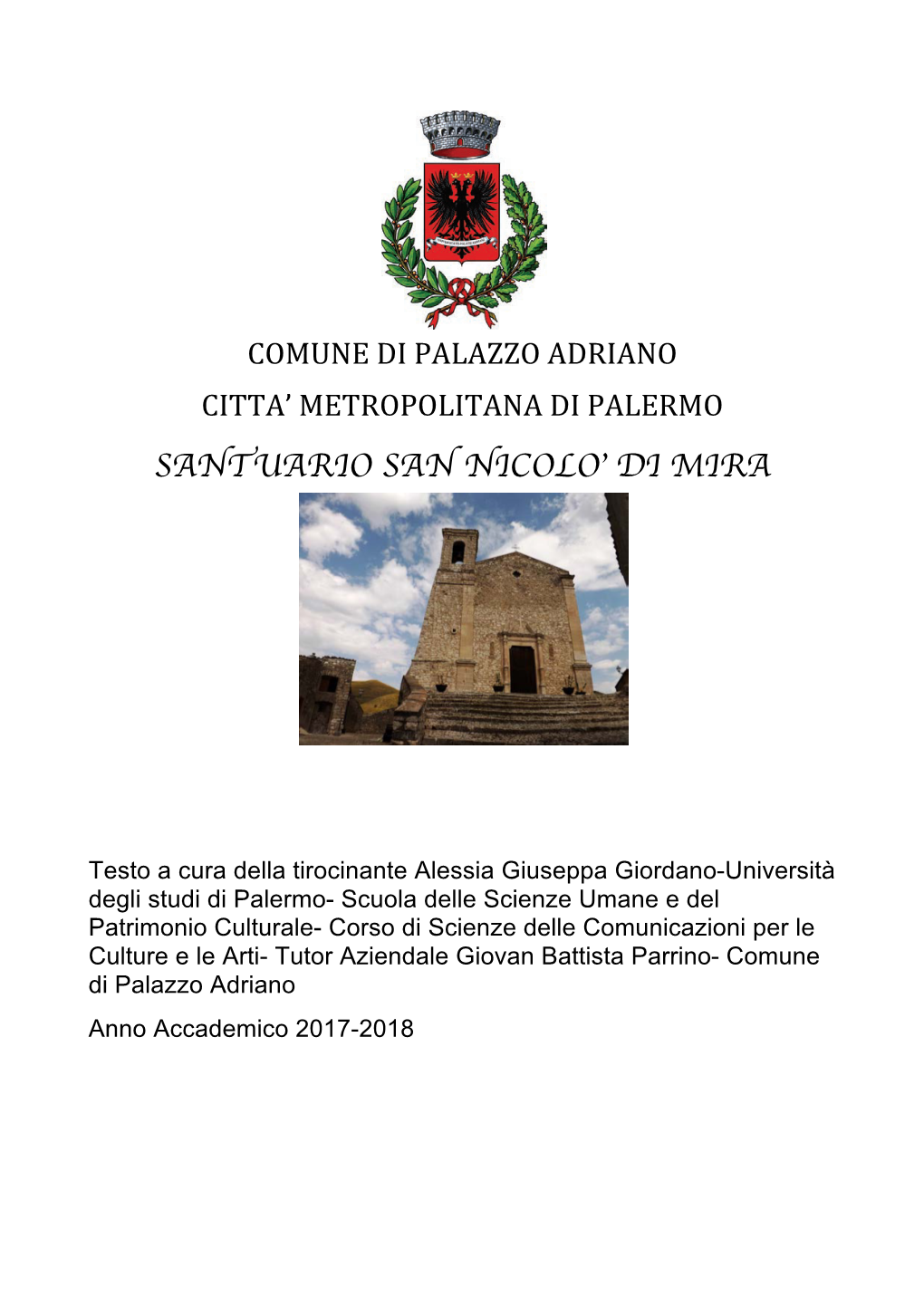
Load more
Recommended publications
-

Motorcycle Tour Italy, Sicily: the Land of the Sun
Motorcycle tour Italy, Sicily: the Land of the Sun. Motorcycle tour Italy, Sicily: the Land of the Sun. Duration Difficulty Support vehicle 8 días Easy Ja Language Guide en,it Ja "How many have not at least longed to know her? Few or none; the fame of her beauty is so universal, so much the memory of it goes together with the history of the most widespread civilizations" (TCI) ... "nation more than region and moreover a nation plural, so many are the different identities "(Bufalino) ..." Italy without Sicily leaves no image in the spirit: only here is the key to everything ". (Goethe) ... There are hundreds of quotes from poets, storytellers and travelers that exalt and tell about Sicily, an infinite island full of dreams and charm. Telling about Sicily, its streets, its history, a millenary culture, experienced on a motorcycle represents a set of emotions. Describing the colors, the smells, the traditions of a land full of charm lead to a unique dream that every motorcyclist should live. Every journey is like a story that becomes a common thread between the different destinations, the routes and the meetings with original people will make you understand that every Sicilian is a world in itself, always with the great desire to tell stories and tell stories. Our journey starts from Palermo to take us in eight days around the island with a path that will make us discover roads such as the SS 185 that connects the Tyrrhenian Sea to Etna, passing through wonderful villages like Novara di Sicilia where it will seem to return back in time, the bell towers of its many churches that dominate the town and the cheerful and serene voices of its people will take us back to the holidays. -

Cenni Storici Historical Background
INTRODUZIONE INTRODUCTION Alto Belice Corleonese Cenni storici Historical background L’Alto Belice Corleonese si estende a Sud di Palermo, verso Alto Belice Corleonese lies south of Palermo,towards the interi- l’interno.Le prime notizie storiche lo danno popolato dalla or.The first historical notices tell us the area was populated by popolazione indigena degli Elimi,a Nord Ovest,e dai Sicani, the native population of the Elymians,to the northwest,and a Sud.Questi ultimi daranno il nome alla catena montuosa the Sicani,to the south.The latter were to give the name to the che interessa l’area sud dell’Alto Belice Corleonese. mountain chain in the southern area of Alto Belice Corleonese. In epoca classica e medievale, il comprensorio segue le In the classical and medieval ages,the area underwent the his- vicende storiche siciliane:la colonizzazione greca e cartagi- torical vicissitudes of all Sicily:Greek and Carthaginian coloniza- nese,le guerre puniche,l’affermazione dei Romani,le inva- tion,the Punic wars,the triumph of the Romans,barbaric inva- sioni barbariche,la presenza bizantina,la conquista araba. sions,the presence of the Byzantines,and the Arab conquest. I Normanni fondano Monreale (sec.XII),la città più impor- The Normans founded Monreale (12th century),the most tante del distretto, e la dotano di un ampio territorio, important town in the area,and they gave it a big territory,the nucleo fondante di quello dell’Alto Belice Corleonese. founding nucleus of that of Alto Belice Corleonese. L’imperatore Federico II di Svevia nel Duecento distrugge le In the thirteenth century the emperor Frederick II of Swabia ultime roccaforti dei ribelli arabi,asserragliati presso anti- destroyed the last strongholds of the Arab rebels,barricaded in 4 INTRODUZIONE INTRODUCTION old towns,today important archaeological sites like Ietas and Entella. -

Influenced Transplantation: a Study Into Emerging Mafia Groups in The
Influenced Transplantation: A Study into Emerging Mafia Groups in the United States pre-1920 Simon May Submitted version deposited in Coventry University’s Institutional Repository Original citation: May, S. (2017) Influenced Transplantation: A Study into Emerging Mafia Groups in the United States pre-1920 . Unpublished PhD Thesis. Coventry: Coventry University. Copyright © and Moral Rights are retained by the author. A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. This item cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the copyright holder(s). The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. Some materials have been removed from this thesis due to Third Party Copyright. Pages where material has been removed are clearly marked in the electronic version. The unabridged version of the thesis can be viewed at the Lanchester Library, Coventry University. Influenced Transplantation: A Study into Emerging Mafia Groups in the United States pre-1920 By Simon May May 2017 A thesis submitted in partial fulfilment of the University’s requirements for the Degree of Doctor of Philosophy 1 2 REGISTRY RESEARCH UNIT ETHICS REVIEW FEEDBACK FORM (Review feedback should be completed within 10 working days) Name of applicant: Simon May ...................................... Faculty/School/Department: [Business, Environment and Society] International Studies and Social Science .................................................................. Research project title: PHD on Organised Crime: Links between pre-prohibition mafias in the US and Sicily Comments by the reviewer 1. Evaluation of the ethics of the proposal: 2. -

Guida All'ospitalità
Altofonte Belmonte Mezzagno Bisacquino Bolognetta Campofiorito Camporeale Cefalà Diana Chiusa Sclafani Contessa Entellina Corleone Giuliana Godrano Marineo Mezzojuso Monreale Palazzo Adriano Piana degli Albanesi Prizzi Roccamena San Cipirello San Giuseppe Jato Santa Cristina Gela Villafrati Alto Belice Corleonese Guida dell’ospitalità Hospitality guide L’Alto Belice Corleonese Cenni storici L’Alto Belice Corleonese si estende a Sud di Palermo, verso l’interno. Le prime notizie storiche lo danno popolato dalla popolazione indigena degli Elimi, a Nord-Ovest, e dai Sicani, a Sud. Questi ultimi daranno il nome alla catena montuosa che interessa l’area meridionale dell’Alto Belice Corleonese. In epoca classica e medioevale,il comprensorio segue le vicende storiche siciliane:la colonizzazione greca e cartaginese,le guerre puniche,l’af- fermazione dei Romani,le invasioni barbariche,la presenza bizantina,la conquista araba. I Normanni fondano Monreale (sec. XII), la città più importante del distretto, e la dotano di un ampio territorio, nucleo fondante di quello dell’Alto Belice Corleonese. L’imperatore Federico II di Svevia nel Duecento distrugge le ultime roccaforti dei ribelli arabi,asserragliati presso antiche città,oggi importanti siti archeologici,come Ietas ed Entella. Al tempo dei Vespri siciliani (sec.XIII),il Senato di Palermo e la città di Corleone si alleano contro gli Angioini,e il vessillo che issano porta il colo- re giallo di Palermo e quello rosso della rivoluzione,scelto da Corleone.Questi colori diventeranno quelli della bandiera siciliana. Alla fine del Quattrocento,gruppi di coloni albanesi,in fuga dall’invasione turca,fondano i centri abitati di Piana degli Albanesi,Palazzo Adriano, Contessa Entellina,Mezzojuso,Santa Cristina Gela,conservando sino ad oggi la lingua,le tradizioni,il rito religioso greco. -

ORARI in VIGORE DAL 29.06.2020 Internet
ORARI ESTIVI PROVVISORI IN VIGORE DAL 29 - 06 - 2020 Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. Struttura Territoriale Occidentale - Sede di Palermo A U T O L I N E E CO L L E G A M E N T I 1 Altavilla/Casteldaccia/A.19/Palermo 2 Altavilla/San Nicola/Trabia/Termini Imerese 3 Altofonte/Palermo 4 Sant'Elia/Aspra/Bagheria/Palermo 5 Bagheria/Santa Flavia/Casteldaccia/Altavilla 6 Burgio/Prizzi/Palazza A./Chiusa S./Corleone/Marineo/Palermo O 7 Campofelice di Fitalia/Mezzojuso/Villafrati/Palermo 8 Carini/Torretta/Capaci/Isola/Sferracavallo/Palermo R 9 Castelbuono/Isnello/Collesano/Campofelice di Roccella/Cefalù 10 Castelbuono/Collesano/Termini Imerese/Palermo A 11 Corleone/S.Cipirello/S.Giuseppe/Partinico 12 Godrano/Cefalà Diana/Villafrati/Bolognetta/Misilmeri/Villabate/Palermo 13 Monreale/Palermo R E 14 Montevago/S.Margherita/Salaparuta/S.S. 624/S.Giuseppe /Palermo 15 Partanna/A.29/Palermo I S 17 Partinico/Borgetto/Pioppo/Palermo 18 Partinico/Giardinello/Montelepre/Palermo T 2 19 Palazzo Adriano/Prizzi/Castronovo/Lercara/Vicari/Palermo 20 Roccamena/Camporeale/S.Cipirrello/S.Giuseppe/Pioppo/S.S. 624/Palermo I 0 21 Termini Imerese/Ventimiglia/Ciminna/Baucina/Misilmeri/Palermo 22 Terrasini/Cinisi/Capaci/Palermo 23 Modica-Palermo V 2 I 0 Informazioni: Direzione via Ugo La Malfa, 40 - Palermo -Tel. 091.6800011 Biglietteria Piazzale J. Lennon Palermo -Tel. 091.6858015 internet: www.aziendasicilianatrasporti.it Direzione Via Ugo La Malfa Palermo - Tel. 091.6800011 ORARIO FERIALE ESTIVO PROVVISORIO N° 1 Biglietteria Piazzale Lennon Palermo -Tel. 091.6858015 AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.p.A. IN VIGORE DAL 15.06.2020 www.aziendasicilianatrasporti.it Autolinea: PALERMO-A 19-CASTELDACCIA-ALTAVILLA 5436 8701 8703 turni 8701 5436 8703 senso senso FERMATE 1 2 3 marcia marcia 4 5 6 NOTE A 13:10 18:00 PALERMO LENNON 7:55 16:40 7:30 13:35 18:25 PALERMO G.CESARE 7:30 9:00 16:15 8:00 14:05 18:55 CASTELDACCIA 7:00 8:30 15:45 8:15 14:30 19:10 ALTAVILLA 6:45 8:15 15:30 Prescrizioni di esercizio: A) Prosegue per via Ernesto Basile. -

Il Monastero Di Mezzojuso Nella Storia Culturale Arbëreshe*
Pietro Di Marco Il Monastero di Mezzojuso nella storia culturale arbëreshe* Nel 1131 e nel 1133 due diplomi regi1 disponevano che tutti i monasteri greci di Sicilia dovevano dipendere da quello del SS.mo Salvatore di Messina, che veniva elevato ad archimandritato.2 Fu così inaugurato il sistema federativo, applicato, alcu- ni decenni più tardi, da Guglielmo II (1168) ai monasteri della Calabria e della Basi- licata. Ciò, insieme alla politica ostile degli Aragonesi, alla ricchezza dei monasteri passati in commenda a cardinali e dignitari, al progressivo assottigliarsi dell’elemento greco (diminuito, il numero dei monaci greci veniva sostituito dagli i- talioti: l’ignoranza della lingua greca cedeva il passo al volgare) causò la decadenza del monachesimo italo-greco. Non era più il tempo dei sovrani normanni o svevi, quando dall’Italia meridionale si inviavano alle università di tutta l’Europa le tradu- * Questo saggio riproduce il testo di una relazione presentata al Convegno storico «Padre Gior- gio Guzzetta e la cultura del suo tempo», Palermo, Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio (Martora- na), 23 marzo 2007. L’articolo è già stato pubblicato sul sito www.jemi.it. 1 Il primo datato: Palermo, maggio 1131. Cfr. Cod. Vaticanus Latinus 8201 (Bolle e diplomi di ogni genere latini e greci per l’archimandritato di Messina dell’ordine di S. Basilio dal sec. XI - all’anno 1536), fol. 128r v; S. CUSA, I diplomi greci ed arabi di Sicilia pubblicati nel testo originale, tradotti ed illustrati, Palermo 1868-1882, vol. I, p. 292, trad. lat. in Vat. Lat. cit, fol. 269; e R. -

Tra Il Dire E Il Fare Cod
GRADUATORIA DEFINITIVA ENTE: AREA AZZURRA SOC. COOP. SOCIALE AR. L. COD. ENTE: NZ01031 PROGETTO: TRA IL DIRE E IL FARE COD. PROG.: R19NZ0103117103611NR19 SEDE DI CONDRO' Cognome Nome Data di nascita Idoneo Sel. Punteggio 1 SCHEPIS GIOSUè 08/08/1997 SI SI 68 2 RUSSO SIMONA 22/02/1998 SI SI 65,83 3 LOMBARDO MATTIA 04/05/1998 SI SI 64,5 4 ISAIA CARMEN 24/10/1993 SI SI 64,33 SEDE DI FICARAZZI DI PALERMO Cognome Nome Data di nascita Idoneo Sel. Punteggio 1 BLANDO DOMENICO 10/09/1992 SI SI 64,47 2 MACCHIARELLA DEBORAH 08/11/1989 SI SI 64,2 3 FANALE FRANCESCO 08/09/1993 SI SI 63,83 4 SAVERINO VITO 23/07/1990 SI SI 61,33 5 FANARA SIMONA 08/06/1996 SI SI 60,83 6 SORCI MARTINA EMANUELA 26/05/1993 SI SI 60,33 CINISI GIUSEPPE 25/01/1991 SI NO 57,17 CINISI GIANLUCA 12/01/1994 SI NO 53,67 TERRANOVA OMAR 14/09/1992 SI NO 53,33 D'ANIELLO ALESSIA 11/08/1997 SI NO 53 CINISI ONOFRIO GABRIELE 14/03/1995 SI NO 52,33 CINISI GIUSEPPE 11/03/1994 SI NO 47 SEDE DI BISACQUINO Cognome Nome Data di nascita Idoneo Sel. Punteggio 1 CAMPAGNA FILIPPO 11/01/1991 SI SI 66,33 2 CALDARERA MADDALENA 10/02/1998 SI SI 64,67 3 CACIOPPO MARIO 25/06/1992 SI SI 61,5 4 TAMBURELLO VINCENZO 23/11/1995 SI SI 61,33 5 MARINO SALVATORE 18/07/1992 SI SI 60,33 6 GENNUSA GIUSEPPE 16/06/1994 SI SI 59,67 SEDE DI SAN PIER NICETO Cognome Nome Data di nascita Idoneo Sel. -

Scaricate Lo Zolfo E Mi Date Il Carro; Ed Egli Prima Che Questo Non Posso Farlo Di Scaricare Lo Zolfo, Secondo È Questa La Prima Volta Che Vi Vedo, E Conosco a Lei
Storia Della Rivolta del 1856 in Sicilia Organizzata dal Barone Francesco Bentivegna In Mezzojuso e da Salvatore Spinuzza In Cefalù Entrambi traditi, vennero arrestati e fucilati Altre 24 persone ebbero sentenza di morte Dedicata alla Gioventù Italiana ROMA Tipografia Econ. Commerciale Piazza Sforza Cesarini 41 A. 1899 Spiridione Franco – Storia della Rivolta del 1856 in Sicilia - Mezzojuso Alla Gioventù Italiana, A voi giovani, dedico questo umile mio lavoro, dal quale emerge una breve pagina delle nostre sofferenze per arrivare alla sospirata mèta, l'unità della patria. Onoratelo di un vostro sguardo, e da esso apprenderete che a voi incombe il dovere di reclamare le altre provincie tuttavia soggette allo straniero qualunque sia il sacrifizio che vi possa costare. Non dimenticale che il 12 Gennaio 1848 la gioventù siciliana fu la prima ad insorgere contro la tirannide, seguita poscia dal Piemonte e da Milano. Battuti a Novara: non cessammo per questo di congiurare contro l'aborrita dinastia Borbonica. Lo stalo d’assedio ci opprimeva, come una cappa di piombo, tuttavia ognuno voleva un'arma, e la portava costantemente, per quanto le carceri rigurgitassero, le isole adiacenti fossero tutte popolate di delinquenti politici, molti sfuggissero al capestro esulando e cento altri cadessero sotto il piombo nemico. Fra tanti martiri non va dimenticato Nicolò Garzilli studente di medicina, fucilato in Palermo nel gennaio 1850 con altri cinque compagni. Nel novembre 1856 insorse in Mezzojuso, mia patria il barone Francesco Bentivegna, mentre Salvatore Spinuzza sollevava Cefalù. Traditi, entrambi vennero fucilati, il Bentivegna in Mezzojuso il 21 dicembre 1856, e lo Spinuzza in Cefalù il 14 Marzo 1857. -

Elenco Unificato Dei Giudici Popolari Di Corte Di Assise, Ex Art
Elenco unificato dei Giudici popolari di Corte di Assise, ex Art. 17 L.287/51. Comune di BAGHERIA N •JWJBPW DATA NASCITA COMUNE NASCITA i COMUNE RESIDENZA INDIRIZZO 1 Abbate Rosaria 01/01/1950 PALERMO BAGHERIA 2 Abbate Vincenza 03/07/1956 BAGHERIA BAGHERIA 3 Aiello Anna Maria 15/06/1959 BAGHERIA BAGHERIA 4 Aiello Giuseppa 07/05/1963 BAGHERIA BAGHERIA 5 Aiello Nunzia 24/08/1954 BAGHERAI BAGHERIA 6 Aiello Salvina 14/03/1952 MIRABELLA IMBACCARI (CT) BAGHERIA 7 Aiello Santo 09/04/1971 PALERMO BAGHERIA 8 Albanese Giovanna 12/11/1966 BAGHERIA BAGHERIA 9 Amico Maurizio 13/02/1959 PALERMO BAGHERIA 10 Anello Anna Maria Elena 11/08/1967 PALERMO BAGHERIA 11 Antera Riccardo 25/09/1974 MAZZARA DEL VALLO BAGHERIA 12 Arcuri Carla Maria 28/11/1963 PALERMO BAGHERIA 13 Ardizzone Roberto 23/05/1953 PALERMO BAGHERIA 14 Amò Rossana 28/08/1977 PALERMO BAGHERIA 15 Averna Francesco 27/01/1971 BAGHERIA BAGHERIA 16 Barca Giacomo Antonio 14/05/1964 G RATTE RI BAGHERIA 17 Bianca Susanna 21/11/1963 PALERMO BAGHERIA 18 Biosa Provvidenza 2.2/02/1952 BAGHERIA BAGHERIA 19 Bologna Giuseppe 26/05/1959 BAGHERIA (PA) BAGHERIA V 20 Bologna Rosa 22/06/1964 PALERMO BAGHERIA ^7 21 Bosio Maria 29/11/1966 PALERMO BAGHERIA 22 Buttitta Anna 07/08/1963 BAGHERIA (PA) BAGHERIA 23 Buttitta Ignazio 210/08/1970 PALERMO BAGHERIA 24 Caltagirone Francesco Paolo 12/10/1959 PALERMO BAGHERIA \ 25 Caltagirone Rosa 15/01/1957 BAGHERIA BAGHERIA 26 Cali Maddalena 11/01/1972 PALERMO BAGHERIA 27 Campanella Daniele 21/01/1977 PALERMO BAGHERIA 28 Carollo Grazia 15/11/1963 BAGHERIA BAGHERIA 29 Carollo -

ELENCO VEICOLI GIACENTI PRESSO DEPOSITERIE.Xlsx
TIPO TARGA /TELAIO STATO GIURIDICO CUSTODE GENERALITA' ARTICOLO VIOLATO ORGANO ACCERTATORE AUTOVETTURA AL296KR CONFISCA SCIANNA DOMENICO RIESI GIUSEPPE nato a Palermo il 14/02/1950 Articolo 193/2 Polizia Municipale di Ficarazzi (PA) AUTOVETTURA BD807VC CONFISCA SCIANNA DOMENICO RUSSO ROMANA nata a Tropea (VB) il 25/01/1958 Articolo 193/2 Polizia Municipale di Ficarazzi (PA) AUTOVETTURA AE220VS CONFISCA SCIANNA DOMENICO BUSCARELLO MARIA LAURETANA nata a Bagheria il 28/06/1967 Articolo 193/2 Commissariato di Polizia di Bagheria (PA) AUTOVETTURA PAB85124 SEQUESTRO SCIANNA DOMENICO BONANNO SALVATORE nato a Palermo il 27/04/1964 Articolo 193/2 Carabinieri stazione di Belmone Mezzagno (PA) AUTOVETTURA AM997PJ CONFISCA SCIANNA DOMENICO ANSELMO CLAUDIA nata a Palermo il 21/04/1987 Articolo 193/2 Polizia Stradale di Palermo AUTOVETTURA AB338PS SEQUESTRO SCIANNA DOMENICO CARUSO GIOVANNI nato a Catania il 19/10/1971 Articolo 193/2 Polizia Stradale di Buonfornello (PA) AUTOVETTURA CL562FZ CONFISCA SCIANNA DOMENICO CORTEGIANI AMEDEO nato a Palermo il 25/11/1980 Articolo 193/2 Polizia Stradale di Palermo AUTOVETTURA AV500HB CONFISCA SCIANNA DOMENICO RIZZO ROSA nata a Palermo il 13/07/1936 Articolo 193/2 Commissariato P.S. Bagheria (PA) AUTOVETTURA BR091FY SEQUESTRO SCIANNA DOMENICO DI SALVO FRANCESCO nato a Bagheria il 21/02/1955 Articolo 193/2 Commissariato P.S. Bagheria (PA) AUTOVETTURA BX959EG SEQUESTRO SCIANNA DOMENICO BARTOLONE ROSALBA ROSARIA NATA A Palermo il 19/08/1955 Articolo 193/2 Commissariato P.S. Bagheria (PA) AUTOVETTURA AG450KA SEQUESTRO -

Piana Degli Albanesi, Chiesa Di S
Benvenuti nella terra di Sha dcfbc:] She derbeut Welcome to the Ska derbe ' s lands 1. Contessa Entellina, Entella; 2. Mezzojuso, Chiesa della SS. Annunziata; 3. Pa• lazzo Adriano, Piazza Umberto I; 4. Piana degli Albanesi, Chiesa di S. Demetrio, Iconostasi (foto di G. Salerno); 5. Santa Cristina Gela, Piazza M. Polizzi, fontana. UNIONE DEI COMUNI LiDHJA E BASHKIVET UNION OF THE MUNICIPALITIES BESA PALERMO PALERME 2012 Questo opuscolo, curato dall'Unione dei Comuni BESA, è stato realizzato con risorse finanziarie ex L. 482/99, es. 200S. 2012 © Unione dei Comuni Lidhja e Bashkivet Unione dei Comuni BESA Unione dei Comuni BESA = Lidhja e Bashkivet BESA / Coordinamento Pietro Manali ; testi e traduzione Mimma Capaci. Giuseppina Cerniglia. - Palermo : Unione dei Comuni BESA, 2012. - 16 p. : ili. ; 21 cm. - (( Testo trilingue: Italiano - Arberesh - Inglese. 1. SIGILLA - Comunità i-\lbanesi. - Guide I. MANALI, Pietro II. CAPACI, Mimma ITI. CERNIGLIA. Giuseppina 914.945823 CDD21 Scheda catalografica a aira della biblioteca comunale "Giuseppe Schirò" di Piana degli Albanesi COORDINAMENTO: Pietro Manali TESTI E TRADUZIONI: Mimma Capaci, Giuseppina Cerniglia. addette agli sportelli linguistici ex L. 482/99 (Es. 2008). PROGOTTO GRAFICO: Iolanda Vassallo. HANNO COLLABOR.^TO: Giovanna Schirò (Contessa Entellina) Andrea Tavolacci (Mezzojuso) Carmela Di Giovanni (Palazzo Adriano) Sara Cuccia (Piana degli Albanesi) Luisa Loffredo (Santa Cristina Gela) ^ STAMPA: Tipolitografìa Luxograph srl - Palermo (Settembre 20]2) Gli Arbèreshè La presenza degli Italoalbanesi (Arbèreshè) in Sieìlia risale alla seconda metà del se• colo XV quando i turchi invasero i Balcani provocando, tra l'altro, la prima vera grande diaspora albanese (shqipetara). Da oltre cinquecento anni, quali tratti della loro identità, gli Arbèreshè conservano con grande cura lingua, costumi, tradizioni e rito bizantino-greco e costituiscono un'en• clave di cultura orientale in pieno occidente, un modello di integrazione ante litteram di grande attualità. -

GIUSEPPE TROMBINO, Engineer, Architect
GIUSEPPE TROMBINO, Engineer, Architect Born in Palermo, 1949 Member of the Chamber of Engineers N. 2373, 1974. Since 1975 his professional activity is dedicated to Urban and territorial planning. Full Professor of Urban Planning at University of Palermo. Technical consultant of many municipalities and of the Regional Government of Sicily. Consultant for the writing of the new Regional urban law, Government of Sicily. President of the provincial centre of urban studies, Palermo. Vice President of the regional section of ANCSA (Historic Centre National Association). Member of the CRU (Regional Committee of Urban planning). President of the regional section of INU (National Planning Institute). Author of numeorus scientific publications about several aspects of Planning. Main Professional activity 1 - General Urban Development Plan (1982-1986) City of Mezzojuso, Sicily- Coprogettista (1984-1993) City of Chisa Sclafani, Sicily- Coprogettista (1986-1991) City of Alia, Sicily- Progettista (1988) City of Giardinello, Sicily- Progettista 1987/2003 City of Aliminusa 1988/1995 City of Castell'Umberto (ME) 1991/2006 City of Canicattì 1993/2005 City of Caltanissetta 1995/2003 City of Marianopoli 1995/2009 City of Cammarata 1988/2006 City of Geraci 1999/2002City of Lercara 1999 City of Sant’Agata di Militello 2000/2007 City of Palma di M. 2001 City of San Mauro Castelverde 2001/2003 City of Lercara 2002 City of Valverde 2003/2009 City of Vicari 2003/2009 City of Chiusa Sclafani 2004 City of Ravanusa 2004 City of Cefalù 2006 City of Campofelice di Roccella 2006/2007 City of Mistretta 2007 City of Serradifalco 2008 City of San Vito Lo Capo 2008 City of Terrasini 2008 City of Campobello di Mazara 2009 City of Pozzallo 2 - Historic Centre Conservation and Development.