U578a01apr01 Relazione
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
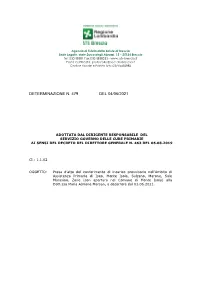
Determinazione N. 479 Del 04/06/2021
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it Posta certificata: [email protected] Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980 DETERMINAZIONE N. 479 DEL 04/06/2021 ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GOVERNO DELLE CURE PRIMARIE AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019 Cl.: 1.1.02 OGGETTO: Presa d’atto del conferimento di incarico provvisorio nell’Ambito di Assistenza Primaria di Iseo, Monte Isola, Sulzano, Marone, Sale Marasino, Zone (con apertura nel Comune di Monte Isola) alla Dott.ssa Maria Ajmone Marsan, a decorrere dal 01.06.2021. _________________________________________________________________ IL DIRIGENTE RESPONSABILE Premesso che: − il Dott. Soardi Enrico medico di Assistenza Primaria nell’Ambito di Iseo, Monte Isola, Sulzano, Marone, Sale Marasino, Zone (con ambulatorio nel Comune di Monte Isola) ha cessato l’attività convenzionale per recesso volontario dal 01.06.2021, come recepito con Determinazione dirigenziale n. 408 del 11.05.2021; − il Dott. Dall’Olio Carlo medico di Assistenza Primaria nell’Ambito di Iseo, Monte Isola, Sulzano, Marone, Sale Marasino, Zone (con ambulatorio nel Comune di Monte Isola e Marone) ha cessato l’attività convenzionale per trasferimento in altro ambito dal 01.06.2021, come recepito con Determinazione dirigenziale n. 426 del 17.05.2021; Considerato che: − ai sensi dell’art. 38, commi n. 1 e n. 4 del vigente A.C.N., si è creata una carenza assistenziale con un’eccedenza di assistiti superiore alle 300 unità, tale da coprire con incarico provvisorio; − gli incarichi provvisori di cui all’art. -
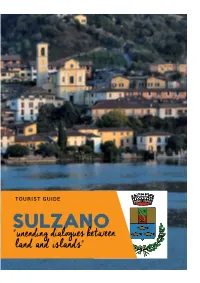
SULZANO " Unending Dialogues Between Land and Islands" SULZANO GUIDE 3
TOURIST GUIDE SULZANO " unending dialogues between land and islands" SULZANO GUIDE 3 SULZANO BACKGROUND HISTORY much quicker and soon small Sulzano derives its name from workshops were turned into actual Sulcius or Saltius. It is located in an factories providing a great deal of area where there was once an ancient employment. Roman settlement and was born as a lake port for the area of Martignago. Along with the economic growth came wealth and during the Twentieth Once, the fishermen’s houses were century the town also became a dotted along the shore and around tourist centre with new hotels and the dock from where the boats would beach resorts. Many were the noble leave to bring the agricultural goods to and middle-class families, from the market at Iseo and the materials Brescia and also from other areas, from the stone quarry of Montecolo, who chose Sulzano as a much-loved used for the production of cement, holiday destination and readily built would transit through here directed elegant lake-front villas. towards the Camonica Valley. At the beginning of the XVI century, the parish was moved to Sulzano and thus the lake town became more important and bigger than the hillside Sulzano is a village that overlooks the one. During the XVII Century, many Brescia side of the Iseo Lake mills were built to make the most of COMUNE DI the driving force of the water that SULZANO flowed abundantly along the valley to the south of the parish. Via Cesare Battisti 91- Sulzano (Bs) Tel. 030/985141 - Fax. -

LOCANDINA Family
STUDENTE/SSA CLASSE STUDENTE/ESSA ARRIVI PARTENZE ACCOGLIENTE STRANIERO/A Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI-MONTALCINI” ISEO- PARATICO Via Pusterla,1 – 25049 Iseo (Bs) C.F.80052640176 Elemire Petegolli 2 E Dimitrije Mitic D alla Sabato 07.03 www.iciseo.edu.it e-mail: [email protected] tel. 030/980235 Vanessa Musaku 2 E Sofija Vukadin SERBIA mattina Anna Bonera 2 E Marija Radić Michele Battagliola 2 E David Alavanja Daniele Mazzola 2 E Jovan Komarčević 20.00 a Milano, con Anna Bonera 2 E Sofija Bogdanović transfer ore Caterina Buelli 2 E Ana Radojičić 22.00 a Paratico Gabriele Cinesi 2 F Vuk Miholjčić Melissa Germinario 2 B Amelia Katanowska Dalla Venerdì Erasmus+ KA229 project 2019-1-IT02-KA229-063210_1 Carla Staffiere 2 C Milena Starowicz POLONIA 06.03 “COMPLEXUS: how the school can have a key role in the Alessia Mancione 2 C Karolina Opalinska pomeriggio current complex reality” Alice Verzeletti 1 B Karolina Morek 15.10 1st mobility: March 2020 in ITALY (Tourism Committee) Penolope Zanini 1 A Wiktoria Szczurek BERGAMO, 01.03.2020/07.03.2020 Alessandro Baroni 2 C Dorota Drewniak con transfer ore 17.30 a Cristian Sottile 2 A Maciej Żurek Iseo Alice Trebeschi 2 A Agata Kucharczyk Elisa Judica 1 A Aitana Bello Dalla Sabato 07.03 Filippo Bianchi 2 C Héctor SPAGNA mattina Gaia Quetti 1 C Carla Guerra 16.25 a Bergamo, Giorgio Tabeni 2 A Tomas Manrique con transfer Maurizio Amerio 2 A Dani Martin ore 18.30 a Luca Brescianini 2 B Alejandro Oñoro Iseo MATTINA PRANZO POMERIGGIO SERA LUNEDÌ 8.00-13.00: Iseo- Scuola 13.00-14.00: 14.00- 17.30 Tour guidato Consegna ai genitori per rientro 02.03.2020 Secondaria pranzo in mensa delle Torbiere (PRESENTI: in famiglia alle ore 17.30, presso Benvenuto; gli student si presso Secondaria alunni accoglienti Iseo- Secondaria di Iseo presentano e visitano la scuola Iseo Paratico e delegati Iseo cl (PRESENTI: alunni accoglienti di Iseo e la cittadina. -

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI Riconoscendo Un Contributo Regionale Massimo Complessi- D.G.R
Bollettino Ufficiale – 3 – Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2020 sercizio 2020, a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.8443, C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI riconoscendo un contributo regionale massimo complessi- D.g.r. 14 dicembre 2020 - n. XI/3977 vo di euro 600.000,00 per ogni Comune che prende parte Accordo quadro di sviluppo territoriale per il rilancio, la all’Accordo; riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dell’area Richiamate altresì: del Sebino. Modifica e integrazione alla d.g.r. n. 211 dell’11 giugno 2018, alla d.g.r n. 1598 del 7 maggio 2019 e alla d.g.r. • la d.g.r. n. 211 del 11 giugno 2018 con la quale è stato ap- n. 2580 del 2 dicembre 2019 provato lo schema di AQST per il rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dell’area del Sebino, sot- LA GIUNTA REGIONALE toscritto digitalmente da parte di tutti i soggetti interessati e Richiamati: pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 31 del 3 agosto 2018; • la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l’art. • la d.g.r. n. 1598 del 7 maggio 2019 con la quale è stata 3 che disciplina l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale modificata e integrata la citata d.g.r. n. 211 dell’11 giugno (di seguito denominato AQST), strumento di programma- 2018, modificando l’AQST per il rilancio, la riqualificazione, zione negoziata regionale; la valorizzazione e la promozione dell’area del Sebino, se- condo le decisioni assunte nel Comitato di Coordinamento • il regolamento regionale 12 agosto 2003 n. -

Slides Lago Di Iseo
Prefettura Regione di Brescia Provincia Lombardia di Brescia Associazione Comunità Montana Consorzio gestione Ferrovie Nord TreNord Comuni Bresciani Navigazione del Sebino Bresciano associata dei Laghi Milano Milano d’Iseo, Endine, Moro Lago d’Iseo Comune Comune Comune Comune di di Iseo di Marone di Monte Isola Paratico Comune Comune di Pisogne di Provaglio PATTO PER LA SICUREZZA Comune d’Iseo di Sulzano DEL LAGO DD’’’’ISEOISEO tra Prefettura di Brescia, Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Consorzio Gestione Associata dei Laghi d’Iseo Endine e Moro, TreNord Milano, Ferrovie Nord Milano, Comunità Montana del Sebino Bresciano, Navigazione Lago d’Iseo, Associazione Comuni Bresciani, Associazione Polizie Locali e Comuni di Iseo, Marone, Monte Isola, Paratico, Pisogne, Provaglio d’Iseo, Sulzano. Brescia, 26 settembre 2012 AREA INTERESSATA LAGO DD’’’’ISEOISEO O SEBINO (LAC DD’’’’IZIZIZIZÈÈÈÈ)))) Dimensioni Superficie: 65,3 Kmq Profondità: Max. 251 m Altitudine: 185 m s.l.m. Idrografia Origine: lago di escavazione glaciale Emissari principali: Oglio Isole: Monte Isola, Isola di Loreto, Isola di San Paolo 2 PATTO PER LA SICUREZZA DELLDELL’’’’AREAAREA DEL LAGO DD’’’’ISEOISEO PrefetturaPrefettura didi BresciaBrescia RappresentanteRappresentante RegioneRegione LombardiaLombardia LE PARTI CONTRAENTI AmministrazioneAmministrazione ProvincialeProvinciale didi BresciaBrescia RappresentanteRappresentante ConsorzioConsorzio Gestione Associata dei Gestione Associata dei ComuniComuni di:di: Iseo,Iseo, Marone,Marone, LaghiLaghi didi Iseo,Iseo, Monte -

Brescian Trails Hiking in the Province of Brescia - Brescia, Provincia Da Scoprire Bibliography
Brescian Trails Hiking in the Province of Brescia www.rifugi.lombardia.it - www.provincia.bs.it Brescia, provincia da scoprire Bibliography Grafo Edolo, l’Aprica e le Valli di S. Antonio, 2010 Le Pertiche nel cuore della Valsabbia, 2010 Gargnano tra lago e monte, 2010 I colori dell’Alto Garda: Limone e Tremosine, 2008 Il gigante Guglielmo tra Sebino e Valtrompia, 2008 L’Alta Valcamonica e i sentieri della Guerra Bianca, 2008 L’antica via Valeriana sul lago d’Iseo, 2008 Sardini Editrice Guida ai sentieri del Sebino Bresciano, 2009 Guida al Lago d’Iseo, 2007 Parco Adamello Guida al Parco dell’Adamello Provincia di Brescia Parco dell’Adamello Uffici IAT - Informazione e Accoglienza Turistica Sentiero Nr1, Alta Via dell’Adamello Brescia Lago di Garda Piazza del Foro 6 - 25121 Brescia Desenzano del Garda Ferrari Editrice Tel. 0303749916 Fax 0303749982 Via Porto Vecchio 34 [email protected] 25015 Desenzano del Garda I Laghi Alpini di Valle Camonica Vallecamonica Tel. 0303748726 Fax 0309144209 [email protected] Associazione Amici Capanna Lagoscuro Darfo Boario Terme Il Sentiero dei Fiori Piazza Einaudi 2 Gardone Riviera 25047 Darfo Boario Terme Corso Repubblica 8 - 25083 Gardone Riviera Tel. 0303748751 Fax 0364532280 Tel. 0303748736 Fax 036520347 Nordpress [email protected] [email protected] Il sentiero 3v Edolo Salò La Val d’Avio Piazza Martiri Libertà 2 - 25048 Edolo Piazza Sant’Antonio 4 - 25087 Salò Tel. 0303748756 Fax 036471065 Tel. 0303748733 Fax 036521423 [email protected] [email protected] Ponte di Legno Sirmione Corso Milano 41 Viale Marconi 6 - 25019 Sirmione Maps 25056 Ponte di Legno Tel. -

Sale Marasino – Marone – Pisogne
Distretto Centro Lago Bresciano Riviera degli Ulivi Sulzano – Monte Isola – Sale Marasino – Marone – Pisogne Dichiarazione sostitutiva stato di difficoltà D.P.R. n. 445/2000 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA' Il sottoscritto / La sottoscritta cognome __________________________________ nome __________________________________ nato/a a _____________________________________________ il _____________________________ residente nel comune di _______________________________________________________________ indirizzo _______________________________________________________ n. civico ___________ codice fiscale __________________________________ indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) ________________________________ in qualità di: □ titolare □ legale rappresentante □ delegato dell’impresa ________________________________________________________________________ (indicare la corretta denominazione) con sede (indirizzo completo) _____________________________________________________________ codice fiscale ___________________________ partita IVA __________________________________ telefono ___________________ cell. ________________________ fax ________________________ indirizzo di posta elettronica (e-mail) _____________________________________________ indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________ ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di -

Milano Parchi
EDOLO RAMO ISEO Sonico PARCO NATURALE Malonno ADAMELLO LEGENDA BRENTA Stazione viaggiatori Forno Allione Stazione di interscambio Cedegolo Linea di interconnessione con altre reti Sellero Navigazione laghi - Battello Capo di ponte Ceto - Cerveno Niardo - Losine BRENO Cividate - Malegno Cogno - Esine Pian di Borno Erbanno - Angone Boario Terme Darfo - Corna Artogne - Gianico Pian Camuno - Gratacasolo Pisogne Lago d'Iseo Toline Vello Marone - Zone Monte Isola Sale Marasino Sulzano Pilzone ISEO Provaglio - Timoline Borgonato - Adro Passirano Bornato - Calino Paderno Franciacorta Cazzago San Martino Castegnato Rovato Città Mandolossa ROVATO BORGO Borgo San Giovanni BRESCIA RFI Milano - Venezia Rev. F pubblicazione del 10/12/2017 Possibili interscambi nella stazione Nome della stazione SCHEMA DELLA RETE Stazione del Servizio Ferroviario Regionale Stazione del Servizio Suburbano Regionale ACCESSIBILITA’ DISABILI MOTORI ACCESSIBILITA’ DISABILI VISIVI ACCESSIBILITA’ DISABILI UDITIVI ASSISTENZA CLASSIFICAZIONE ACCESSIBILITA’ ALLE STAZIONI: Informazioni al pubblico con Mobilità autonoma in stazione Stazione con percorsi tattili Spazio accoglienza bacheche e teleindicatori Informazioni al pubblico con Mobilità assistita in stazione Linea gialla in banchina a rilievo Help Point bacheche PUNTI DI INTERSCAMBIO: LINEA FERROVIARIA LINEA METROPOLITANA AEROPORTO NAVIGAZIONE LAGHI Edizione. 02/2018 LEGENDA Adro - Timoline - Brescia Borgo SanCastegnato GiovanniPaderno PassiranoBornato CalinoBorgonatoProvaglio Iseo Cazzago SanRovato Martino CittàRovato Borgo -

AMONG ANCIENT VILLAGES on a COZY MINI-BUS Long Weekend on Foot and by Bike Exploring Bienno in Camonica Valley, Lovere and Monte Isola on Lake Iseo
AMONG ANCIENT VILLAGES ON A COZY MINI-BUS Long weekend on foot and by bike exploring Bienno in Camonica Valley, Lovere and Monte Isola on Lake Iseo. WHAT YOU WILL DISCOVER In this three-day tour on foot and by bike you will discover three of the most beautiful villages in Italy. Three ancient villages, rich in history and traditions, although very different and close to each other. You will travel in the two provinces of Brescia and Bergamo. Bienno: in the heart of the middle Camonica Valley, cradle of craftsmanship, ironworking and water mills. Lovere: a village perched on the Bergamo coast of upper Lake Iseo, which preserves a prestigious academy, medieval towers, a Basilica and Renaissance palaces, as well as a culture of water-sports including the historic rowing and sailing club. Monte Isola, the largest inhabited lake island in Europe, with its fishing villages, its traditions of fishing and sardine drying and the production of nets and typical wooden boats. VILLAGE N° 1 BIENNO Departure at 9 am on board of a mini-bus to visit one of the most beautiful villages in Italy: Bienno! You will visit this interesting town and the things that this ancient village offers. The Camonica Valley has a long history of ironworking that still lives here, with hammers and forges that can still be seen scattered throughout the territory. The grinding of wheat and the production of different types of flour, as well as the olive harvest or the production of craft beers. Along the way it will also be interesting to visit one of the most beautiful churches of the whole Camonica Valley. -

CYCLING ALONG the MOST FAMOUS “GIRO D'italia” PASSES Tour for Passionate Road Cyclists
CYCLING ALONG THE MOST FAMOUS “GIRO D'ITALIA” PASSES Tour for passionate road cyclists WHAT YOU’LL DISCOVER In these tours you will cycle along Lombardy, among the most famous passes of the “Giro d'Italia”: in CAMONICA VALLEY (2) and in TELLINA VALLEY (1). The color that represents the Camonica Valley is GREY, the color of the UNESCO heritage rocks engraved in the Neolithic, and the high peaks, cradle of the majestic Presena glacier. Camonica valley is also a UNESCO Biosphere Reserve since 2019. The color of Valtellina is VIOLET, which represents the crisp air of high mountains between the famous passes of northern Italy: Stelvio, Gavia but also towns like Bormio, Livigno and Saint Moritz in nearby Switzerland. Violet are also the grapes and the wines produced in this land CHOOSE WHAT SUITS YOU BEST! Here you will find some passes routes for cycling enthusiasts. They are all part of the “Giro d’Italia” the most famous and important annual multiple-stage bicycle race. The passes we chose are all located in north-eastern Lombardy in Camonica Valley and Valtellina. You have to know that we could personalize everything for you, as ascent and distance. Choose far in advance which of these routes you will want to ride with other people or with a groups of friends. This way you will be sure to reserve the best period for you and to do it with our organization. Lovere (Bg) my little town, is situated in the upper Sebino (lake Iseo) and in 2019 was the starting point of the most hard step of the much followed tour “Giro d’Italia”. -

Trekking Sulzano Monte Isola
Legenda / Key Infopoint Strade asfaltate TREKKING Infopoint Road Parcheggio libero o disco orario Sentieri-mulattiere Free parking/parking disk Trail Direzione per Polaveno SULZANO MONTE ISOLA Polaveno Parcheggio a pagamento Confini comunali Parking fee Municipal border 1 Imbarcadero numerato Percorso Verde / Green path: Pier + number Scoprendo Sulzano Ormeggio temporaneo Discovering Sulzano Santa Maria del Giogo Zoadello Temporary mooring Sentiero delle tre valli mslm: 950 Three Valleys trail Cuna Ristoro Refreshment area Percorso rosso / Red path Sulzano - Santa Maria del Area Picnic Giogo Stela Pic-nic area Accesso Via Valeriana I colmì Area Barbecue Access to Via Valeriana Barbecue area Sentiero della Resistenza Chiesa Resistance trail COMUNE di SULZANO COMUNE di MONTE ISOLA Church Sentiero degli Elfi Spiaggia pubblica Caposs Elf’s trail mslm: 900 Public beach Sentiero / Trail Grisa Noleggio biciclette Proai - Gölem Bike rental Punto panoramico Stazione treno View Point Train station Cascata DiDifficoltàfficoltà DiDislivelloslivello in ssalitaalita Doss Bruc DDegreeegree ooff difficultydifficulty MMeterseters ooff heightheight didifferentialfferential Waterfall trail Idai / Key SSchwierigkeitsgradchwierigkeitsgrad HHöhenunterschiedöhenunterschied LLocalitàocalità di partenzapartenza Punto acqua / Fountain DDurataurata / DurDurationation / LLaufzeitaufzeit SStartingtarting llocationocation / AAbfahrtbfahrt Simà DDistanzaistanza LLocalitàocalità di arrivoarrivo Nistisino DDistanceistance / LLangeranger WWegeg EEndingnding locationlocation -

Informazioni Su Monte Isola
MONTE ISOLA INFORMAZIONI GENERALI Superficie: kmq 12,79 Perimetro: km 9 Altitudine: m. 187 - 600 s.l.m. Popolazione residente: 1769 (dati ultimo censimento 2001) COME SI RAGGIUNGE In auto: Autostrada A 4: - provenendo da est uscita Ospitaletto, proseguire per Val Trompia per 2 km, poi preincanalarsi a sinistra per Iseo Valle Camonica, proseguire fino a Iseo, Sulzano o Sale Marasino per l’imbarco.; - provenendo da ovest uscita Palazzolo sull'Oglio, poi a sinistra per Iseo Valle Camonica, fino a Iseo, Sulzano o Sale Marasino: - provenendo da CR, PC, PR uscita Rovato, proseguire a sinistra e poi a destra sulla rotonda per Iseo; In treno: Da Brescia con linea delle Ferrovie Nord Brescia-Iseo-Edolo, scendere nelle stazioni di Iseo, Sulzano o Sale Marasino per traghettare. Distanze in km dai maggiori aeroporti: Milano Linate 100 km, Verona Villafranca 40 km, Bergamo Orio al Serio 38 km. N.B. L’isola non è transitabile da autoveicoli e motoveicoli privati di non residenti, pertanto è necessario parcheggiare i mezzi a Iseo, Sulzano o Sale Marasino prima di traghettare. PANORAMICA GENERALE Monte Isola, l’isola più grande dei laghi europei, è una montagna verde al centro del lago d'Iseo, definita dalla legislazione italiana "zona di particolare rilevanza naturale e ambientale". L’attuale comune si formò nel 1928 con l’unione degli antichi paesi di Peschiera Maraglio e Siviano, per decisione del governo fascista, con il nome di Comune di Siviano. L’attuale nome è stato deciso negli anni cinquanta. Il comune di Monte Isola comprende anche le due isolette di San Paolo e di Loreto, la prima a sud, l’altra a nord.