Dentro Il Testo E Nella Storia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
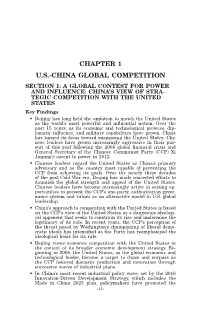
A Global Contest for Power and Influence
CHAPTER 1 U.S.-CHINA GLOBAL COMPETITION SECTION 1: A GLOBAL CONTEST FOR POWER AND INFLUENCE: CHINA’S VIEW OF STRA- TEGIC COMPETITION WITH THE UNITED STATES Key Findings • Beijing has long held the ambition to match the United States as the world’s most powerful and influential nation. Over the past 15 years, as its economic and technological prowess, dip- lomatic influence, and military capabilities have grown, China has turned its focus toward surpassing the United States. Chi- nese leaders have grown increasingly aggressive in their pur- suit of this goal following the 2008 global financial crisis and General Secretary of the Chinese Communist Party (CCP) Xi Jinping’s ascent to power in 2012. • Chinese leaders regard the United States as China’s primary adversary and as the country most capable of preventing the CCP from achieving its goals. Over the nearly three decades of the post-Cold War era, Beijing has made concerted efforts to diminish the global strength and appeal of the United States. Chinese leaders have become increasingly active in seizing op- portunities to present the CCP’s one-party, authoritarian gover- nance system and values as an alternative model to U.S. global leadership. • China’s approach to competition with the United States is based on the CCP’s view of the United States as a dangerous ideologi- cal opponent that seeks to constrain its rise and undermine the legitimacy of its rule. In recent years, the CCP’s perception of the threat posed by Washington’s championing of liberal demo- cratic ideals has intensified as the Party has reemphasized the ideological basis for its rule. -

C China Allgemein
Seite 1 C China Allgemein R C 1 Biblio-Bibliographien / Kataloge von Bibliographien / periodisch erscheinende Bibliographien / Bücherkataloge / Bibliographische Jahrbücher C 1 Bibliographien: allgemeine Studien R C 2 Bibliographien, Kataloge und Indices von Zeitschriften, Zeitungen, Datenbanken / allgemeine Verzeichnisse von Zeitschriften- und Zeitungsartikeln [Indices von einzelnen Zeitschriften, welche die Bibliothek besitzt, stehen bei der ZS] R C 3 Bibliographien von Sammelwerken C 4 Geschichte und Technik der Papierherstellung, des Buchdrucks und des Buchbindens / Konservierung alter Materialien / banben 版本 [s.a. → C 299] C 6 Bibliotheken, Archive, Privatsammlungen, Buchhandlungen und Verlagswesen, Zeitschriften und Zeitungen C 7 Bibliothekskunde R C 11 Bibliothekskataloge: bis 1850 (China und Japan) R C 13 Bibliothekskataloge: nach 1850 (nur China) R C 16 Bibliothekskataloge: Privatsammlungen in China (inkl. Hongkong und Taiwan) R C 18 Bibliothekskataloge: Sammlungen chinesischer Bücher im Ausland (ab 1850 inkl. Japan) R C 21 Allg. Bibliographien und Indices / Bibliographien und Indices von allg. Nachschlagewerken C 24 Bibliographische Hinweise, Notizen und Essays / dushu ji 讀書記 R C 25 Spezialbibliographien zu historischen Perioden, geographischen Gebieten, verbotenen, verlorenen und wiedergefundenen Büchern etc. [Bibliographien zu den einzelnen Fachgebieten → Fachgebiete] Seite 2 C 27 Textüberlieferung / Authentizität / jiaokanxue 校勘學 / wenxianxue 文獻學 / [xungu 訓詁 → C 411]/ Verfolgung von Texten, Literatur wenhuo 文禍, wenzi yu 文字獄, Textedition jiaoben 校本 / guji 古 籍 R C 29 Bibliographien und Indices zu Sammelwerken congshu 叢書 R C 31 Enzyklopädien / leishu 類書 [ cihai 辭海 → RC 472] C 31 Sekundärliteratur zu Enzyklopädien, leishu 類書 und congshu 叢書 R C 765 Allgemeine Nachschlagewerke / Handbücher gongjushu 工具書 [Bibliographien dazu → RC 21] C 34 Sekundärliteratur zu Nachschlagewerken und Handbüchern R C 35 Adress- und Telefonbücher C 37 Studiengesellschaften / Museen / Institutionen / Kongresse etc. -

Moderní Čínská Literatura 中國現代文學
Moderní čínská literatura 中國現代文學 Mgr. Kamila Hladíková, Ph.D. Olomouc 2013 Moderní čínská literatura učební materiál pro studenty sinologie Tato publikace vznikla na Katedře asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu OPVK Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0289. Ediční poznámka KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hladíková, Kamila Vzhledem k výukové povaze je v předkládaném textu obsaženo mnoho odborných termínů, jmen i názvů Moderní čínská literatura : učební materiál pro studenty v češtině i čínštině. V textu je použita zjednodušená podoba čínských znaků. Pro přepis čínských jmen a topo- sinologie / Kamila Hladíková. -- 1. vyd. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. -- 190 s. nym je důsledně využíváno mezinárodně uznávaného transkripčního přepisu pinyin, pouze v bibliografických ISBN 978-80-244-3840-5 (brož.) citacích je vždy zachován přepis, v němž bylo publikováno původní dílo. 821.581 Dělení slov a psaní velkých písmen v pinyinu vychází z Národního standardu Čínské lidové republiky (ICS - čínská literatura -- 20. stol. 01.140.10), jež spravuje Komise pro Pravopis čínského pinyinu. Tuto standardní podobu a pravidla mohou čte- - učebnice vysokých škol náři nalézt např. na www.pinyin.info. Užití velkých písmen na počátcích českých slov a slovních spojení vychází z Pravidel českého pravopisu 821.58.09 - Sino-tibetské literatury (o nich) [11] a podrobnější a pravidelně aktualizované Internetové jazykové příručky dostupné na http://prirucka.ujc.cas. 37.016 - Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice [22] cz/, na jejímž vzniku se podíleli pracovníci Ústavu pro jazyk český AV ČR a pracovníci Centra zpracování při- rozeného jazyka Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. -
China Insight October 2013
C HINA Fostering business and culturalI harmonyNSIGHT between China and the U.S. VOL. 12 NO. 9 OCTOBER 2013 University of Minnesota begins yearlong China 100 celebration ment to developing more exchange and Minnesota would like to hear from you. partnership opportunities with China in Meanwhile, one upcoming event is Page 3 the next 100 years. During the 2013- “Chinese Students at the University of 2014 academic year, the University of Minnesota: The First 10 Years (1914 Minnesota will celebrate China 100, a – 1924)” presented by Institute for yearlong celebration honoring the first Advanced Study Director and History students from China and the wealth of Professor Ann Waltner. connections that have come since. It Date:Tuesday, Oct. 8 recognizes the past and looks at future Time: 4 - 5:30 p.m. engagements between the University of Location: University International Minnesota and China. Center, Room 101 The University hosts more than Waltner teaches Chinese history and 2,200 students and scholars from China world history with research interests Page 8 each year and also holds more than 80 in the social history of 16th and 17th memorandum of agreements signed century China. She also served as edi- with some 30 Chinese universities as tor of the Journal of Asian Studies from strategic partners. Its world-renowned 2000 to 2005 and has published widely faculty works with Chinese research- on the history of Ming dynasty China Pan Wen Ping, the first Chinese ers to address some of the world’s most and serves on the Advisory Council of student to attend the University of pressing problems. -

Personenregister
PERSONENREGISTER A Cheng = Zhang Acheng 阿城 C 694.215 A Cheng = Wang Acheng 阿成 C 694.254 A Lai 阿來 C 694.341 A Sheng 阿盛 C 698.301 A Ying = Qian Xingcun 阿英 C 687.038 Ai Juan 艾涓 C 694.348 Ai Mi 艾米 C 694.522 Ai Qing = Jiang Haicheng 艾青 C 687.054 Ai Wei 艾偉 C 694.434 Ai Wen 艾雯 C 698.315 Ai Wu = Tang Daogeng 艾蕪 C 687.055 Anni Baobei 安妮寶貝 C 694.437 Ba Jin = Li Feigan 巴金 C 687.022 Ba Ren = Wang Renshu 巴人 C 687.057 Bai Hua 白樺 C 694.101 Bai Juyi (auch Bo Juyi) 白居易 C 568 Bai Lang 白郎 C 687.151 Bai Qiu 白萩 C 698.322 Bai Ren 白刃 C 694.063 Bai Wei 白危 C 687.155 Bai Wei 白蘶 C 687.204 Bai Xianyong 白先勇 C 698.002 Bai Xiaoguang = Ma Jia 白曉光 C 687.046 Bai Ye = Fei Qi 白夜 C 687.163 Bao Mi 保密 C 698.105 Bao Xiaolin 包曉琳 C 694.559 Bei Cun 北村 C 694.323 Bei Dao = Zhao Zhenkai 北島 C 694.237 Bi Feiyu 畢飛宇 C 694.358 Bi Shumin 畢淑敏 C 694.319 Bi Ye 碧野 C 694.145 Bian Zhilin 卞之琳 C 687.105 Bing Xin = Xie Wanying 冰心 C 687.023 Bo Yang 柏楊 C 698.083 Personenregister 1 Cai Chusheng 蔡楚生 C 694.200 Cai Qilan = Lu'ermen Yufu 蔡奇蘭 C 698.248 Cai Tianxin 蔡天新 C 694.526 Cai Yanpei 蔡炎培 C 698.293 Cai Yuanpei 蔡元培 C 687.083 Can Xue = Deng Xiaohua 殘雪 C 694.246 Cang Langke 滄浪客 C 698.113 Cao Cao 曹操 C 544 Cao Guilin = Glen Cao 曹桂林 C 694.364 Cao Juren 曹聚仁 C 687.042 Cao Lijuan 曹麗娟 C 698.205 Cao Ming 草明 C 687.078 Cao Naiqian 曹乃謙 C 694.580 Cao Pi 曹丕 C 544 Cao Wenxuan 曹文軒 C 694.334 Cao Xueqin 曹雪芹 C 676 Cao Yu 曹禺 C 687.034 Cao Zhenglu 曹征路 C 694.576 Cao Zhi 曹植 C 544 Cao Zhuanmei = Du Ai 曹傳美 C 687.131 Cen Sang 岑桑 C 694.083 Cha Liangzheng = Mu Dan 查良錚 C 687.196 Chang Yao = Wang Changyao 昌耀 C 694.299 Chen Baichen -

Understanding Shuangxue the PLAAF’S Learning Organization Initiative
Understanding Shuangxue The PLAAF’s Learning Organization Initiative Jess Woo Understanding Shuangxue The PLAAF’s Learning Organization Initiative Printed in the United States of America by the China Aerospace Studies Institute ISBN-13: 978-1727847321 ISBN-10: 1727847326 To request additional copies, please direct inquiries to Director, China Aerospace Studies Institute, Air University, 55 Lemay Plaza, Montgomery, AL 36112 Cover: Mao Zedong’s calligraphy saying “Study Hard and Keep Improving” [“天天学 习, 天天向上”] - now a common exhortation to students in China. E-mail: [email protected] Web: http://www.airuniversity.af.mil/CASI https://twitter.com/CASI_Research @CASI_Research https://www.facebook.com/CASI.Research.Org https://www.linkedin.com/company/11049011 Disclaimer The views expressed in this academic research paper are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy or position of the U.S. Government or the Department of Defense. In accordance with Air Force Instruction 51-303, Intellectual Property, Patents, Patent Related Matters, Trademarks and Copyrights; this work is the property of the US Government. Limited Print and Electronic Distribution Rights Reproduction and printing is subject to the Copyright Act of 1976 and applicable treaties of the United States. This document and trademark(s) contained herein are protected by law. This publication is provided for noncommercial use only. Unauthorized posting of this publication online is prohibited. Permission is given to duplicate this document for personal, academic, or governmental use only, as long as it is unaltered and complete however, it is requested that reproductions credit the author and China Aerospace Studies Institute (CASI). -

Representing the Chinese Cultural Revolution in Scar Literature
University of Alberta Revolutionary Trauma and Reconfigured Identities: Representing the Chinese Cultural Revolution in Scar Literature by Min Yang A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Comparative Literature ©Min Yang Fall 2012 Edmonton, Alberta Permission is hereby granted to the University of Alberta Libraries to reproduce single copies of this thesis and to lend or sell such copies for private, scholarly or scientific research purposes only. Where the thesis is converted to, or otherwise made available in digital form, the University of Alberta will advise potential users of the thesis of these terms. The author reserves all other publication and other rights in association with the copyright in the thesis and, except as herein before provided, neither the thesis nor any substantial portion thereof may be printed or otherwise reproduced in any material form whatsoever without the author's prior written permission. Abstract Revolutionary Trauma and Reconfigured Identities: Representing the Chinese Cultural Revolution in Scar Literature While a number of studies have examined the scar literature movement (1977-1983), no study has thoroughly explored the psychological function of the scar metaphor, the emotional catharsis (or so called “qinsu shi”) and the “bright tails” (the so-called “guangming de weiba”) — the key paradigm of scar stories in most Chinese people’s expression and assimilation of the trauma wrought by the Cultural Revolution. Through examining psychological mechanisms of metaphorical thinking, identification, and guilt or shame, which were articulated in scar stories, this dissertation attempts to shed new light on how some Chinese people who went through personal afflictions during the Cultural Revolution worked through their memories and reconstructed their social identity after Mao. -

Learning Warfare from the Laboratory— China’S Progression in Wargaming and Opposing Force Training
SEPTEMBER 2021 ELSA B. KANIA AND IAN BURNS MCCASLIN LEARNING WARFARE FROM THE LABORATORY— CHINA’S PROGRESSION IN WARGAMING AND OPPOSING FORCE TRAINING MILITARY LEARNING AND THE FUTURE OF WAR SERIES ELSA B. KANIA AND IAN BURNS MCCASLIN LEARNING WARFARE FROM THE LABORATORY— CHINA’S PROGRESSION IN WARGAMING AND OPPOSING FORCE TRAINING MILITARY LEARNING AND THE FUTURE OF WAR SERIES Cover: Chinese Navy submarines and warships take part in an international fleet review to celebrate the 60th anniversary of the founding of the People's Liberation Army Navy in Qingdao, Shandong province, April 23, 2009. (Photo by Guang Niu/ Pool via Reuters) All rights reserved. Printed in the United States of America. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage or retrieval system, without permission in writing or from the publisher. ©2021 by the Institute for the Study of War. Published in 2021 in the United States of America by the Institute for the Study of War. 1400 16th Street NW, Suite 515 | Washington, DC 20036 understandingwar.org ABOUT THE AUTHORS Elsa B. Kania is a Non-Resident Fellow in Indo-Pacific Defense with the Institute for the Study of War, where she is contributing to a new project on “Military Learning & The Future of War.” Ms. Kania is also an Adjunct Senior Fellow with the Technology and National Security Program at the Center for a New American Security and an Associate with the China Aerospace Studies Institute. She is currently a PhD candidate in Harvard University’s Department of Government. -

Revolutionary Trauma and Reconfigured Identities: Representing the Chinese Cultural Revolution in Scar Literature
University of Alberta Revolutionary Trauma and Reconfigured Identities: Representing the Chinese Cultural Revolution in Scar Literature by Min Yang A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Comparative Literature ©Min Yang Fall 2012 Edmonton, Alberta Permission is hereby granted to the University of Alberta Libraries to reproduce single copies of this thesis and to lend or sell such copies for private, scholarly or scientific research purposes only. Where the thesis is converted to, or otherwise made available in digital form, the University of Alberta will advise potential users of the thesis of these terms. The author reserves all other publication and other rights in association with the copyright in the thesis and, except as herein before provided, neither the thesis nor any substantial portion thereof may be printed or otherwise reproduced in any material form whatsoever without the author's prior written permission. Library and Archives Bibliothèque et Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de l'édition 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A 0N4 Ottawa ON K1A 0N4 Canada Canada Your file Votre référence ISBN: 978-0-494-89381-4 Our file Notre référence ISBN: 978-0-494-89381-4 NOTICE: AVIS: The author has granted a non- L'auteur a accordé une licence non exclusive exclusive license allowing Library and permettant à la Bibliothèque et Archives Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par télécommunication ou par l'Internet, prêter, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des thèses partout dans le loan, distrbute and sell theses monde, à des fins commerciales ou autres, sur worldwide, for commercial or non- support microforme, papier, électronique et/ou commercial purposes, in microform, autres formats. -

The Pla Beyond Borders
THE BEYOND Chinese Military Operations in Regional and Global Context BORDERS THE PLA Chinese Military Operations in Regional and Global Context PLA BEYOND BORDERS Edited by Joel Wuthnow, Arthur S. Ding, Phillip C. Saunders, Andrew Scobell, Andrew N.D. Yang THE PLA BEYOND BORDERS THE PLA BEYOND BORDERS Chinese Military Operations in Regional and Global Context Edited by Joel Wuthnow Arthur S. Ding Phillip C. Saunders Andrew Scobell Andrew N.D. Yang National Defense University Press Washington, D.C. 2021 Published in the United States by National Defense University Press. Portions of this book may be quoted or reprinted without permission, provided that a stan- dard source credit line is included. NDU Press would appreciate a courtesy copy of reprints or reviews. Opinions, conclusions, and recommendations expressed or implied within are solely those of the contributors and do not necessarily represent the views of the Depart- ment of Defense or any other agency of the Federal Government. Cleared for public release; distribution unlimited. Library of Congress Control Number: 2021935171 ISBN: 978-0-9968249-7-2 (paperback) National Defense University Press 300 Fifth Avenue (Building 62), Suite 212 Fort Lesley J. McNair Washington, DC 20319 NDU Press publications are sold by the U.S. Government Publishing Office. For ordering information, call (202) 512-1800 or write to the Superintendent of Docu- ments, U.S. Government Publishing Office, Washington, DC 20402. For GPO publica- tions online, access its Web site at: http://bookstore.gpo.gov. -

The Chinese Air Force's First Steps Toward
C O R P O R A T I O N The Chinese Air Force’s First Steps Toward Becoming an Expeditionary Air Force Cristina L. Garafola, Timothy R. Heath For more information on this publication, visit www.rand.org/t/RR2056 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data is available for this publication. ISBN: 978-0-8330-9866-5 Published by the RAND Corporation, Santa Monica, Calif. © Copyright 2017 RAND Corporation R® is a registered trademark. Limited Print and Electronic Distribution Rights This document and trademark(s) contained herein are protected by law. This representation of RAND intellectual property is provided for noncommercial use only. Unauthorized posting of this publication online is prohibited. Permission is given to duplicate this document for personal use only, as long as it is unaltered and complete. Permission is required from RAND to reproduce, or reuse in another form, any of its research documents for commercial use. For information on reprint and linking permissions, please visit www.rand.org/pubs/permissions. The RAND Corporation is a research organization that develops solutions to public policy challenges to help make communities throughout the world safer and more secure, healthier and more prosperous. RAND is nonprofit, nonpartisan, and committed to the public interest. RAND’s publications do not necessarily reflect the opinions of its research clients and sponsors. Support RAND Make a tax-deductible charitable contribution at www.rand.org/giving/contribute www.rand.org Preface This report is based on RAND Project AIR FORCE Strategy and Doctrine Program research that was presented at the second China Aerospace Studies Institute conference, sponsored by Headquarters, U.S.