3729Rel Storica
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

“Progetto Per La Conciliazione Vita–Lavoro” Promosso Dalla Regione Emilia Romagna FSE 2014-2020
Progetto approvato con DGR 2213/2019 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna Comune Comune Comune Comune Comune Comune di Castelfranco di Ravarino di Bastiglia di Nonantola di San Cesario sul di Bomporto Emilia Panaro “Progetto per la Conciliazione vita–lavoro” promosso dalla Regione Emilia Romagna FSE 2014-2020. Rif. PA n° 2020-13510/RER Allegato alla Determinazione n. 762 del 30/09/2020 AMMESSI AI CONTRIBUTI ECONOMICI DEL DISTRETTO DI CASTELFRANCO EMILIA – ANNO 2020 ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTI ECONOMICI Codice domanda Comune di appartenenza Ammesso/ non ammesso 3991 BOMPORTO AMMESSO 3992 CASTELFRANCO EMILIA AMMESSO 3993 CASTELFRANCO EMILIA AMMESSO 3994 CASTELFRANCO EMILIA AMMESSO 3995 BOMPORTO AMMESSO 3996 CASTELFRANCO EMILIA NON AMMESSO 3997 BOMPORTO AMMESSO 3999 BASTIGLIA AMMESSO 4000 CASTELFRANCO EMILIA AMMESSO 4001 BASTIGLIA AMMESSO 4003 NONANTOLA AMMESSO 4004 NONANTOLA AMMESSO 4005 BOMPORTO AMMESSO 4006 CASTELFRANCO EMILIA AMMESSO 4008 NONANTOLA AMMESSO 4009 NONANTOLA AMMESSO 4010 NONANTOLA AMMESSO 4012 CASTELFRANCO EMILIA AMMESSO 4014 CASTELFRANCO EMILIA AMMESSO 4016 NONANTOLA AMMESSO 4018 NONANTOLA AMMESSO 4019 CASTELFRANCO EMILIA AMMESSO 1 4020 BOMPORTO AMMESSO 4021 CASTELFRANCO EMILIA AMMESSO 4022 NONANTOLA AMMESSO 4023 CASTELFRANCO EMILIA AMMESSO 4024 CASTELFRANCO EMILIA AMMESSO 4025 CASTELFRANCO EMILIA AMMESSO 4026 CASTELFRANCO EMILIA AMMESSO 4027 CASTELFRANCO EMILIA AMMESSO 4028 NONANTOLA AMMESSO 4029 CASTELFRANCO EMILIA AMMESSO 4030 NONANTOLA AMMESSO 4031 CASTELFRANCO EMILIA AMMESSO 4033 -

Ufficio Del Territorio Di MODENA
Ufficio del territorio di MODENA Data: 24/10/2017 Ora: 11.39.43 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2017 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.- del - n.181 del 27/06/2017 REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 VALLI DEL DRAGONE E DEL ROSSENNA ALTO PANARO Comuni di: FRASSINORO, MONTEFIORINO, PALAGANO, POLINAGO Comuni di: FANANO, FIUMALBO, LAMA MOCOGNO, MONTECRETO, MONTESE, PAVULLO NEL FRIGNANO, PIEVEPELAGO, RIOLUNATO, SESTOLA, ZOCCA COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) BOSCO CEDUO DEGRADATO 2000,00 2400,00 BOSCO CEDUO GOVERNATO 4400,00 4600,00 BOSCO D`ALTO FUSTO - DA 0 A 20 ANNI 6400,00 6900,00 BOSCO D`ALTO FUSTO - DA 20 A 40 8600,00 9200,00 ANNI BOSCO D`ALTO FUSTO - OLTRE 40 ANNI 12500,00 13200,00 BOSCO MISTO DEGRADATO 3300,00 3500,00 BOSCO MISTO GOVERNATO 5900,00 6100,00 CASTAGNETO DA FRUTTO 3900,00 4400,00 DEGRADATO CASTAGNETO DA FRUTTO 8000,00 9600,00 GOVERNATO COLTIVO ABBANDONATO 3900,00 4000,00 FRUTTETO DI POMACEE - 14000,00 BASSA/MEDIA DENSITA Pagina: 1 di 9 Ufficio del territorio di MODENA Data: 24/10/2017 Ora: 11.39.43 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2017 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.- del - n.181 del 27/06/2017 REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 VALLI DEL DRAGONE E DEL ROSSENNA ALTO PANARO Comuni di: FRASSINORO, MONTEFIORINO, PALAGANO, POLINAGO Comuni di: FANANO, FIUMALBO, LAMA MOCOGNO, MONTECRETO, MONTESE, PAVULLO NEL FRIGNANO, PIEVEPELAGO, RIOLUNATO, SESTOLA, ZOCCA COLTURA Valore Sup. -

Lega Nord Emilia E Romagna ^G^^.^»
Regione Emilia-Romagna OGGETTO 8341 Assemblea legislativa Fascicolo: 2019.2.4.1.407 AL/2019/11877 del 15/05/2019 Lega Nord Emilia e Romagna ^g^^.^», ^wqrwinFTfXIVr Gruppo Assembleare \^A$métm Ugkktim « Bologna, 15/05/2019 OGGETTO 83 4* Alla Presidente dell'Assemblea Legislativa *^ della Regione Emilia-Romagna INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA Il sottoscritto Consigliere Regionale Lega Nord Emilia e Romagna Stefano Bargi Premesso che Dal 2011 la gestione dei rifiuti a Modena e provincia è stata affidata da Atersir ad Hera tramite continue proroghe dell'appalto e suscitando le contestazioni dell'Antitrust. Pochi mesi fa l'Antitrust, "soprattutto al fine di garantire la possibilità di partecipare alla gara anche a piccole e medie imprese in Ati", ha suggerito alla Regione e alla stazione appaltante, oltre che di ridurre la durata degli affidamenti, anche di ridurre l'ampiezza dei bacini. Nei giorni scorsi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Contratti Pubblici n.54 del 10-5- 2019) il Bando di gara - Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese" del territorio provinciale di Modena. Il bando è per 33 comuni: Modena, Castelfranco Emilia, Vignola, Pavullo nel Frignano, Spilamberto, Savignano sul Panaro, San Cesario sul Panaro, Zocca, Marano sul Panaro, Lama Mocogno, Sestola, Palagano, Montefiorino, Frassinoro, Polinago, Montecreto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Fanano, Fiumalbo, Riolunato, Pievepelago, Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Montese, Sassuolo, Fiorano, Prignano, Formigine, Maranello e Serramazzoni, molti dei quali andranno al voto il prossimo 26 maggio. Il servizio oggetto della presente concessione avrà una durata di 15 anni per un valore complessivo stimato in quasi 1 miliardo di euro (933.475.135 euro per la precisione). -

Per Fare Rete (#Farelab) E Fornire Infrastrutture Ed Aree Di Qualità
Novi di Modena Camposanto Bomporto Soliera Pianifichiamo e Gestiamo I tredici Comuni della Ravarino provincia di Modena Bastiglia Nonantola che aderiscono al Campogalliano Aree Industriali Consorzio Attività Produttive Aree e Modena . per Fare Rete (#FaReLab) Servizi Castelfranco Nel loro territorio risiede una popolazione di circa 325 mila abitanti San Cesario sul Panaro e Fornire Infrastrutture su una superficie complessiva di 660 chilometri quadrati. Castelnuovo Rangone ed Aree di Qualità Spilamberto Il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi comprende 13 Comuni della provincia di Modena: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, San Cesario sul Panaro, Soliera e Spilamberto oltre al Comune capoluogo di Modena. Organi Soci Le aree PIP Chi siamo Presidente del CdA: Anna Maria Vandelli Dalla sua costituzione il Consorzio ha ceduto/ Direttore: Luca Biancucci assegnato alle aziende - in proprietà e in diritto di superficie – circa 2,7 milioni di metri quadrati Nel 1973 nacque il piano comprensoriale delle ASSEMBLEA CONSORZIALE di superficie fondiaria (SF) per PIP. Su queste aree si sono insediate più di 400 Aziende. Le Francesca Silvestri, eletta Presidente dell’Assemblea, aree PIP (Piani degli insediamenti produttivi) attività produttive allargato ai 10 Comuni che Sindaco del Comune di Bastiglia sono terreni riservati alle attività produttive e Alberto Borghi, Sindaco del Comune di Bomporto ceduti alle aziende a prezzi particolarmente fanno da corona al capoluogo Paola Guerzoni, Sindaco del Comune di Campogalliano vantaggiosi rispetto alle normali quotazioni Antonella Baldini, Sindaco del Comune di Camposanto di mercato (mediamente tra il 50% e 30% in Nel 1974 si costituì il Consorzio intercomunale per le aree produttive, Carlo Bruzzi, Sindaco di Castelnuovo Rangone meno). -

Cimitero Di Finale Emilia
Prot. Data prot. Oggetto 2045 31/01/2019 FINALE EMILIA MO - CIMITERO DI FINALE EMILIA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA NON PROVVISORI DI PARTE DEL TETTO - ART 21 - RICH DOC INTEGRATIVA 2038 31/01/2019 SISMA 2012 - CREVALCORE BO - TEATRO COMUNALE IN VIA MATTEOTTI N. 106 - LAVORI DI RIPRISTINO - INTERVENTO 2621 - RILASCIO NULLA OSTA 2036 31/01/2019 CASTIGLIONE DEI PEPOLI BO VIA BOCCADIRIO BARAGAZZA N 379/1 - IMPIANTO TECNOLOGICO - PROPONENTE ILIAD ITALIA SPA - TRASMISSIONE PARERE VINCOLANTE ART 146 2034 31/01/2019 MESOLA FE TRASMISSIONE DI REGOLAMENTO DAL CENTRO 2033 31/01/2019 LOIANO BO VIA DEI MULINI - SCIA PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATO - - CONFERENZA SERVIZI - INVIO PARERE DI COMPETENZA 2032 31/01/2019 FERRARA - LICEO ARTISTICO DOSSO DOSSI IN VIA BERSAGLIERI DEL PO N. 25B. INTERVENTO DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO. RICH. CERT. BUON ESITO LAVORI. DITTA: PROVINCIA FE. 2031 31/01/2019 FERRARA - VIA XX SETTEMBRE N. 104. RICH. CERTIFICAZIONE BUON ESITO LAVORI. DITTA: 2029 31/01/2019 FERRARA - VICOLO DEL TEATRO N. 2A. RICH. CERTIFICAZIONE BUON ESITO LAVORI. 2027 31/01/2019 FERRARA - VIA XX SETTEMBRE N. 104. LAVORI DI RESTAURO. RICH. CERT. BUON ESITO LAVORI. 2026 31/01/2019 BONDENO (FE) - LOC. OSPITALE, SANTUARIO MADONNA DELLA PIOPPA. RICH. CERTIFICAZIONE BUON ESITO LAVORI. 2025 31/01/2019 FERRARA - IMMOBILE IN VIA S. MAURELIO N. 10/16. RICH. AI CERTIFICAZIONE BUON ESITO LAVORI. 2024 31/01/2019 BOLOGNA VIA ALTABELLA 21 CASA DEL MONTE DEL MATRIMONIO - LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA BASAMENTO - AUT ART 21 2019 -

Poesiafestival 2020.Pdf
agosto - settembre ottobre - novembre XVI edizione PROMOTORI Comune di San Cesario sul Panaro Francesco Zuffi, Sindaco UNIONE TERRE DI CASTELLI e Sofia Biondi, Assessore Fabio Franceschini, Presidente COMITATO SCIENTIFICO dell’Unione e Sindaco del Comune di Castelvetro di Modena Roberto Alperoli (Direttore) e Giorgia Mezzacqui, Assessore Alberto Bertoni Roberto Galaverni Umberto Costantini, Assessore alle Emilio Rentocchini politiche culturali e per il turismo e Andrea Candeli (Direttore musicale) Sindaco di Spilamberto Erika Beneventi (Direttore organizzativo) e Carlotta Acerbi, Assessore Angelo Pasini, Sindaco di Vignola DIREZIONE ORGANIZZATIVA e Franca Massa, Assessore Aps Laboratorio Musicale del Frignano Massimo Paradisi, Sindaco di COLLABORATORI Castelnuovo Rangone Marco Bini e Sofia Baldazzini, Assessore Guido Mattia Gallerani Iacopo Lagazzi, Sindaco di Guiglia e Roberta Zanantoni, Assessore ORGANIZZAZIONE Giovanni Galli, Sindaco di Marano sul Simona Baldini, Savignano sul Panaro Panaro Perla Cecoli, Castelnuovo Rangone e Andrea Adani, Assessore Luca Cesari, Castelfranco Emilia Patrizia Lazzaro, Castelvetro di Enrico Tagliavini, Sindaco di Savignano Modena sul Panaro Loretta Ferrari, Guiglia e Antonella Gozzi, Assessore Ada Pelloni, Marano sul Panaro Gianfranco Tanari, Sindaco di Zocca e Stefania Pirli e Franca Ruggeri, Zocca Susanna Rossi Torri, Assessore Antonella Tonielli, Spilamberto FONDAZIONE DI VIGNOLA Maria Cristina Serafini, Vignola Valentina Rebecchi, San Cesario sul Carmen Vandelli, Presidente Panaro Graziella Nardini, -

Calendario Eventieventi Denominazione Data Luogo Evento Info - Rif
Calendario Eventi events calendar - calendrier des èvènements - veranstaltungskalender della provinCia di modEna pEriodo marzo-diCEmbrE 2010 calendario eventi calendario eventi dEnominazionE data luogo EvEnto info - rif. organizzativo baStiglia Festa di Primavera Marzo Bastiglia - Vie del centro 059 800912 Comune di Bastiglia - Ufficio Cultura Musei da Gustare 3° week end Aprile Bastiglia - Museo Civiltà contadina 059 800912 Comune di Bastiglia - Ufficio Cultura Festa della Civilta’ Contadina 4,5,6 Giugno Bastiglia - Piazze, vie, museo ecc 059 800912 Comune di Bastiglia - Ufficio Cultura La Sera d’estate Giugno-Luglio Bastiglia - Piazza Repubblica e Museo 059 800912 Comune di Bastiglia - Ufficio Cultura Lungo le Antiche Sponde Luglio Bastiglia - Santuario di S. Clemente e chiesa S.M. Assunta 059 800912 Comune di Bastiglia - Ufficio Cultura Nelle Piazze di Bastiglia Luglio Bastiglia - Piazze 059 800903 Comune di Bastiglia Sagra di San Clemente 8 Settembre Bastiglia - Santuario di San Clemente 059 800912 Comune di Bastiglia - Ufficio Cultura Giornate Europee del Patrimonio Settembre Bastiglia - Museo Civiltà contadina 059 800912 Comune di Bastiglia - Ufficio Cultura Concerto di Natale Dicembre Bastiglia - Chiesa parrocchiale 059 800912 Comune di Bastiglia - Ufficio Cultura bomporto Dolcissima Marzo Bomporto -Centro Storico 059 909780 Uff. Prom. del Territorio e Cultura Giornata Matildica Giugno Bomporto - Piazza Matilde di Canossa 059 909780 Ufficio Cultura Notte Blu Luglio Bomporto -Centro Storico 059 909780 Ufficio Cultura Festa della Tagliatella Luglio Bomporto - Solara 339 1168679 Comitato Festa della Tagliatella Festa del Lambrusco Settembre Bomporto - Piazza Matilde di Canossa 335 5330812 Comitato Festa del Lambrusco Campogalliano Festa della Repubblica 2 Giugno Campogalliano -Circ.Saliceto Buzzalino 059 899438 Comune di Campogalliano Fiera di Luglio 23,24,25,26,27 Luglio Campogalliano - Centro e Museo 059 899438 Comune - Ass.ProCampo dEnominazionE data luogo EvEnto info - rif. -

Curriculum Studio Associato Di Tecnica Industriale Minghelli
STUDIO ASSOCIATO DI TECNICA INDUSTRIALE MINGHELLI Via Locatelli, 122 - 41058 Vignola (MO) Tel. (059) 76.50.44 - Telefax (059) 76.46.50 E-mail: [email protected] P R O F I L O D E L L O S T U D I O Studio Progettazione e consulenza impianti meccanici ed elettrici civili e industriali Pratiche energetiche, omologative, di sicurezza ed ambientali STUDIO ASSOCIATO DI TECNICA INDUSTRIALE MINGHELLI CURRICULUM PROFESSIONALE SEDI DELLO STUDIO Via Locatelli, 122 - 41058 Vignola (MO) Tel. 059/765044 - Fax 059/764650 Email: [email protected] ATTIVITA’ Progettazione e consulenza impianti elettrici per attività industriali, civili e terziarie. TITOLARI DELLO STUDIO MATSECHEK p.i. DIEGO è nato a PUERTO CABELLO (VENEZUELA) il 18/06/1967 ed è residente in Vignola (MO) - Via Bontempelli, n° 265 - C.F. MTS DSP 67H18 Z614G. Nell’anno 1986 ha conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri “GUARINO GUARINI” di Modena il diploma di Geometra. Nell’anno 1992 ha conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale “FERMO CORNI” di Modena il diploma di Perito Industriale nella specializzazione ELETTROTECNICA. Nell’anno 1994 si è iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Modena con matricola n° 1780 ed è inserito nell’elenco dei professionisti di cui alla Legge 818/84 matricola MO1780P0208 . Abilitato ai sensi del d.lgs 494/96. CAVAZZUTI p.i. TIZIANO è nato a Modena il 08/05/1972 ed è residente in Maranello (MO) - Via Graziosi, n° 20 - C.F. CVZ TZN 72E08 F257B. Nell’anno 1991 ha conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale “FERMO CORNI” di Modena il diploma di Perito Industriale nella specializzazione ELETTROTECNICA. -
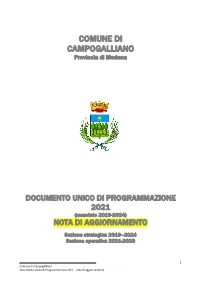
Nota Di Aggiornamento Dup 2021
COMUNE DI CAMPOGALLI ANO Provincia di Modena DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 20 21 (mandato 2019 -2024) NOTA DI AGGIORNAMENTO Sezione strategica 2019 –2024 Sezione operativa 202 1-202 3 1 Comune di Campogalliano Documento Unico di Programmazione 2021 – nota di aggiornamento Indice Introduzione.........................................................................................................................................3 1. LA SEZIONE STRATEGICA ..............................................................................................................6 1.1 Analisi delle condizioni esterne .......................................................................................7 1.1.1 La situazione socio-economica ........................................................................................7 Analisi demografica..............................................................................................................................7 Analisi economica ..............................................................................................................................12 Gli obiettivi individuati dal Governo ..................................................................................................24 1.1.2 Il quadro regionale.........................................................................................................55 1.2 Analisi delle condizioni interne......................................................................................66 1.2.1 Il governo delle partecipate e i servizi -

Associazioni Che Operano Nel Territorio Comunale
Associazioni che operano nel territorio comunale Associazioni di promozione sociale CULTURA ANPI Sede: Casa del combattente - Via Marconi, 12 - 41018 San Cesario sul Panaro Presidente: Mauro Artioli Telefono: 059 933028 Fax: Email: [email protected] Sito web provinciale: www.emilia-romagna.anpi.it/modena L’ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, costituita il 6 giugno 1944, a Roma, con i suoi oltre 110.000 iscritti, è tra le più grandi associazioni combattentistiche presenti e attive oggi nel Paese. Nello Statuto erano evidenziati gli scopi operativi che la struttura si era prefissata. Tra questi restituire al Paese una piena libertà e favorire un regime di democrazia per impedire in futuro il ritorno di qualsiasi forma di tirannia e assolutismo e valorizzare in campo nazionale e internazionale il contributo effettivo portato alla causa della libertà dall’azione dei partigiani. L’Anpi - Sezione di San Cesario attualmente collabora attivamente, con l’Amministrazione Comunale e altre associazioni, all’organizzazione delle iniziative per le giornate di celebrazione del 25 aprile e del 4 novembre. A.N.S.P.I. - Don Luigi Albertini Sede legale: Vicolo del Priore, 6 – 41018 San Cesario sul Panaro Sede operativa: Corso Libertà, 38 Presidente: Don Fabrizio Colombini C/o Parrocchia di San Cesario, Piazza Basilica, 7 Tel/Fax: 059 930109 Email: [email protected] Sito web: www.anspi.it Numero soci: 300 Organizza attività ricreative non competitive per i giovani, legate alla vita della Parrocchia. Tra queste i tornei di calcio e di basket, per giocatori non agonistici. Offre occasioni di socializzazione e incontro per i giovani e le famiglie; inoltre ha una convenzione in essere con la scuola e l’Amministrazione Comunale per la gestione di attività socio-ricreative per i bambini delle elementari e medie, l’organizzazione del doposcuola e, nel periodo estivo, dei centri estivi per i ragazzi. -

Albo Ordinario Dei Dottori Farmacisti Ed Elenco Speciale Dei Docenti E Ricercatori Universitari
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MODENA ALBO ORDINARIO DEI DOTTORI FARMACISTI ED ELENCO SPECIALE DEI DOCENTI E RICERCATORI UNIVERSITARI ANNO 2021 AGGIORNATO AL 02.10.2021 Via Vellani Marchi, 20 - 41124 - MODENA | TEL 059/23.80.09 - FAX 059/43.96.955 [email protected] - [email protected] - www.ordinefarmacistimo.it 1 / 168 Intro ............................................................................................................................................................................................................. 1 Elenco Speciale dei docenti e ricercatori universitari - Ordine alfabetico.......................................................................................... 3 Albo Ordinario - Ordine alfabetico ........................................................................................................................................................ 5 2 / 168 ELENCO SPECIALE DOCENTI E RICERCATORI UNIVERSITARI Elenco Speciale dei docenti e ricercatori universitari ordine alfabetico 3 / 168 ELENCO SPECIALE DOCENTI E RICERCATORI UNIVERSITARI Numero Numero di iscizione Dati Iscritti 1 2545 PELLEGRINI GRAZIELLA Nascita: GENOVA (GE) il 12/07/1961 Iscrizione: Elenco Speciale dei docenti e ricercatori universitari dal 16/01/2018 Abilitazione: Esame di Stato - I SESSIONE SESSIONE 1989 - GENOVA Residenza: CASTELNUOVO RANGONE (MO) 2 1451 SORBI CLAUDIA Nascita: MODENA (MO) il 21/01/1972 Iscrizione: Elenco Speciale dei docenti e ricercatori universitari dal 10/10/2019 Abilitazione: Esame -

Linea: 750 Rastellino Riolo Castelfranco
Linea: 750 Rastellino Riolo Castelfranco Validità Da lunedì a sabato note Rastellino 6.45 14.02 14.39 Riolo 6.50 14.10 14.44 Castelfranco FFSS 14.51 Manzolino 6.55 Castelfranco Emilia teatro 7.05 14.15 Linea: 750 Castelfranco Riolo Rastellino Validità Da lunedì a sabato note Castelfranco Emilia teatro 6.35 13.45 14.22 Manzolino 13.52 14.29 Riolo 6.43 13.57 14.34 Rastellino 6.45 14.02 14.39 Linea: 751 Nonantola Redu Castelfranco Validità Da lunedì a sabato note Nonantola 7.20 Redu' 6.50 7.25 Pioppa 7.35 Castelfranco Emilia teatro 7.40 Castelfranco FFSS 7.41 Gaggio 7.10 Fossalta 7.17 Piazzale Risorgimento 7.32 Modena Autostazione 7.35 Linea: 751 Castelfranco Redu Nonantola Validità Da lunedì a sabato note Modena Autostazione 13.45 Piazzale Risorgimento 13.46 Fossalta 13.58 Gaggio 14.03 Castelfranco FFSS 13.30 Castelfranco Emilia teatro 13.31 Pioppa 13.36 Redu' 13.45 14.30 Nonantola 13.50 Linea: 760 Vignola Castelfranco Modena Rubiera Da lunedì a sabato note Vignola Autostazione 5.50 6.05 6.20 6.20 6.35 7.00 Savignano sul Panaro 6.15 6.30 6.30 Mulino di Savignano 6.17 6.32 6.32 Bazzano Stazione 6.23 6.38 Magazzino 6.36 Spilamberto 6.05 6.45 6.50 7.15 Ponte Rosso 7.24 Piumazzo - Stazione 6.30 6.40 6.40 7.30 San Cesario sul Panaro 6.10 6.38 6.45 6.50 6.50 6.50 6.50 6.55 7.38 Cavazzona 6.48 Castelfranco Emilia teatro 6.20 6.50 6.52 6.58 7.00 7.00 7.00 7.00 7.05 7.05 7.50 Castelfranco FFSS 6.21 6.51 7.01 7.01 7.01 7.06 7.41 7.51 Castelfranco Emilia teatro 6.22 6.52 7.02 7.02 7.02 7.07 7.42 7.52 S.