Identità Dalmata Al Confine
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Elenco Basi Musicali
Elenco basi musicali (Nella scheda d'iscrizione indicare sempre 3 titoli di canzoni) 1 Grazie mille 883 2 Bella vera 883 3 Viaggio al centro del mondo 883 4 Nient'altro che noi 883 5 Come deve andare 883 6 Io ci saro' 883 7 Come mai 883 8 Nord Sud Ovest Est 883 9 Le ragazze fanno grandi sogni Edoardo Bennato 10 Sembra ieri Edoardo Bennato 11 Si tratta dell'amore Edoardo Bennato 12 L'isola che non c'e' Edoardo Bennato 13 W la mamma Edoardo Bennato 14 Il gatto e la volpe Edoardo Bennato 15 C'e' il sole Edoardo De Crescenzo 16 Ancora Edoardo De Crescenzo 17 Abbronzatissima Edoardo Vianello 18 I watussi Edoardo Vianello 19 Guarda come dondolo Edoardo Vianello 20 Hully Gully In Dieci Edoardo Vianello 21 Pinne fucile ed occhiali Edoardo Vianello 22 Luce (tramonti a Nord-Est) Elisa 23 Rainbow Elisa 24 Broken Elisa 25 Una poesia anche per te Elisa 26 Eppure sentire (un senso di te) Elisa 27 Stay Elisa 28 Pavimento liquido Ale Baroni 29 La distanza di un amore Ale Baroni 30 I Want Love Elton John 31 Something About The Way You Look Tonight Elton John 32 Written In The Stars Elton John 33 Nikita Elton John 34 In The Ghetto Elvis Presley 35 It's Now Or Never (O Sole Mio) Elvis Presley 36 Can't Help Falling In Love Elvis Presley 37 Il portiere di notte Enrico Ruggeri 38 Mistero Enrico Ruggeri 39 Rhythm Divine Enrique Iglesias 40 Sad Eyes Enrique Iglesias 41 Bailamos RM Enrique Iglesias 42 Be With You Enrique Iglesias 43 Escape Enrique Iglesias 44 Cose della vita Eros Ramazzotti 45 Un angelo non e' Eros Ramazzotti 46 Piu' che puoi Eros Ramazzotti -
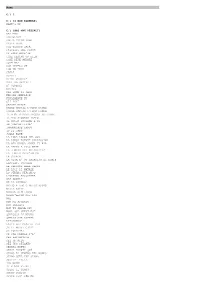
Name C:\ \ C:\ \4 NON BLONDES\ WHAT's up C:\ \883 MAX PEZZALI
Name C:\ \ C:\ \4 NON BLONDES\ WHAT'S UP C:\ \883 MAX PEZZALI\ 883 MIX AEROPLANO ANDRÀ TUTTO BENE BELLA VERA CHE GIORNO SARÀ CHIUDITI NEL CESSO CI SONO ANCH'IO COME DENTRO UN FILM COME DEVE ANDARE COME MAI CON DENTRO ME CON UN DECA CREDI CUMULI DIMMI PERCHE' DURI DA BATTERE E' VENERDI ECCOTI FAI COME TI PARE FAVOLA SEMPLICE FINALMENTE TU GLI ANNI GRAZIE MILLE HANNO UCCISO L'UOMO RAGNO HANNO UCCISO L'UOMO RAGNO IL MEGLIO DEVE ANCORA ARRIVARE IL MIO SECONDO TEMPO IL MONDO INSIEME A TE IN QUESTA CITTA' INNAMORARE TANTO IO CI SARÒ JOLLY BLUE LA DURA LEGGE DEL GOL LA LUNGA ESTATE CALDISSIMA LA MIA BANDA SUONA IL RAP LA RADIO A 1000 WATT LA REGINA DEL CELEBRITA' LA REGOLA DELL'AMICO LA STRADA LA VITA E' UN PARADISO DI BUGIE LASCIATI TOCCARE LE CANZONI ALLA RADIO LE LUCI DI NATALE LO STRANO PERCORSO L'ULTIMO BICCHIERE MAI UGUALI ME LA CAVERO' MEZZO PIENO O MEZZO VUOTO NELLA NOTTE NESSUN RIMPIANTO NIENT'ALTRO CHE NOI NOI NON MI ARRENDO NON PENSAVI NON TI PASSA PIÙ NORD SUD OVEST EST QUALCOSA DI NUOVO QUELLO CHE CAPITA RITORNERO' ROTTA PER CASA DI DIO SE TI MUOVI COSI' SE TORNERAI SE UNA REGOLA C'E' SEI FANTASTICA SEI UN MITO SEI UNO SFIGATO SEMBRO MATTO SENZA AVERTI QUÌ SIAMO AL CENTRO DEL MONDO SIAMO QUEL CHE SIAMO SOLITA ITALIA TENENDOMI TI SENTO VIVERE TIENI IL TEMPO TORNO SUBITO TUTTO CIO' CHE HO TUTTO CIÒ CHE HO UN GIORNO COSI UN GIORNO COSI' UNA CANZONE D'AMORE UNA LUNGA ESTATE CALDISSIMA UN'ESTATE CI SALVERA' UNO IN PIÙ UNO SFIGATO VIAGGIO AL CENTRO DEL MONDO WEEKEND WELCOME TO MIAMI YOU NEEDED ME C:\ \A HA\ ANALOGUE COSY PRISONS DREAM -

Il Repertorio Dei Redrose
Il repertorio dei RedRose (aggiornato al 27/06/2019) Le canzoni sono elencate in ordine alfabetico col nome del cantante che le ha rese famose e si intendono “CANTATE” dal vivo. Altre canzoni si possono inserire a richiesta. I repertori sono divisi per “Repertorio Davide”, “Repertorio Rossella”, “Repertorio in coppia”. Questi sono i brani che cantiamo come sottofondo. Poi però abbiamo molti altri brani come “Balli di gruppo”, “lenti”, “Dance Remix”, “liscio”, ecc (che troverete nella seconda metà di questo elenco). Repertorio Davide 883 – Medley (LUomoRagno, 6UnMito,NordSudOvestEst, RicordatiDiMe_AltaMarea) RottaXCasaDiDio, NellaNotte) Antonello Venditti – Notte prima degli esami 883 – Ci sono anch'io Antonello Venditti– Ogni volta 883 – Come mai Antonello Venditti– Sotto il segno dei pesci 883 – Eccoti Antonello Venditti– Stella 883 – Gli Anni (anche sola Chitarra Acustica) Antonello Venditti– Vento Selvaggio 883 – Grazie Mille ... e le altre a richiesta 883 – Io ci sarò Artisti Vari – Mix Anni 60 (La Fisarmonica, 883 – La Regina Del Celebrità UnOraSolaTiVorrei, IoChe non Vivo, CieloInUnaStanza, 883 – La Regola Dell'Amico NelBluDipintoDiBlu) 883 – Nessun rimpianto Barry Manilov – Mandy 883 – Nient'altro che noi Ben & king – Stand By Me (anche in versione Seal) 883 – Quello che capita Biagio Antonacci– Angela 883 – Senza Averti Qui Biagio Antonacci– Aprila 883 – Ti sento vivere Biagio Antonacci– Che differenza c'è 883 – Un giorno così Biagio Antonacci– Così presto no 883 ....le altre a richiesta Biagio Antonacci– Le cose che hai amato -

Lista Dal Nostro Repertorio Di Musica Dal Vivo – Controlla Le Novita’ Direttamente Sul Sito
SITO: WWW.MUSICADENTRO.IT – POSTA: [email protected] – TEL. 338 2692022 (Whatsapp) LISTA DAL NOSTRO REPERTORIO DI MUSICA DAL VIVO – CONTROLLA LE NOVITA’ DIRETTAMENTE SUL SITO ...PER CERCARE LA TUA CANZONE PREFERITA USA IL TASTO RICERCA DEL TUO LETTORE PDF E DIGITA UNA PAROLA I'M NOT IN LOVE 10CC WHAT'S UP 4 NON BLONDES BELLA VERA 883 - MAX PEZZALI CI SONO ANCH'IO 883 - MAX PEZZALI CISONOANCHIO 883 - MAX PEZZALI COME DEVE ANDARE 883 - MAX PEZZALI COME MAI 883 - MAX PEZZALI ECCOTI 883 - MAX PEZZALI GRAZIE MILLE 883 - MAX PEZZALI HANNO UCCISO L'UOMO RAGNO 883 - MAX PEZZALI IL MONDO INSIEME A TE 883 - MAX PEZZALI IO CI SARÒ 883 - MAX PEZZALI LA REGOLA DELL’AMICO 883 - MAX PEZZALI LASCIATI TOCCARE 883 - MAX PEZZALI LO STRANO PERCORSO 883 - MAX PEZZALI L’UNIVERSO TRANNE NOI 883 - MAX PEZZALI NELLA NOTTE 883 - MAX PEZZALI NESSUN RIMPIANTO 883 - MAX PEZZALI NORD SUD OVEST EST 883 - MAX PEZZALI ROTTA PER CASA DI DIO 883 - MAX PEZZALI SEI UN MITO 883 - MAX PEZZALI SENZA AVERTI QUI 883 - MAX PEZZALI TE LA TIRI 883 - MAX PEZZALI TIENI IL TEMPO 883 - MAX PEZZALI UNA CANZONE D'AMORE 883 - MAX PEZZALI VIAGGIO AL CENTRO DEL MONDO 883 - MAX PEZZALI ‘A CITTA’ E PULECENELLA AA.VV. (NAPOLI) COMME FACETTE MAMMETA AA.VV. (NAPOLI) DICITENCELLO VUJE AA.VV. (NAPOLI) FUNICOLI’ FUNICULA’ AA.VV. (NAPOLI) LA LUNA MEZZ’O MARE AA.VV. (NAPOLI) LUNA CAPRESE AA.VV. (NAPOLI) MALAFEMMENA AA.VV. (NAPOLI) MUNASTERIO E SANTA CHIARA AA.VV. (NAPOLI) NINI' TIRABUCIO' AA.VV. (NAPOLI) NUN E' PECCATO AA.VV. -

Download Lista Karaoke
.883 AEROPLANO .883 ANDRA' TUTTO BENE .883 BELLA VERA .883 CHIUDITI NEL CESSO .883 CI SONO ANCH'IO .883 COME DEVE ANDARE .883 COME MAI .883 CON UN DECA .883 CREDI .883 CUMULI DI ROBA .883 DIMMI PERCHE' .883 E' VENERDI' .883 ECCOTI .883 FAI COME TI PARE .883 FATTORE S .883 FAVOLE SEMPLICI .883 FINALMENTE TU .883 GLI ANNI .883 GRAZIE MILLE .883 HANNO UCCISO L'UOMO RAGNO .883 IL MIO SECONDO TEMPO .883 IL MONDO INSIEME A TE' .883 INNAMORATO TANTO .883 IO CI SARO' .883 JOLLY BLUE .883 L2 .883 LA DURA LEGGE DEL GOL .883 LA LUNGA ESTATE CALDISSIMA .883 LA REGINA DEL CELEBRITA' .883 LA REGOLA DELL'AMICO .883 LASCIATI TOCCARE .883 LE LUCI DI NATALE .883 LO STRANO PERCORSO .883 L'ULTIMO BICCHIERE .883 L'UNIVERSOTRANNE NOI .883 ME LA CAVERO' .883 MEDLEY .883 MEZZO PIENO O MEZZO VUOTO .883 NELLA NOTTE .883 NESSUN RIMPIANTO .883 NIENT'ALTRO CHE NOI .883 NON MI ARRENDO .883 NON TI PASSA PIU' .883 NORD SUD OVEST EST .883 QUELLO CHE CAPITA .883 ROTTA PER CASA DI DIO .883 SE TORNERAI .883 SEI FANTASTICA .883 SEI UN MITO .883 SENZA AVERTI QUI' .883 SIAMO AL CENTRO DEL MONDO .883 TENENDOMI .883 TI SENTO VIVERE .883 TIENI IL TEMPO .883 TORNO SUBITO .883 TUTTO CIO' CHE HO .883 UN GIORNO COSI' .883 UNA CANZONE D'AMORE .883 UNO IN PIU' .883 VIAGGIO AL CENTRO DEL MONDO .883 WEEKEND ACHILLE LAURO .16 MARZO ACHILLE LAURO .1969 ACHILLE LAURO BAM BAM TWIST ACHILLE LAURO C'EST LA VIE ACHILLE LAURO ME NE FREGO ACHILLE LAURO ROLLS ROYCE ACHILLE LAURO ULALALA ADAMO ALINE ADAMO AMO ADAMO CADE LA NEVE ADAMO DOLCE PAOLA ADAMO GRIDARE IL TUO NOME ADAMO IL NOSTRO ROMANZO -

Titolo Artista Tipo Here Without You 3 Doors Down MP3 Ba Ba Bay 360
www.cristommasi.com Titolo Artista Tipo Here Without You 3 Doors Down MP3 Ba ba bay 360 Gradi MIDI Giorno di sole 360 Gradi MIDI Sandra 360 Gradi MIDI E poi non ti ho vista più 360 Gradi & Fiorello MIDI Anything 3T MIDI Spaceman 4 Non Blondes MIDI What's up 4 Non Blondes MIDI In da club 50 Cent MIDI Fotografia 78 Bit MIDI Andrà tutto bene 883 MIDI Bella vera 883 MIDI Chiuditi nel cesso 883 MIDI Ci sono anch'io 883 MIDI Come deve andare 883 MIDI Come mai 883 MIDI Con dentro me 883 MIDI Con un deca 883 MIDI Cumuli 883 MIDI Dimmi perchè 883 MIDI Eccoti 883 MIDI Favola semplice 883 MIDI Finalmente tu 883 MIDI Gli anni 883 MIDI Grazie mille 883 MIDI Il mondo insieme a te 883 MIDI Innamorare tanto 883 MIDI Io ci sarò 883 MIDI Jolly blue 883 MIDI La regina del Celebrità 883 MIDI La regola dell'amico 883 MIDI Lasciati toccare 883 MIDI Medley 883 MIDI Nella notte 883 MIDI Nessun Rimpianto 883 MIDI Nient'altro che noi 883 MIDI Non mi arrendo 883 MIDI Non ti passa più 883 MIDI Quello che capita 883 MIDI Rotta per casa di Dio 883 MIDI Se tornerai 883 MIDI Sei un mito 883 MIDI Senza averti qui 883 MIDI Siamo al centro del mondo 883 MIDI Tenendomi 883 MIDI Ti sento vivere 883 MIDI 1/145 www.cristommasi.com Tieni il tempo 883 MIDI Tutto ciò che ho 883 MIDI Un giorno cosi 883 MIDI Uno in pi 883 MIDI Aereoplano 883 & Caterina MIDI L'ultimo bicchiere 883 & Nikki MIDI Dark is the night A-Ha MIDI Stay on these roads A-Ha MIDI Take on me A-Ha MIDI Desafinado A.C. -

Lista 16 APRILE 2020
Fabio e Mirko - Basi Karaoke Lista aggiornata al 16 Aprile 2020 TITOLO ARTISTA (COGNOME-NOME) WAVES OF LUV (IN ALTO MARE) 2 BLACK SANDRA 360 GRADI WHAT'S UP 4 NO BLONDES AEREOPLANO 883 - CATERINA BELLA VERA 883 (PEZZALI MAX) CHIUDITI NEL CESSO 883 (PEZZALI MAX) COME DEVE ANDARE 883 (PEZZALI MAX) COME MAI 883 (PEZZALI MAX) CON UN DECA 883 (PEZZALI MAX) CREDI 883 (PEZZALI MAX) ECCOTI 883 (PEZZALI MAX) FAI COME TI PARE 883 (PEZZALI MAX) FINALMENTE TU 883 (PEZZALI MAX) GLI ANNI 883 (PEZZALI MAX) GRAZIE MILLE 883 (PEZZALI MAX) HANNO UCCISO L'UOMO RAGNO- 883 (PEZZALI MAX) I COWBOY NON MOLLANO 883 (PEZZALI MAX) IL MIO SECONDO TEMPO 883 (PEZZALI MAX) IL MONDO INSIEME A TE 883 (PEZZALI MAX) IO CI SARO' (PEZZALI 883) 883 (PEZZALI MAX) L'ULTIMO BICCHIERE 883 (PEZZALI MAX) L'UNIVERSO TRANNE NOI 883 (PEZZALI MAX) LA DURA LEGGE DEL GOL 883 (PEZZALI MAX) LA LUNGA ESTATE CALDISSIMA 883 (PEZZALI MAX) LA REGINA DEL CELEBRITA' 883 (PEZZALI MAX) LA REGOLA DELL'AMICO 883 (PEZZALI MAX) ME LA CAVERO' 883 (PEZZALI MAX) MEDLEY 883 883 (PEZZALI MAX) MEZZO PIENO O MEZZO VUOTO 883 (PEZZALI MAX) NESSUN RIMPIANTO 883 (PEZZALI MAX) NIENT'ALTRO CHE NOI 883 (PEZZALI MAX) NON MI ARRENDO 883 (PEZZALI MAX) NORD SUD OVEST EST 883 (PEZZALI MAX) QUELLO CHE CAPITA 883 (PEZZALI MAX) QUELLO CHE COMUNEMENTE NOI 883 (PEZZALI MAX) RAGAZZO INADEGUATO 883 (PEZZALI MAX) RITORNERO' 883 (PEZZALI MAX) ROTTA PER CASA DI DIO 883 (PEZZALI MAX) SE TORNERAI 883 (PEZZALI MAX) SEI FANTASTICA 883 (PEZZALI MAX) SEI UN MITO 883 (PEZZALI MAX) SENZA AVERTI QUI 883 (PEZZALI MAX) SOPRAVVIVEREI 883 (PEZZALI MAX) TIENI IL TEMPO 883 (PEZZALI MAX) TORNO SUBITO 883 (PEZZALI MAX) UNA CANZONE D'AMORE 883 (PEZZALI MAX) VIAGGIO AL CENTRO DEL MONDO 883 (PEZZALI MAX) WELCOME TO MAIAMI 883 (PEZZALI MAX) SEMPRE NOI 883 (PEZZALI MAX) - J-AX AMAPOLA (BEGUINE) AA.VV. -

MEDIANE Media in Europe for Diversity Inclusiveness
MEDIANE Media in Europe for Diversity Inclusiveness 28-30 April 2014 MEDIANE THEMATIC ENCOUNTER Biographies Split City Museum – 28.4.14 Hotel Park – 29. – 30.4.14 SPLIT - Croatia www.coe.int/mediane / #mediane_hr Facebook/Groups – Journalistsfordiversity PARTICIPANTS MASENJKA BACIC Journalist Cenzura Plus - stav.cenzura.hr CENZURA PLUS is a non-profit, civil society organization from Split, Croatia, that promotes human rights, media freedoms and works on the development of civil society, through methods of independent media (TV) production, out-institutional education and public advocacy, with the aim of building modern, democratic and fair society in Croatia. Cenzura Plus was established in 2003., by a group of human-rights activists and it arise from history and experience of producing the first independent TV show that explored limitation of media freedoms in post-war Croatia, since mid 1990es. Since then Cenzura Plus remains unique and recognized in Croatia and in the Region of Western Balkans for its non-profit TV production, of one 1-hour long TV show weekly, that deals with broader range of human rights issues, democratization and civil society status in Croatia. In previous 5 years it has developed numerous activities and today is one of the leading civil society organizations in its lines of work in the south part of the country. It is located in Split, second town by its size in Croatia, on the Adriatic coast. CENZURA PLUS est une organisation à but non lucratif de la société civile de Split, en Croatie. Sa mission est de promouvoir les droits de l’Homme, la liberté des médias et le développement de la société civile au travers d’une production d’émissions télévisuelles et radiophoniques indépendantes, d’une éducation non-formelle et d’une sensibilisation du public à ces sujets, dans le but de construire une société moderne, juste et démocratique en Croatie. -

Repertorio United Feeling PIANO BAR/Dinner Music a Chi Fausto Leali
Repertorio United Feeling PIANO BAR/Dinner Music A chi Fausto Leali Abbraciami Julio Iglesias All at once Whitney Hoiuston Almaz Randy Crawford All of me John Legend A modo mio Gigi Finizio Amore da Favola Giorgia Ancora de Crecenzo Anima mia Cugini di Campagna A puro dolor son by Four Assenza di te Laura Pausini Balliamo Fred Bongusto Besame mucho Brivido Felino Celentano/Mina Buonasera Signorina Come Prima Canzone Gianni Morandi Carless Whisper Wham Champagne Pepino di Capri Che sara José Feliciano Chiara Nino D´angelo Che angelo sei Albano e Romina Power Ciao Ciao Bambina Ci sara Albano Carisi Come prima Toni Dallara Come vorrei Ricchi e Poveri Como una Flor Selena Corazon Partido Alejandro Sanz Cumme Murolo mia Martini Diamante Zucchero Diana Senza Luce Dik Dik Drupi cosi piccola Easy lionel Ritchi L´emozione non ha voce A. Celentano I Belong to you Eros Ramazzotti / Anastacia Feelings Felicitá Albano e Romina Power Firenze santa maria novela Pupo Su di noi Pupo Forse si forse no Pupo Gente di Mare Tozzi & Raf Hello Lionel Ritchie Hero Mariah Carey How deep is your love Il Mondo Jimmy Fontana I like Chapain Il Tempo se ne va A. Celentano Soli A.Celentano Imagine John Lennon Thats amore Dean Martin We found love Rihanna Read all about it Emelie Sandé Inevitabile Giorgia e Ramazzotti Io Vagabondo Io Vorrei gigi d´alessio I will always love you Whitney Houston Just the way you are Billy Joel Killing me softly Fugees L `Italiano Toto Cotugno Lady Laura Roberto Carlos La Luce buona delle stelle Eros Ramazzotti La mia storia fra le dita Gianluca Grignani La solitudine Laura Pausini Laurora Eros Ramazzotti Lauretta mia Liberta Albano e Romina Lo dejaria todo Chayanne L´unica donna Alan Sorrenti Mala Femmina jerry Vale Malinconia Ricardo Fogli Maledetta Primavera loretta goggi Mi rubi l´anima Laura Pausini My Way Frank Sinatra Na cosa Grande per me Non sucedera piu A. -

Catalogo Completo Mp3 - 22/09/2021
M-LIVE CATALOGO COMPLETO MP3 - 22/09/2021 ZIBALDONE POPOLARE - ERAVAMO IN CENTOMILA RICOMINCIAMO ALEANDRO BALDI - ALEX BRITTI 2 VOL.2 FASCINO AEROSMITH FRANCESCA ALOTTA 7000 CAFFÈ FIORI 2 EIVISSA ABBA I DON'T WANT TO MISS A NON AMARMI BACIAMI E PORTAMI A CHIQUITITA FRESCO (LATIN THING BALLARE OH LA LA LA ALEJANDRO SANZ FT. DOES YOUR MOTHER REGGAETON) AFTERHOURS BENE COSÌ 24KGOLDN FT. IANN DIOR FUMO NEGLI OCCHI ZUCCHERO KNOW BIANCA BUONA FORTUNA MOOD UN ZOMBIE A LA FERNANDO (SMOKE GETS IN YOUR CINQUE PETALI DI ROSA AIELLO INTEMPERIE HONEY HONEY EYES) FORTUNA CHE NON ERA ORA 4 I HAVE A DREAM GELOSIA ALESSANDRA AMOROSO NIENTE VIENIMI A BALLARE 4 NON BLONDES KNOWING ME KNOWING GRAZIE PREGO SCUSI AMA CHI TI VUOL BENE L'ATTIMO PER SEMPRE HAI BUCATO LA MIA VITA AKA 7EVEN AMORE PURO WHAT'S UP YOU LA VASCA LOCA MONEY MONEY MONEY I PASSI CHE FACCIAMO ARRIVI TU LA VITA SOGNATA MI MANCHI TAKE A CHANCE ON ME IL FORESTIERO BELLEZZA INCANTO LO ZINGARO FELICE A MILLE PAROLE THE NAME OF THE GAME IL RAGAZZO DELLA VIA NOSTALGIA MILANO A-HA THE WINNER TAKES IT ALL GLUCK AL CORLEY BELLISSIMO OGGI SONO IO STAY ON THESE ROADS WATERLOO IL RAGAZZO DELLA VIA SQUARE ROOMS CIAO PERCHÈ TAKE ON ME ABBA - MERYL STREEP GLUCK (LIVE) AL JARREAU COMUNQUE ANDARE PIOVE IL TANGACCIO DIFENDIMI PER SEMPRE AA.VV. MAMMA MIA AFTER ALL QUANTO TI AMO IL TEMPO SE NE VA È ORA DI TE (FIND A WAY) 'O SOLE MIO SOS AL STEWART SE NON CI SEI IL TUO BACIO È COME UN È VERO CHE VUOI AUTUMN LEAVES (PIANO AC/DC YEAR OF THE CAT SENZA CHIEDERCI DI PIÙ JAZZ) ROCK RESTARE SOLO CON TE BACK IN BLACK -

Karaoke Italiano
KARAOKE ITALIANO ACHILLE LAURO - 1969 ACHILLE LAURO - ME NE FREGO SANREMO 2020 ADAMO - AL DI LA ADRIANO CELENTANO - LA CUMBIA CHE CAMBIA ADRIANO CALENTANO - PRISENCOLINENSINAINCIUSOL ADRIANO CELENTANO - 24 000 BACI ADRIANO CELENTANO - ANCORA VIVO ADRIANO CELENTANO - AZZURRO ADRIANO CELENTANO - BISOGNA FARE QUALCOSA ADRIANO CELENTANO - CAREZZA IN UN PUGNO ADRIANO CELENTANO - IL MONDO IN MI7 ADRIANO CELENTANO - IL RAGAZZO DELLA VIA GLUCK ADRIANO CELENTANO - IL TUO BACIO E´ COME UN ROCK ADRIANO CELENTANO - L'EMOZIONE NON HA VOCE ADRIANO CELENTANO - MARÌ MARÌ ADRIANO CELENTANO - MEDLEY ADRIANO CELENTANO - NON ESISTE L'AMOR ADRIANO CELENTANO - NON TI ACCORGEVI DI ME ADRIANO CELENTANO - PREGHERÓ Vers. Bachata ADRIANO CELENTANO - PRIMA PAGINA www.discoykaraokemovil.es TLF.; 615497575 1 KARAOKE ITALIANO ADRIANO CELENTANO - SEI RIMASTA SOLA ADRIANO CELENTANO - SI E SPENTO IL SOLE CON CORI ADRIANO CELENTANO - SOLI ADRIANO CELENTANO - SOTTO LE LENZUOLA ADRIANO CELENTANO - SUSANNA ADRIANO CELENTANO - SVALUTATION ADRIANO CELENTANO - TI PENSO E CAMBIA IL MONDO ADRIANO CELENTANO - TI PRENDERÒ ADRIANO CELENTANO - UN'ALBERO DI 30 PIANI ADRIANO CELENTANO - VIVO PER LEI AL BANO & ROMINA - CI SARA AL BANO & ROMINA - RACCOGLI L-ATTIMO AL BANO & ROMINA - SEMPRE SEMPRE AL BANO & ROMINA POWER - FELICITÁ AL BANO´& ROMINA POWER - LIBERTÀ AL RANGONE - L´EMIGRANTE ALBERTO URSO - ACCANTO A TE ALBERTO URSO - IL SOLE AD EST ALBERTO URSO - LA MIA RIVOLUZIONE ALESSANDRA AMOROSO - NIENTE www.discoykaraokemovil.es TLF.; 615497575 2 KARAOKE ITALIANO ALESSANDRA AMOROSO - -

Trgovci Hrvatskim Kožama Polemike O Nacionalnoj Povijesti Xx
Tomislav Jonjić TRGOVCI HRVATSKIM KOŽAMA POLEMIKE O NACIONALNOJ POVIJESTI XX. STOLJEĆA BIBLIOTEKA HRVATSKA POLITIČKA BIBLIOTEKA Knjiga 7. Tomislav Jonjić TRGOVCI HRVATSKIM KOŽAMA POLEMIKE O NACIONALNOJ POVIJESTI XX. STOLJEĆA Urednik Zvonimir Ujević Nakladnik Naklada Trpimir Zagreb Mini-print-logo d.o.o. Varaždin Za nakladnika Mariana Jonjić Priprema i tisak Mini-print-logo d.o.o. Varaždin © Tomislav Jonjić, Zagreb, 2021. CIP – Katalogizacija u publikaciji. CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice pod brojem 001087490. ISBN 978-953-8220-05-0 978-953-7573-57-7 Tomislav Jonjić TRGOVCI HRVATSKIM KOŽAMA POLEMIKE O NACIONALNOJ POVIJESTI XX. STOLJEĆA Zagreb, 2021. TOMISLAVU, NIKOLI, FILIPU I MIHOVILU SADRŽAJ PROSLOV ........................................................................................................ 9 „Dalmatinstvo“ je instrument rastakanja Hrvatske ...................................... 17 Površno o Šufflayu i ustaškom pokretu .......................................................... 45 Duhovna i politička previranja u Hrvatskoj 1935.–1945. ............................. 54 Meštrovićeva jugoslavenska saga .................................................................. 77 Srebroljubci i partijsko zlato .......................................................................... 83 Drugdje je Rod, tamo treba skakati! .............................................................. 89 Od predrasuda do krivih zaključaka ............................................................ 120 Bartulinov